La squadra olimpica dei rifugiati? Un'idea razzista e colonialista
di Andrea Coccia
Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, a Rio 2016 parteciperà una squadra di atleti rifugiati. Ma dietro al gesto che si vorrebbe politico, c'è soltanto ipocrisia e retaggi neocoloniali
I vertici del CIO lo avevano annunciato a marzo: per la prima volta nella storia delle Olimpiadi moderne, tra le squadre partecipanti ci sarebbe stata anche una squadra speciale che avrebbe gareggiato sotto la benedizione del CIO stesso, che avrebbe sfilato sotto i colori della bandiera olimpica e che sarebbe stata formata da dieci atleti selezionati dal comitato centrale del CIO. I criteri? Abbastanza semplici: “sporting level, official refugee status verified by the United Nations, and personal situation and background”, recita il comunicato ufficiale.
Una buona notizia? Per il mondo colorato in cui saltellano fischiettando le nostre pallide coscienze sicuramente sì, proprio un'ottima notizia. Ma per il mondo reale, quello che sta fuori dai cinque cerchi olimpici, invece, è soltanto un'operazione di comunicazione, una mossa ipocrita e consolatoria.
In tutto dieci persone. Sei uomini e quattro donne. Due siriani, tre sudsudanesi, due congolesi e un etiope. Tutti con un vissuto dietro le spalle da far accapponare la pelle. Dalla storia epica della giovane nuotatrice siriana che ha fatto commuovere tutti noi — con la sorella si è messa a spingere a nuoto la barca in panne con la quale stavano attraversando l'Egeo per raggiungere la Grecia, salvando la vita a tutto l'equipaggio — fino alle storie dei judoki congolesi, picchiati e seviziati in patria dai loro allenatori.
Tutto molto bello e commovente: una squadra olimpica di atleti senza patria di donne e uomini in fuga da guerre, violenze, persecuzioni razziali, religiose, politiche, carestie, disastri naturali e crisi economiche. Ehm, no. O meglio, non proprio. Perché in pratica è un po' meno bello.
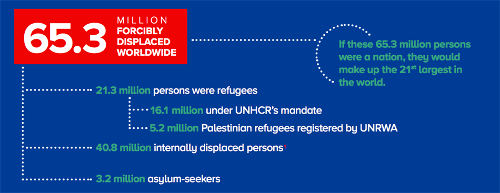
È un po' meno bello perché ad essere molto meno bella di così è la nostra visione del diritto d'asilo, una visione e una legislazione che discrimina la disperazione a seconda della sua matrice.
Sei disperato perché fuggi da una guerra? Ok. Papà Occidente ti può aiutare. Sei disperato perché le multinazionali della pesca d'alto mare hanno impoverito i luoghi dove pescavi da generazioni o il tuo terreno ormai è sabbia del deserto e non puoi più coltivare nemmeno una patata? Mi dispiace molto, ma sono cazzi tuoi.
Insomma, questa squadra olimpica dei rifugiati è un'operazione tipicamente occidentale, che come al solito ci semplifica il mondo; lo normalizza di fronte alla nostra coscienza cinematografica; ci tranquillizza e ci fa andare a letto un po' più convinti del solito che, in fondo, noi siamo delle brave persone.
In realtà non è così. Questa è un'operazione che butta tutto in favoletta senza accorgersi — o facendo finta di non accorgersi — di replicare la solita vecchia dinamica coloniale: l'élite bianca e ricca che, grazie al suo buon cuore e alla sua magnanimità, dà la possibilità a dei poveretti sfortunati di gareggiare “come tutti gli altri”.
Ma queste dieci persone non sono come tutti gli altri. E non soltanto nei loro paesi d'origine. Non sono come tutti gli altri soprattutto nei paesi dove sono stati accolti, paesi in cui cresce la xenofobia e la stigmatizzazione dello straniero e del diverso.
Insomma, l'idea di mettere insieme una squadra olimpica di rifugiati somiglia a quella che sta alla base della scommessa dei due ricchissimi fratelli Duke di Una poltrona per due, che decidono di dare a Eddie Murphy aka Billy Ray Valentine, la possibilità di dimostrare che anche un senzatetto nero può fare il broker e che può tranquillamente fare il lavoro del loro protetto, Winthorpe.
Peccato che al cinema ci vivano solo le nostre coscienze e che la realtà sia decisamente più prosaica. Perché se il mondo reale fosse come Una poltrona per due, uno di questi atleti vincerebbe di certo una medaglia d'oro e, altrettanto di certo, una volta salito sul gradino più alto del podio olimpico, sotto la paternalistica bandiera del Comitato che vibra nel vento, invece di mostrarci via cavo i loro occhi lucidi di poveri a cui è stata data la possibilità di sognare, si girerebbero dall'altra parte. Esattamente come facciamo noi ogni giorno, quando decine di migranti — che abbiano o meno diritto a chiedere l'asilo — che non sanno nuotare affogano nel Mediterraneo. Senza nessuna bandiera, senza nessun inno.
































Add comment