La politica economica al tempo della crisi
Da Keynes alla controrivoluzione monetarista e (non) ritorno
di Amedeo Di Maio e Ugo Marani
Il lavoro che segue costituisce uno stralcio dell’Introduzione al volume Politiche economiche e crisi internazionale. Uno sguardo sull’Europa, curato da Amedeo Di Maio e Ugo Marani con contributi di Paul De Grauwe, Amedeo Di Maio, Pasquale Foresti, Guglielmo Forges Davanzati, Nicolò Giangrande, Ernesto Longobardi, Antonio Lopes, Ugo Marani e Antonio Pedone, per i tipi di L’Asino d’Oro edizioni, di prossima pubblicazione
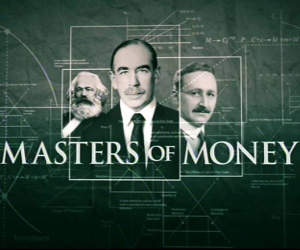 «Torneranno» disse.
«Torneranno» disse.
«La vergogna ha la memoria debole».
(Gabriel Garcia Márquez, La mala ora)
Il volume che introduciamo ha come oggetto la politica economica al tempo della crisi; un oggetto inteso in un duplice senso. Da un lato esso ambisce a un esercizio di statica comparata: quanto è cambiato, e in che cosa l’indirizzo di policy, rispetto alla fase che ha preceduto lo scatenarsi della tempesta, prima finanziaria e poi reale. Dall’altro si pone l’interrogativo se le nuove impostazioni si stiano palesando efficaci nel gestire le nuove problematiche che esse affrontano. Con riferimento al primo quesito, il mutamento nell’indirizzo di policy, nelle sue linee generali ed estremamente qui sintetizzate, può essere compreso solo se si risale ai cambiamenti, striscianti e graduali, dei riferimenti teorici, iniziati negli anni settanta del secolo scorso. Infatti, è proprio in quegli anni che la politica economica si allontana progressivamente dalla impostazione cosiddetta keynesiana, ma comunque fortemente viziata dai forti retaggi della teoria liberista tradizionale.
Il primo effetto è consistito nell’abbandono definitivo dei tentativi di armonizzare la politica monetaria con quella fiscale, nel senso di rendere compatibile la stabilizzazione dei tassi di interesse con le politiche fiscali volte a combattere la disoccupazione che si manifesta nel breve periodo, l’unico che val la pena di considerare quando si cita Keynes al pari modo di un qualsiasi motto attribuito a Oscar Wilde. E’ da qui che inizia la cosiddetta controrivoluzione monetarista, con le sue aspettative adattive, dapprima, razionali successivamente e che ben completano il ritrovato laissez faire desiderato da F.A. Hayek. Con le aspettative adattive si teorizza una capacità di previsione degli accadimenti economici futuri da parte degli individui, basata sulle esperienze osservate in passato sui medesimi accadimenti, mentre le aspettative razionali arrivano ad assumere che gli individui siano capaci di utilizzare sempre e comunque in modo efficiente le informazioni che posseggono, fino a individuare strategie che possono annullare gli effetti di politiche economiche attesi e desiderati dal decisore politico.
Si celebra, dall’inizio degli anni Ottanta, l’avvento dell’era della Grande Moderazione, così chiamata perché caratterizzata da basse oscillazioni nel prodotto nazionale e nel tasso di inflazione. Un sostantivo tuttavia impregnato di giudizi di valore che celano, al loro interno, apparenti e molteplici trionfi dell’ortodossia: assenza di conflitti sociali, trascurabili perturbazioni sui prezzi e sulla crescita, un armamentario di politica economica agghindato a scienza. Tutto ciò consente, e non solo agli assertori estremi della scuola delle aspettative razionali, di considerare “superato” il ciclo economico quale dato caratterizzante delle economie di mercato e di dover inaugurare una fase in cui le regole costituiscano il dato saliente della politica economica.
L’impoverimento epistemologico della scienza economica, dovuto all’estremismo nell’assunzione di dette aspettative, è ben e sarcasticamente evidenziato dal famoso politologo Robert Keohane[1]. Egli cita Misura per misura di Shakespeare, proprio per mettere in luce la irragionevolezza di quanti sostengono l’efficace ausilio della teoria delle aspettative razionali alla comprensione della complessità dei processi decisionali umani, individuali e collettivi:
L’uomo, l’arrogante uomo,
investito d’una piccola breve autorità,
più ignorante di ciò
di cui dovrebbe essere più certo,
la sua essenza cristallina,
come irosa bertuccia
dà in smorfie così grottesche al cospetto dell’eccelso cielo,
che gli angeli ne piangono.
W. Shakespeare, Misura per misura, Atto 2, scena 2
È quindi da ritenere che Shakespeare non sia molto gradito ai teorici delle aspettative razionali, anche se la critica all’ipotesi di mercati efficienti, soprattutto quelli finanziari, era da considerare anche solo osservando l’alta variabilità dei prezzi delle azioni; variabilità presente in tempi ancora lontani da quelli della crisi attuale. Soprattutto questa variabilità nei prezzi avrebbe dovuto escludere il suo riflettersi nei mutamenti dei fondamentali dell’economia. Non a caso G. Akerlof e R. Shiller sostengono che “ogni grande crollo del mercato azionario appare inesplicabile… A cambiare è stato praticamente sempre il mercato azionario; i fondamentali invece no” (G. Akerlof – R. Shiller, Animal Spirits, Princeton University Press, 2009). Comunque, gli anni della Grande Moderazione, iniziati a metà degli anni ’80, sono per definizione caratterizzati da bassa variabilità, sia dei tassi di inflazione, sia di quelli di crescita e ciò può aver fatto credere alla giustezza di politiche economiche minimali, soprattutto dal lato della politica fiscale. La politica della Grande Moderazione è tuttavia come la strada maestra, sembra la più sicura ma è anche quella della mediocrità, se conveniamo con Thomas Mann, perché caparbiamente ignora percorsi alternativi.
Con riferimento al secondo quesito che ci siam posti in questo libro, osserviamo che i teorici e gli uomini di affari si sono illusi di vivere il tempo della grande armonia tra mercati reali e finanziari. Ma quei teorici e quegli uomini di affari inconsapevolmente confermavano l’analisi di H. Minsky, secondo la quale nell’epoca della calma piatta, com’è stata quella, almeno apparente, della Grande Moderazione, aumenta la disponibilità all’indebitamento e a concedere credito. Tutto ciò si traduce nella “tendenza a trasformare una situazione fiorente in un boom di investimento speculativo” (H. Minsky, Potrebbe ripetersi?, Einaudi, 1984).
L’evidenza della crisi, con la dimostrazione della sua imprevedibilità, pur puntuale, non demolisce la fede degli economisti ortodossi nella mano invisibile e la politica monetaria da arte si fa scienza. Scienza in un contesto monobiettivo, l’inflation targeting, che dovrebbe annullare l’incertezza nella politica monetaria. Questa assenza di incertezza consente la deregolamentazione dei mercati finanziari. Deregolamentazione che dovrebbe condurre all’efficienza e vincolare il debito pubblico a tendere verso condizioni ritenute di sostenibilità.
In questa logica di mano invisibile o, se si vuole usare un termine più da iniziati, di equilibrio economico generale, in tutti i mercati indicati si determinano prezzi di equilibrio e quindi anche nel mercato n-esimo (così si definisce il mercato residuale, non esplicitamente considerato e che non può che adattarsi agli equilibri che si sono determinati altrove), ormai quello del lavoro, se non fosse per le sue rigidità derivanti da decisioni esterne ai mercati e/o da eredità normative che resistono al necessario cambiamento. Ne discende che solo la deregolamentazione anche del mercato del lavoro può garantire la stabilizzazione del sistema economico complessivo.
Tutto ciò sembra confermare l’intuizione di K. Polanyi consistente nell’azione politica non semplicemente volta a garantire la supremazia del mercato, ma addirittura essere la causa determinante dell’esistenza del libero mercato, fino a quando, con altrettanta spontaneità la politica ritiene debba porre limiti al laissez faire per via di tensioni sociali causate da quel libero operare del mercato. Il paradosso, è la tesi di Polanyi, è che quei limiti posti al mercato non garantiscono la tenuta della democrazia e conseguentemente, diremmo oggi, la tutela dei diritti umani (K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi 1974). Seguendo la tesi di Polanyi, la fase attuale sembra essere quella della supremazia del mercato. Ciò significa che l’agire dei governi viene regolato da indicatori, reali o pseudo tali, determinati nei vari mercati. Ne discende inevitabilmente la domanda retorica se crescita e piena occupazione possano realmente dipendere da elementi quali la regola di Taylor, attraverso la quale le banche centrali ritengono di poter fissare quel tasso di interesse nominale coincidente con quello reale che conduce all’equilibrio macroeconomico di pieno impiego. Così come crescita e pieno impiego dipenderebbero dal raggiungimento di un prefissato tasso di indebitamento pubblico che influenza lo spread positivo rispetto al più basso dei tassi di interesse sul debito pubblico registrabile in un data comunità sovranazionale. Ancora, ritenere che la globalizzazione conduca a quel tanto desiderato pieno impiego anche attraverso la negoziazione internazionale dei capitali (cross border) con l’ausilio delle banche. Infine, come già richiamato, quella crescita e quel pieno impiego desiderati non possono che raggiungersi attraverso la deregolamentazione del mercato del lavoro. Deregolamentazione che quando diverrà completa, allora non potrà che far intendere la disoccupazione come evento liberamente e volontariamente scelto dal lavoratore e così definitivamente rimuovere le cause che hanno contribuito a sperimentare trent’anni gloriosi.
Non è nostra intenzione discutere in questo testo della crisi e delle sue cause e neanche di quanto il modello economico principale di riferimento le abbia spianato la strada. La nostra domanda è se quel modello sia stato abbandonato o se è possibile prevedere che lo sia nel breve periodo.
Immediatamente dopo l’inizio della crisi economica, è sembrato diffondersi tra gli economisti un we are all keynesians now. È stata tuttavia una illusione di breve periodo perché, fatta eccezione di alcune politiche economiche statunitensi, governi nazionali e istituzioni internazionali sono rientrati nell’ovile di quel che credono il buon pastore e che paradossalmente alcuni di loro definiscono post keynesiano.
Seppur non rientra negli intenti della nostra trattazione, sarebbe interessante analizzare come la Keynesian Resurgence sia durata per così breve tempo [2] o come il ritorno al modello dei principi di austerità e di finanza sana sia stato compatibile con la mole di finanziamenti destinati ai salvataggi bancari (vedi U.Marani, La schizofrenia europea tra salvataggi bancari e austerità fiscale) , se non ricorrendo alle caratteristiche di ideologia che l’economia ortodossa ha progressivamente assunto, e dunque
“… alle convinzioni e alle idee dei gruppi dominanti, le quali sembrano congiungersi così strettamente agli interessi di una data situazione da escludere qualunque comprensione dei fatti che potrebbero minacciare il loro potere. Con il termine ideologia noi intendiamo così affermare che, in talune condizioni, i fattori inconsci di certi gruppi nascondono lo stato reale della società a sé e agli altri e pertanto esercitano su di esso una funzione conservatrice” (Karl Mannheim, Ideologia e utopia, 1929. Ed. It. Il Mulino, 1957)
Eppure sarebbe bastato riflettere per comprendere come l’economia si muovesse, prima della crisi, su di un sentiero precario costellato da un numero crescente di trilemmi, di una situazione, cioè, in cui, per l’esistenza di fenomeni quasi sempre di carattere internazionale, risulta impossibile, al medesimo tempo, perseguire un obiettivo, utilizzare uno strumento, mantenendo inalterati i vincoli che si pongono all’agire della politica economica. Immiserimento della politica economica e liberalizzazione-deregolamentazione finanziaria sono, dunque, le principali cause efficienti dello scoppio della crisi.
E subito dopo una mutazione che non molti analisti hanno percepito nella sua portata e che ha innescato uno spettro di misure di politica monetaria crescente nel corso del tempo e profondamente diverso da quanto era avvenuto sino al decennio precedente, un pacchetto di misure che tende ad omologarsi verso quelle che sono definite oramai come le “Misure Non Convenzionali di Politica Monetaria”. Un atteggiamento, per certi versi, opposto a quello del periodo pre-crisi: prima l’ambizione era quella di rendere la politica monetaria sempre meno un’Arte, la discrezionalità, e sempre più una Scienza, connotabile per Regole sempre valide. Si trattava del tentativo ambizioso di far assurgere il banchiere centrale a policy maker unico, delegato ad un simile ruolo di responsabilità per la sua indipendenza dalla politica e per l’affermazione di automatismi di comportamento che avrebbero potuto evitare l’arbitrio proprio di atteggiamenti discrezionali. La crisi finanziaria del 2007 arresta questo tentativo di scientificizzare la politica monetaria: la crisi è di una tale gravità che i tradizionali strumenti di intervento si rivelano inefficaci e le banche centrali devono avventurarsi in unchartered waters nelle quali l’armamentario di regole e di automatismi vantati nel passato servono ora a ben poco. Per i banchieri centrali è stato necessario abbandonare la “scienza” e ritornare all’incerto mondo, più che dell’arte, di far da sé in forme inedite e preoccupanti per i principi di accountability e di delega esplicita dei poteri in un ordinamento democratico.
In contemporanea un ruolo sempre più debole della politica fiscale, a riprova della caducità delle confessioni di credo keynesiano che più sopra abbiamo richiamato. Pare indubbio che si siano verificati due evidenti rovesciamenti nell’impostazione teorica e nelle conseguenti politiche fiscale.
Il primo riguarda il ruolo dello stato sociale, un tempo generalmente considerato come valido strumento per evitare, o quantomeno ritardare, l’inevitabile, per alcuni, crollo del capitalismo. Ora, al contrario, lo stato sociale considerato un ostacolo alla crescita economica e quindi alla potenziale diffusione di più alti livelli generalizzati di benessere.
Il secondo rovesciamento riguarda il ribaltamento tra obiettivi e strumenti della politica fiscale. Un tempo, ad esempio, gli obiettivi erano la piena occupazione, la stabilità dei prezzi, l’equilibrio con il resto del mondo, la crescita e per conseguirli si utilizzavano gli strumenti individuati nella spesa pubblica, nella tassazione, nel debito pubblico. Oggi, gli obiettivi sono il pareggio di bilancio, l’assenza di indebitamento pubblico e gli strumenti per conseguirli sono le regole da immettere nel mercato del lavoro, la deregolamentazione nel mercato dei capitali, le privatizzazioni delle imprese pubbliche, ecc.
Questi rovesciamenti sono il frutto di assecondamenti al mercato, à la Polanyi, soprattutto da parte di partiti un tempo naturali sostenitori di politiche keynesiane. I riferimenti più evidenti sono al blairismo sorto nel Regno Unito e all’ordoliberismo tedesco diffusosi attraverso i trattati dell’Unione Europea.
In definitiva, le brevi note che fanno da introduzione ai saggi contenuti nel volume ambiscono a fornire una chiave di lettura della politica economica al tempo (prima e dopo) della crisi: così come essa aveva tentato di ridimensionarsi a pochi precetti universalmente riconosciuti prima, espunti di qualunque riferimenti all’instabilità e alla carenza di domanda effettiva, ha poi cercato di dotarsi di un corredo di strumenti variegato, non convenzionale e immemore di quanto solo poco tempo prima i suoi fautori andavano predicando. Un armamentario caratterizzato da alcune continuità preoccupanti per chi identifica la politica economica in una funzione di utilità sociale in cui il policy maker esprime e rende conto di una gerarchia rivelata di obiettivi finali e delle proprie scelte.
Il primo elemento di preoccupazione è costituito dalla pervicace assenza del ricorso esplicito all’uso della politica fiscale nella sua accezione di strumento anti-ciclico e di compensazione alla carenza della domanda aggregata privata. Non che il finanziamento monetario della spesa sia venuto meno: ne è testimone l’ammontare destinato al finanziamento del Quantitative Easing e degli ingenti trasferimenti di liquidità a istituzioni finanziarie e imprese private. Quel che si ambisce a modellare è una politica fiscale, spesso camuffata di “misura non convenzionale di politica monetaria” senza delegare alla “politica” il compito di doversene occupare.
La rinuncia alla politica fiscale, nella sua accezione più piena e responsabile, si accompagna a una seconda continuità della politica economica all’indomani della crisi: l’assenza di mandati espliciti sulle funzioni, sugli strumenti, sulla discrezionalità che, specie i banchieri centrali, si auto attribuiscono. Non c’è che dire per un’ideologia che i principi di discrezionalità keynesiana aveva equiparato all’arbitrarietà, al sopruso sul mercato.
Come per una rivincita della storia l’arbitrio ritorna: saranno le istituzioni a dover decidere quanto possa protrarsi, poiché: “Designs of purely arbitrary nature cannot be expected to last long.”(Kenzo Tange).


