La parabola dell’economia politica dalla scienza all’ideologia
di Ascanio Bernardeschi
 I. La fisiocrazia
I. La fisiocrazia
Questa prima parte è dedicata ai fisiocratici e in particolar modo al Tableau économique di Quesnay
Anche se già nell’antichità non mancarono riflessioni sull’attività umana volta a produrre e riprodurre la società, come per esempio con Aristotele che tese a distinguere fra economia e crematistica, quest’ultima intesa come accumulazione di ricchezza misurata in denaro e considerata attività innaturale, Marx aveva ben chiaro che si può parlare di economia politica come scienza autonoma solo con l’affermarsi del modo di produzione capitalistico. Nelle società precedenti, infatti, la riproduzione sociale era governata da regole fisse, i rapporti di dipendenza erano rapporti personali stabiliti per legge o per volontà divina e inderogabili e lo sfruttamento era ben visibile, senza la necessità di dotarsi di una scienza:
“La corvée si misura col tempo, proprio come il lavoro produttore di merci, ma ogni servo della gleba sa che quel che egli aliena al servizio del suo padrone è una quantità determinata della sua forza-lavoro personale. La decima che si deve fornire al prete è più evidente della benedizione del prete” [1].
Con l’affermarsi del modo capitalistico di produzione, i rapporti sociali perdono la caratterizzazione di rapporti di dipendenza personale, gli uomini sono tutti liberi e uguali di fronte alla legge e occorre la scienza per indagare come, sotto la superficie di rapporti paritari nel mercato, sussista la dipendenza di carattere economico e lo sfruttamento. Per questo motivo gli albori dell’economia politica coincidono con l’affermazione di questo modo di produzione.
La fisiocrazia, dalle parole greche physis (natura) e krátos (potere), fece la sua comparsa in Francia nella seconda metà del XVIII secolo, cioè alle soglie della rivoluzione francese. L’agricoltura era ancora in quel paese il settore trainante ed era, per l’epoca, estremamente produttiva, tanto che le esportazioni di prodotti agricoli erano molto fiorenti. Anche in campo agricolo si andavano affermando le imprese a conduzione capitalistica e gli investimenti di capitale per migliorare la produttività. Gli esponenti di questa scuola, non potrebbe essere altrimenti, avevano una visione che risentiva di questa struttura economica e individuarono nel lavoro agricolo (e in quello delle miniere a esso assimilabile), l’unico lavoro produttivo. Un evidente limite che occorrerà attendere lo sviluppo dell’industria per veder superare.
I fisiocratici sostenevano che lo Stato non dovesse intervenire nelle questioni economiche. Per esempio non avrebbe dovuto imporre tasse troppo elevate ai produttori agricoli in modo da consentire loro di essere competitivi negli scambi con l’estero, né intervenire con dazi per contenere le importazioni. Il sistema di libero mercato avrebbe di più motivato la modernizzazione delle aziende.
I fisiocratici si opponevano pertanto alla corrente del mercantilismo, comparsa alcuni decenni prima, la quale invece sosteneva che la ricchezza di un paese si identifica con la quantità di moneta posseduta (oro e argento), e quindi esortava ad attuare una politica protezionistica da parte dello stato nei confronti delle importazioni e incentivante nei confronti delle esportazioni.
L’esponente più importante della scuola fisiocratica fu François Quesnay (1694-1774), che fu anche medico di corte di Luigi XV.
Il più importante contributo di Quesnay alla teoria economica fu il famoso Tableau économique. Il medico francese prese spunto dal sistema di circolazione del sangue per schematizzare il movimento circolare dell’economia il cui fine ultimo sarebbe quello di creare un surplus da investire per aumentare la produttività della terra.
Le classi sociali venivano distinte sulla base della funzione che svolgevano all’interno di questo ciclo. La classe produttiva era costituita da coloro che investivano il capitale produttivo (i proprietari fondiari) e dai lavoratori agricoli che, coltivando la terra, creano la ricchezza. Gli artigiani e i lavoratori alle loro dipendenze, che trasformavano i beni provenienti dall’agricoltura, costituivano la classe sterile, al pari dei mercanti.
Politicamente, questa teoria si traduceva in un assist ai proprietari terrieri, i quali erano considerati gli unici a cui fosse appropriato attribuire diritti politici.
La circolazione avveniva in modo tale da permettere la riproduzione sociale. Quesnay, in uno schema semplificato dalla consapevole soppressione del capitale fisso, che pure aveva presente, suppose che gli agricoltori producessero merci per un importo indicato, a titolo esemplificativo, in cinque miliardi e pagassero ai proprietari la rendita dei terreni per un valore, sempre a titolo esemplificativo, di due miliardi. La classe sterile trasformava il prodotto per un pari importo di due miliardi. Anche il denaro esistente ammontava a due miliardi ed era inizialmente in possesso degli agricoltori. A partire da questi dati la circolazione sarebbe avvenuta nel modo seguente:
- gli agricoltori pagavano ai proprietari la rendita annua che ammonta a due miliardi;
- i proprietari spendevano un miliardo per acquistare dagli agricoltori i loro alimenti per l’anno successivo e l’altro miliardo per acquistare dalla classe sterile i beni e servizi da essi offerti, sempre per l’anno successivo;
- la classe sterile acquistava dagli agricoltori gli alimenti per la sussistenza per il valore di un miliardo e le materie prime da impiegare per la produzione dell’anno successivo, sempre per un miliardo;
- gli agricoltori acquistavano presso la classe sterile beni e servizi da utilizzare l’anno successivo per un miliardo.
Schema del Tableau Économique di Quesnay
(Riproduzione totale 5 miliardi)
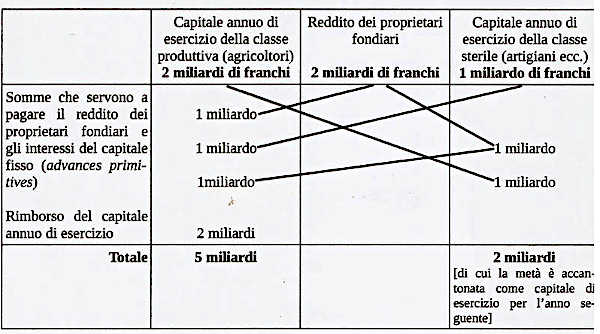
Alla fine del ciclo i tre miliardi che gli agricoltori pagavano rispettivamente per la rendita (due miliardi) e per i beni e servizi produttivi (un miliardo) ritornavano loro sotto forma di acquisti dei proprietari (un miliardo) e della classe sterile (un miliardo per le sussistenze e uno per le materie prime). Quindi ritornavano in possesso del denaro speso. Avendo prodotto beni per cinque miliardi e venduto beni per tre, rimanevano loro due miliardi di prodotti che servivano per reintegrare i beni da essi consumati sia per la sussistenza sia per la produzione (sementi, concimi naturali, bestiame ecc.), in modo che fossero in grado l’anno successivo di produrre ancora cinque miliardi di beni.
La classe sterile vendeva due miliardi di beni da essa trasformati (uno ai contadini e uno ai proprietari) e ne acquistava due dai contadini per il proprio consumo e per le materie prime. Ugualmente, con l’acquisto delle materie prime era in condizione di ripetere la produzione di due miliardi di beni e servizi.
I proprietari avevano ricevuto i due miliardi di rendita che spendevano presso gli agricoltori (un miliardo) e la classe sterile (un miliardo) essendo così in grado di soddisfare i propri consumi.
In questo modo erano soddisfatte le condizioni perché la riproduzione si ripetesse sulla medesima scala l’anno successivo.
Bastavano pochissime complicazioni per costruire uno schema in cui la riproduzione avvenisse su scala allargata: presupporre una quantità di prodotto superiore a parità di prodotto impiegato; prevedere che il surplus andasse ai proprietari terrieri per i miglioramenti fondiari o agli agricoltori per dotarsi di strumenti (fossero pure i cavalli al posto dei buoi) in grado di incrementare la produttività e/o per dotarsi di maggiori sementi ecc. Alternativamente sarebbe bastato supporre che i due miliardi di consumi dei proprietari fondiari fossero almeno in parte consumi produttivi, cioè investimenti in sementi, animali da lavoro, concimi, terreni, per estendere la scala della produzione.
Marx, come vedremo, apprezzerà molto questo schema e ne trarrà ispirazione per elaborare i suoi schemi di riproduzione.
Il pregiudizio che esista una sola classe produttiva derivava dal fatto che gli agricoltori, anticipando due miliardi di sementi ecc., producevano cinque miliardi di mezzi di sussistenza e materie prime. Anche includendo il miliardo di beni acquistati dalla classe sterile (che Quesnay qui trascura) si ha un’eccedenza di due miliardi di prodotto. Si noti che ciò corrisponde alla rendita pagata ai proprietari e che quindi nella riproduzione semplice il cosiddetto “sovrappiù” è l’esclusiva fonte di reddito dei possessori delle condizioni della produzione, come in effetti sarà con il plusvalore di Marx. Ma questo lo noterà Marx e non Quesnay. La classe sterile invece non fa che riprodurre le proprie condizioni di produzione e consumo (due miliardi), senza nessuna eccedenza. Per Quesnay essi si limitano a “trasformare” in manufatti equivalenti due miliardi di prodotti agricoli. In tal modo il prodotto sociale lordo consiste solo nei cinque miliardi provenienti dall’agricoltura.
Si noti che l’origine del profitto era ignota e alcuni seguaci di questa scuola lo avrebbero spiegato come conseguenza di una maggiorazione dei prezzi dei prodotti trasformati. Quindi era auspicabile la massima concorrenza per contenere queste maggiorazioni che avrebbero gravato sulla classe produttiva.
Ideologicamente i fisiocratici anticiparono la visione liberale del sistema economico, auspicando che lo Stato limitasse il più possibile il suo intervento nell’economia la quale doveva procedere secondo “leggi di natura”. Vedremo che questa concezione del modo di produzione come dato naturale e non risultato di precisi rapporti sociali storicamente determinati in ciascuna epoca sarà una sorta di “peccato originale” che l’economia politica deve scontare anche al giorno d’oggi.
Pur con questi limiti, siamo di fronte a importanti acquisizioni teoriche: la definizione delle classi sociali sulla base del loro ruolo nel sistema economico, il concetto di prodotto nazionale, le condizioni della produzione date dalla sussistenza dei lavoratori e dai mezzi di produzione che a loro volta devono essere (ri)prodotti, la circolazione monetaria come momento della circolazione complessiva delle merci, il rapporto fra consumo produttivo e consumo finale, l’idea della circolarità del processo riproduttivo sociale, la possibilità di schematizzare questo processo secondo un modello formale.
“Tutto questo in un tableau che in realtà non consiste che di cinque linee che uniscono sei punti di partenza e di ritorno [...] Fu indubbiamente una delle idee più geniali di cui si sia resa finora colpevole l’economia politica” [2].
Si comprende quindi come per Marx, contrariamente all’opinione prevalente, fosse Quesnay e non lo scozzese Adam Smith, il padre dell’economia politica.
Note:
[1] K. Marx, Il Capitale, Libro I, Editori Riuniti, 1989, p. 109.
[2] K. Marx, Storia delle teorie economiche, Vol. I, Giulio Einaudi editore, 1954, p. 92
* * * *
II. Adam Smith
In questo capitolo l’analisi del pensiero del “padre dell’economia politica”
La scuola classica di economia politica, i cui principali esponenti furono Adam Smith e David Ricardo, era presa in seria considerazione da Marx, nonostante la criticasse a fondo, operando una profonda rottura nei suoi confronti. Diversamente avvenne per i confusionari economisti apologeti del capitalismo che Marx denominò economisti volgari.
Considerato dai più il padre dell’economia politica, Adam Smith (1723-1790) fu un intellettuale di vasta cultura e uno dei maggiori esponenti della filosofia scozzese del Settecento. Già docente di Filosofia morale all’Università di Glasgow, di cui molti anni dopo diventerà rettore, in un soggiorno parigino ebbe contatti con la fisiocrazia francese. Il suo primo importante scritto, la Teoria dei sentimenti morali [1], fu notevolmente influenzato dalla filosofia di David Hume, uno dei maggiori teorici del liberalismo. Gli uomini, sostenne Smith in questo lavoro, giudicano le proprie azioni con gli occhi degli altri e quindi conta più la loro accettabilità da parte della società che non la loro adeguatezza al benessere individuale. I conflitti fra i diversi interessi e pulsioni vengono allevati dal sentimento della simpatia, pervenendo così a una sorta di loro armonizzazione. Questa filosofia fu anche sullo sfondo della sua maggiore opera, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni [2].
A differenza di Quesnay, Smith aveva di fronte la rivoluzione industriale e l’innegabile progresso che essa portava con sé, assieme alla divergenza degli interessi dei capitalisti rispetto a quelli dei lavoratori. Tuttavia egli, aderendo alla visione ottimistica degli illuministi, riteneva che al di là del contrasto immediato, si pervenisse a una armonizzazione, se si esamina la società nel suo insieme, e a un vantaggio per tutte le classi. Le trasformazioni produttive e sociali intervenute gli consentirono di padroneggiare meglio le caratteristiche di un sistema economico che si apprestava ad avviare la cosiddetta rivoluzione industriale: al centro della sua teoria introdusse il ruolo dell’industria nell’economia, una visione della società molto più articolata e nuovi concetti che non potevano emergere in società prevalentemente agricole e con rapporti di produzione ancora in larga parte di tipo feudale. Fra questi, è rilevante il riconoscimento che il sovrappiù prodotto non va esclusivamente alla rendita ma, soprattutto, ai profitti. Tuttavia, rileva Marx, Smith fa anche un passo indietro rispetto ai fisiocratici: non riconosce che nella determinazione di questo sovrappiù, o prodotto netto, occorre detrarre i reintegri degli elementi consumati nella produzione.
In ogni caso, è significativo che Smith avesse chiaro che la società borghese si regge sulla classe dei lavoratori produttivi i quali sostengono se stessi e tutte le altre classi. I capitalisti che hanno anticipato le sussistenze dei lavoratori si appropriano del prodotto netto, tenendosene per sé una parte, il profitto, da destinare prevalentemente all’accumulazione del capitale.
La rimanente parte del sovrappiù va a retribuire i proprietari fondiari, sotto forma di rendita, e i lavoratori improduttivi, cioè quei lavoratori dedicati ai lavori servili alle dipendenze dei capitalisti oppure i dipendenti pubblici. A questo proposito Smith ritenne che il progresso economico fosse tanto maggiore quanto minore fosse il lavoro improduttivo. Vedremo che Marx fornirà una definizione di lavoro improduttivo più funzionale all’analisi dell’accumulazione capitalistica.
Anche Smith, ideologicamente, era un liberale e auspicava che l’intervento dello Stato in economia fosse ridotto al minimo, in quanto la “mano invisibile” del mercato avrebbe garantito l’allocazione ottimale delle risorse e la distribuzione ottimale del prodotto. L’azione congiunta di domanda e offerta e la capacità (perfino l’egoismo) degli operatori economici, alla ricerca del loro massimo tornaconto, era in grado di assicurare questo risultato. È questa la filosofia che ancora oggi prevale in ambito accademico, anche se spesso sostenuta da strumentazioni matematiche tanto sofisticate quanto fondate su presupposti poco aderenti alla realtà.
Dalla fisiocrazia ereditò sia l’individuazione delle tre classi principali – lavoratori (produttivi e “sterili”), capitalisti e proprietari fondiari – che l’idea del carattere naturale del capitalismo e della sua attitudine a ottimizzare i risultati dell’attività produttiva e del commercio, ritenendo nocivo l’intervento dello Stato che avrebbe alterato questo carattere. Lo Stato avrebbe dovuto invece limitarsi ad assicurare alcuni servizi utili alla società, quali la difesa, la sicurezza, l’istruzione. Quest’ultima in particolare era considerata necessaria per contrastare l’abbrutimento dei lavoratori, costretti – come vedremo – a specializzarsi in attività monotone e non creative. Anche in tema di commercio internazionale recepì la critica dei fisiocratici ai mercantilisti. Questi ultimi raccomandavano misure protezionistiche delle attività produttive nazionali. Smith a tal fine abbozzò anche una teoria, poi sviluppata da Ricardo, sui vantaggi del commercio internazionale secondo cui è sbagliato destinare lavoro e risorse per produrre cose che all’estero sono prodotte con meno dispendio. Se queste risorse vengono invece impiegate per produzioni da noi meno dispendiose che all’estero, ogni nazione si può specializzare nelle produzioni più vantaggiose e si assicurerà ciò che non produce attraverso lo scambio, con un vantaggio per tutti.
Sempre dai fisiocratici recepì la nozione di salario medio, denominato “prezzo naturale” del lavoro (si noti ancora il termine “naturale” che ci ossessionerà fino ai nostri giorni!).
Il debito verso i fisiocratici era tale che Marx ebbe ad asserire: “ha semplicemente raccolto l’eredità dei fisiocratici, catalogando e specificando con maggior rigore i singoli articoli dell’inventario, ma riuscendo appena a seguire e interpretare il movimento nel suo complesso con l’esattezza che si trova nel Tableau”[3].
Su un punto invece vi fu una cesura fra i fisiocratici e Smith, cioè sull’idea che la ricchezza provenisse solo dal lavoro nell’agricoltura. L’economista scozzese individuò invece nel lavoro, anche in quello di trasformazione, la fonte del valore e della ricchezza. Tutte le merci di diverse qualità che vengono portate al mercato sono fra di loro scambiabili e commensurabili per il fatto che hanno un valore e questo valore è dato dal lavoro in esse contenuto. Ma mentre fra produttori singoli lo scambio può avvenire in base alla quantità di lavoro da ciascuno prestato per produrre la propria merce, le cose si complicano con la produzione capitalistica in cui più lavoratori operano alle dipendenze di un imprenditore e il prezzo di vendita deve contenere anche la retribuzione del capitale (e della rendita immobiliare se si opera in immobili, siano essi terreni o fabbricati, presi in affitto).
Il tentativo di superare questo scoglio portò Smith a ipotizzare due diverse definizioni di valore fra di loro inconciliabili. Fu Marx e notare una sorta di oscillazione [4] fra queste due impostazioni. Il valore è concepito sia come quantità di lavoro contenuto nelle merci che come “lavoro comandato”, cioè la quantità di merce necessario all’acquisto di una determinata quantità di lavoro (quindi l’equivalente del salario). Il che è la stessa cosa che dire la quantità di lavoro che può essere acquistata con un’equivalente quantità di merce. Rilevò anche la contraddittorietà fra le due impostazioni. Infatti il “valore del lavoro” [5], inteso come salario, varia come il valore di ogni qualsiasi altra merce ma viene preso da Smith come misura del valore. Sarà Ricardo il primo a comprendere il vero nodo che sta alla base di questa formulazione contraddittoria e a tentare una soluzione e successivamente Marx ne propose un’altra introducendo il concetto di forza-lavoro distinto da quello di lavoro e affermando di considerare questa distinzione la sua più importante scoperta. La confusione fra lavoro e forza-lavoro, fra plusvalore e profitto, fra valore di una merce e retribuzione dei soggetti che concorrono a portarla sul mercato conduce infatti a contraddizioni insanabili.
Tuttavia – riconobbe Marx – nel ricercare la natura del plusvalore, dell’eccedenza che alimenta i profitti, il luminare scozzese “si attiene” sempre alla prima impostazione, quella del lavoro contenuto.
Uno dei contributi più importanti della Ricchezza delle nazioni , invece, fu l’analisi della divisione del lavoro, e come questa incidesse nello sviluppo delle forze produttive. Per comprenderne l’importanza si noti che tale opera inizia proprio con questa analisi [6]. Smith rilevò che mettendo insieme più lavoratori, ciascuno specializzato in una fase ben distinta della produzione di una merce, si aumentava la produttività. Fece l’esempio della fabbrica di spilli, della quale contò innumerevoli fasi lavorative. Facendo fare a ogni lavoratore solo un singolo passaggio si ottenevano due effetti positivi. Si poteva utilizzare manodopera meno qualificata, perché è più facile apprendere l’esecuzione di un’unica operazione, ottenendo quindi un risparmio. Inoltre, effettuando un solo passaggio l’operaio non era costretto a spendere tempi morti per passare da una fase all’altra e da un utensile all’altro. In più finiva per diventare abilissimo e veloce in quella semplice mansione. In tal modo si possono raggiungere livelli di produttività assai superiori rispetto a quelli del pur bravissimo artigiano che realizza interamente il prodotto finale e quindi passa da una fase all’altra della lavorazione e cambia a più riprese gli utensili da usare, interrompe il ritmo del lavoro ecc. I vantaggi della divisione del lavoro favoriscono la trasformazione dell’artigiano in operaio salariato.
Con lo sviluppo della divisione del lavoro si sarebbe accresciuta enormemente la produttività e ci sarebbe stato un innegabile progresso umano. Nonostante ciò Smith non mancò di rilevare alcuni suoi aspetti negativi, la diversità fra l’artigiano che produce i propri manufatti dall’inizio alla fine, con amore, e l’operaio, capace di svolgere una sola fase e che subisce una sorta di abbrutimento.
L’altra gamba su cui si regge il progresso economico era per Smith l’accumulazione di capitale e la concorrenza. La ricerca da parte dei singoli del proprio tornaconto e l’impulso ad accumulare ricchezza erano visti come la molla che innestava un beneficio per tutti. Accumulando capitale si assumevano nuovi lavoratori. Inoltre un’azienda più grande permette una maggiore divisione del lavoro e quindi una produzione di beni meno costosa. Questa identificazione del bene della singola impresa col bene comune sarà un buon assist per la (contro)rivoluzione marginalista. Come pure l’esaltazione della concorrenza che consentiva ai capitali di rivolgersi verso le produzioni di cui c’è domanda e, tendendo a saturarla, manteneva che i prezzi di tali merci attorno al loro valore “naturale”. Il mercato, come una “mano invisibile” avrebbe condotto l’imprenditore a promuovere il bene comune, al di là delle sue intenzioni. È nota la frase contenuta nella Ricchezza delle nazioni: “Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura dei propri interessi” [7].
La Ricchezza delle nazioni, fu indubbiamente la prima opera di grande spessore dell’economia politica, sia pure all’interno dei limiti di una visione borghese delle cose. Per esempio, il capitale era concepito (e lo sarà fino al giorno d’oggi!) come un elemento materiale, i beni e la ricchezza spesi per impiegare i lavoratori produttivi. Tale impiego consente di produrre un reddito e quindi l’accumulazione capitalistica. Manca qualsiasi altra qualificazione di carattere storico e sociale, perdendo così di vista la specificità dei rapporti sociali di produzione capitalistici.
Se il contributo maggiore di Smith fu senza dubbio l’intuizione che il lavoro fosse la sola fonte della ricchezza, egli, dopo aver osservato che in condizioni di autonomia il lavoratore vive del solo suo lavoro e che la ricchezza che ne ottiene ha un valore proporzionale al lavoro necessario per la sua produzione, notò che lo sviluppo delle capacità produttive avveniva invece con la trasformazione del lavoro autonomo in lavoro salariato, cioè quando i lavoratori non si appropriavano più direttamente del proprio lavoro e anche il capitalista e il rentier dovevano essere ricompensati per il loro ruolo economico. Pertanto, la legge del valore proporzionale al lavoro cessava di funzionare nella maniera pura e i prezzi dovranno contenere anche una quota di profitto dell’imprenditore e di rendita del possidente. Coincidevano quindi con la somma delle retribuzioni di tre fattori: il lavoro (salari), il capitale (profitti) e la terra (rendita) impiegati nella produzione.
“In ogni società il prezzo di ogni merce si risolve, in definitiva, nell’una o nell’altra di queste parti o in tutte e tre, mentre in ogni società progredita, tutti e tre entrano, poco o tanto, come componenti del prezzo della maggior parte delle merci” [8].
In maniera ancora più equivocabile: “Salario, profitto e rendita sono le tre fonti originarie di ogni reddito, così come di ogni valore di scambio” [9]. Con ciò Smith non esplicitò fino in fondo la distinzione fra la creazione (o “fonte”) del valore, da attribuire esclusivamente al lavoro, e la sua ripartizione fra le varie categorie di reddito, il che ha aperto una breccia su cui si sono inseriti i marginalisti per giustificare il profitto, per essi dovuto alla produttività del capitale. Marx, attingendo ai dogmi religiosi, avrebbe in seguito sarcasticamente denominato “formula trinitaria” questa determinazione del valore come somma dei tre tipi di reddito, cui oppose i meccanismi con cui il il plusvalore, interamente dovuto al pluslavoro, viene fra le varie classi e all’interno di esse. Infatti, limitarsi a constatare che i prezzi si risolvono nelle tre componenti dei redditi significa rimanere alla superficie fenomenica delle cose, al pari di quanto fa tutt’oggi l’economia borghese.
Note:
[1] A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, ed. Rizzoli, 1995.
[2] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, Newton Compton editori, 1995.
[3] K. Marx, Storia delle Teorie Economiche, Vol. I, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1954, p. 93.
[4] Ivi pp. 130 e segg.
[5] Sarebbe corretto dire valore della forza-lavoro ma prima di Marx la distinzione fondamentale fra lavoro e forza-lavoro era ignota.
[6] A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit, pp. 66-77.
[7] Ivi, p. 73.
[8] Ivi, p. 97.
[9] Ivi p. 98, grassetto mio.
* * * *
III. David Ricardo
L’altro grande classico, David Ricardo (1772-1823), rispetto ai due economisti precedenti, si trova di fronte a un capitalismo ancora più sviluppato. A differenza di Smith, non ha titoli accademici ma, quale uomo di affari, conosce a fondo le attività e i meccanismi economici della società.
L’altro grande classico, David Ricardo (1772-1823), rispetto ai due economisti precedenti, si trova di fronte a un capitalismo ancora più sviluppato. A differenza di Smith, non ha titoli accademici ma, quale uomo di affari, conosce a fondo le attività e i meccanismi economici della società. Inoltre possiede spiccate capacità di logica e di astrazione. La sua opera maggiore, Principi di economia politica e tassazione, costituisce un ulteriore avanzamento dell’economia politica.
La teoria del valore
La teoria del valore, si rifà a Adam Smith. Il valore di una merce dipende dalla quantità di lavoro necessario a produrla. Tuttavia egli cerca di sviluppare ulteriormente questo concetto per dimostrarne la validità anche in presenza di rapporti capitalistici, di lavoro salariato e di proprietà privata della terra e del capitale.
La sua opinione, certamente più corretta, è che il valore di una merce, da lui chiamato “prezzo naturale” (ancora naturale! I borghesi non riescono a distaccarsi dalla naturalizzazione del modo di produzione capitalistico), non dipende, in termini relativi, cioè in confronto ai valori di tutte le altre merci, dal compenso che viene dato ai fattori produttivi (salario, profitto e rendita) ma dal lavoro contenuto nella merce stessa, mentre il profitto è un’entità residuale: ciò che rimane al capitalista dopo aver pagato i fattori produttivi. Quindi ai salari maggiori corrispondono minori profitti e viceversa. Date le condizioni tecniche della produzione, il saggio del profitto e quello di salario stanno fra di loro in una relazione inversa. Si profila pertanto l’idea di interessi antagonistici fra le classi sociali e viene criticato il concetto di “lavoro comandato” di Smith.
Spiegare infatti il valore delle merci con la quantità di lavoro che queste merci possono “comandare” fa dipendere il valore anche dall’entità dei salari. In questo modo però, secondo Ricardo, si misurerebbe il valore di una merce con il valore di un’altra, il salario, anch’esso variabile, per cui ci si troverebbe in assenza di una “misura invariabile del valore”. Egli si impegna pertanto a definire questa misura in modo che rimanga stabile al variare dei prezzi relativi e della distribuzione fra salari e profitti; un impegno che verrà ripreso in epoca relativamente recente dalla scuola neoricardiana il cui padre spirituale unanimemente riconosciuto è Piero Sraffa con la sua artificiosa “merce tipo”. Ricardo trova una soluzione al problema, semplicistica ma efficace come schematizzazione, prendendo come elemento invariabile il valore del grano nell’ipotesi del tutto teorica che esso non dipenda dagli altri prezzi in quanto prodotto esclusivamente da grano (sementi) e da lavoratori che si alimentano con il solo grano. Un’altra soluzione empirica, più concreta ma approssimativa, viene individuata nel valore dell’oro, reso stabile dall’ingente presenza di riserve auree: l’oscillante produzione nel periodo preso in considerazione non incide significativamente a modificarne il valore.
E se i capitalisti, a fronte di un aumento dei salari, decidessero di aumentare di pari importo i prezzi? Semplificando un po’ il discorso, tralasciando alcuni aspetti ben presenti in Ricardo, si può dire che i prezzi delle merci aumenterebbero tutti nella stessa proporzione e che quindi i prezzi relativi rimarrebbero immutati. Se i prezzi relativi non cambiano, il capitalista non può scaricare un aumento di salari sul prezzo del proprio prodotto. È inevitabile quindi che a fronte dell’aumento dei salari, diminuiscano i profitti. Vedremo che l’odierna scuola monetarista dirà l’esatto contrario.
Ricardo attribuisce la variazione del valore relativo delle merci unicamente al variare delle difficoltà di produzione, siano esse dovute a fenomeni naturali o tecnologici, e conseguentemente alla variazione della quantità di lavoro necessaria alla loro produzione.
Altro problema affrontato è la differenza di produttività fra i diversi tipi di lavoro, per esempio più o meno specializzato, che inevitabilmente si traducono in apporti diversi di valore. Ricardo lo risolve mettendo in relazione produttività e salari: se un lavoratore specializzato percepisce un salario doppio rispetto a quello di un lavoratore comune, allora si suppone che anche il suo contributo alla creazione di valore sia doppio.
Dato il crescente peso dei mezzi di produzione, si preoccupa anche di precisare che il valore è dato non solo dal lavoro diretto impiegato nella produzione del bene finale, ma anche da quello indiretto, contenuto, incorporato, nei mezzi di produzione, che egli denomina “capitale fisso”, confondendo la distinzione fra beni capitali durevoli (per esempio gli utensili, gli immobili, le macchine ecc.) che non si consumano in un solo ciclo produttivo e beni che si consumano interamente in un ciclo produttivo (per esempio le materie prime, l’energia, le materie ausiliarie ecc.) che si consumano interamente e devono essere per intero reintegrate alla fine del processo) con l’altra distinzione fra lavoro diretto e lavoro cristallizzato nei mezzi di produzione, siano essi durevoli o meno.
Questa sua visione di un conflitto fra interessi dei lavoratori e dei capitalisti e l’individuazione nel solo lavoro della fonte del valore, è ovviamente un argomento utilizzabile a favore della classe lavoratrice. Un esempio è la corrente dei cosiddetti socialisti ricardiani della prima metà dell’800 la quale rivendicava che tutto il prodotto dovesse andare ai lavoratori, visto che tutto il valore scaturisce dal lavoro.
Ricardo si occupa infine del caso in cui le differenti merci vengano prodotte con combinazioni diverse (in proporzioni variabili) di lavoro diretto e lavoro indiretto (“beni capitale”), e in cui tali beni abbiano durata diversa fra di loro. Per esempio, la materia prima viene consumata per intero nel ciclo produttivo in cui la si trasforma, mentre le macchine e gli edifici vengono consumati gradualmente in più cicli produttivi. In tal caso, per spiegare i prezzi relativi non è sufficiente considerare la quantità di lavoro necessario in quanto, ipotizzando un saggio del profitto che la concorrenza rende uniforme, i prezzi delle merci prodotte con più lavoro indiretto di maggiore durata, dovranno retribuire capitali per più periodi, determinando prezzi relativi che si discostano dal valore. In questo caso, ammette Ricardo, la variazione dei salari reali incide sui prezzi relativi. Per esempio, se aumentano i salari aumenteranno anche i prezzi relativi delle merci prodotte con meno intensità di capitale fisso e viceversa diminuiranno i prezzi delle altre. Marx darà una diversa soluzione a questo problema, con la trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Una soluzione ancora diversa la darà Sraffa con la sua merce tipo, un paniere di merce il cui prezzo non varia al variare della distribuzione.
Nonostante gli importanti passi avanti compiuti rispetto a Smith, la teoria di Ricardo presenta ancora diversi punti deboli.
Abbiamo già visto la naturalizzazione del capitalismo che lo porta a identificare, come Smith, il capitale con i mezzi di produzione e di sussistenza dei lavoratori. Viene presa in considerazione cioè solo la composizione materiale del capitale e non il suo carattere sociale. Per Ricardo esso è costituito dal fondo salari – i mezzi di sussistenza dei lavoratori – e dai mezzi di produzione. Ma gli strumenti di produzione, le materie prime e le sussistenze dei lavoratori sono indispensabili in tutti i modi di produzione e in tutti i tipi di società. Considerare solo l’aspetto “naturale” del capitale, identificando processo lavorativo col processo di valorizzazione del capitale, si perdono tutte le specificità storicamente e socialmente determinate del modo di produzione capitalistico. Per la stessa ragione si identificano i due aspetti del lavoro: il lavoro concreto, necessario in ogni società per produrre beni utili, con il lavoro astratto che produce valore.
Altra aporia è l’identificazione del lavoro con la forza-lavoro. In questo modo, quando Ricardo tratta del valore della forza-lavoro parla di “valore del lavoro”, espressione evidentemente tautologica: se il valore dipende dal solo lavoro, parlare di valore del lavoro è come dire valore del valore!
Egli sostiene inoltre che il valore del lavoro dipende dal prezzo dei mezzi di sussistenza e che più è alto questo prezzo più è alto il valore del lavoro e quindi il valore delle merci prodotte dal lavoro. Quindi i “prezzi naturali” delle merci dipendono dai prezzi naturali delle merci. Siamo di nuovo, come in Smith in un ragionamento circolare. Per questo entrambi i grandi classici si fermano all’apparenza dei prezzi di produzione, spiegati nella sfera della circolazione. In Marx invece si spiegherà il profitto come una forma trasformata, mistificata e feticizzata del plusvalore.
Abbiamo visto anche che la sua definizione di capitale fisso è impropria. Distinguendo solamente fra capitale fisso e circolante, e prendendo in considerazione solo il tempo per il quale si deve capitalizzare il profitto, e non il ruolo di ogni componente del capitale nel processo produttivo (i mezzi di produzione il cui valore viene semplicemente trasferito nel valore del prodotto e la forza-lavoro che invece, oltre a riprodurre il proprio valore produce un plusvalore), si rimane alle forme che il capitale assume nella sola circolazione.
Infine un grosso limite della teoria di Ricardo è quello di pervenire comunque, nonostante i tentativi di correggere Smith, a prezzi difformi dalle quantità di lavoro contenute senza indicare come si possano calcolare tali prezzi a partire da tali quantità di lavoro. Ciò darà il pretesto agli economisti successivi di smontare il suo costrutto e produrre altre teorie, disinnescando così il suo pericolo sociale, dato dall’idea di un sistema distributivo antagonistico fra le classi.
La distribuzione del valore fra salari, profitti e rendita
I salari, come ogni altra merce che abbia una domanda e un’offerta, hanno un “prezzo naturale” e un prezzo di mercato che possono temporaneamente essere diversi fra loro ma che comunque tendenzialmente si avvicinano. Secondo la “legge ferrea dei salari” Il prezzo naturale del lavoro è quello “che mette in grado la classe dei lavoratori, nel complesso, di sussistere e di riprodursi senza aumenti né diminuzioni”, cioè il salario deve tendere a quel livello che consente al lavoratore di mantenere la propria famiglia. Pertanto, gli aumenti e le riduzioni del salario dipendono dalle variazioni dei prezzi relativi delle merci facenti parte dei mezzi di sussistenza dei lavoratori (viveri, beni di prima necessità ecc.).
I salari di mercato non possono discostarsi a lungo dal loro livello naturale. Nel caso fossero superiori il lavoratore potrebbe permettersi dei consumi al di sopra del livello di sussistenza e verrebbe indotto a procreare più figli. Con i figli che crescono aumenterebbe la consistenza della classe dei lavoratori e con ciò l’offerta di braccia da lavoro, con conseguente riduzione del prezzo di mercato (salario). Al contrario, se i salari di mercato fossero al di sotto del livello naturale, non consentirebbero al lavoratore di riprodursi normalmente e diminuirebbe così l’offerta di lavoro e con ciò si avrebbe un aumento del salario.
Farebbe eccezione alla legge ferrea il caso in cui l’economia crescesse più consistentemente rispetto all’aumento demografico: complessivamente la società spende per il mantenimento dei lavoratori il cosiddetto “fondo salari”. Dividendo tale fondo per il numero dei lavoratori si ottiene il salario del singolo lavoratore. Tale fondo tende a crescere alla stessa velocità dell’economia e, quindi, dell’accumulazione di capitale. Se quindi l’economia e il fondo salari crescono più velocemente della popolazione, potrebbe verificarsi il mantenimento della popolazione sopra i livelli di sussistenza per un lungo periodo.
Si noti che questa teoria fa dipendere il salario da fattori “naturali”, come quelli demografici piuttosto che legati ai rapporti di forza fra le classi.
Abbiamo già visto la spiegazione dei profitto come sottrazione dal valore del prodotto del lavoro. Ricardo cerca di spiegare anche come si forma la rendita. Essa costituisce la parte del prodotto che spetta al proprietario della terra per aver messo a disposizione il suo potenziale produttivo. Le terre, però, non sono tutte ugualmente fertili. Quindi, se la rendita fosse uniforme i capitalisti che mettessero a cultura la terra più fertile godrebbero di maggiori profitti, ma in questo caso aumenterebbe la domanda di terra più fertile, facendo crescere la rispettiva rendita. Il meccanismo del mercato e di livellamento dei profitti farà sì che si determini un saggio del profitto uniforme e rendite differenziate in relazione alle differenze di fertilità, con una rendita pari a zero nel terreno “marginale”, cioè l’ultimo e meno fertile terreno messo a coltura.
Al proprietario fondiario spetterebbe invece, oltre alla rendita differenziale in relazione diretta con la fertilità del suolo, la rendita assoluta qualora la scarsità di terra induca a mettere a coltura anche quelle meno fertili.
A mano a mano che la popolazione aumenta, e con essa l’esigenza di prodotti agricoli, viene coltivata terra meno fertile che acquisisce il diritto a una rendita. Di conseguenza, aumenta la rendita delle terre più fertili e il saggio del profitto, per differenza, diminuisce. Quindi non è il prezzo dei prodotti agricoli a essere influenzato dalla rendita, ma i profitti. Siamo di fronte a un altro aspetto della distribuzione che vede antagonismo fra le classi sociali, questa volta fra profitti e rendita.

La figura 1 illustra il movimento inverso di rendita (tratto verde delle colonne) e profitti (tratto giallo) qualora si mettano a coltura terre nuove meno fertili. Il valore dei salari (tratto rosso) uguale a due milioni di quintali di grano, supponendo che ogni tipo di terreno necessiti della stessa manodopera. Si ipotizzano sei tipologie di terreni. Nella prima si possono produrre sette milioni di quintali di grano, nella seconda sei, e così via a diminuire fino alla sesta in cui se ne possono produrre due. Qualora il fabbisogno di grano fosse pari a ventidue milioni di quintali (grafico A) è sufficiente mettere a coltura le quattro tipologie di terreni maggiormente fertili (7+6+5+4=22). La quarta, cosiddetta marginale, in cui la produzione è pari al valore dei salari e dei profitti, non riceve rendita. Il profitto, che deve essere uniforme, è pari a due milioni di quintali di grano per ogni tipologia di terreno. Mettendo a coltura i terreni meno fertili, si avrebbero profitti inferiori alla media. Pertanto quei terreni restano incolti.
Se invece il fabbisogno di grano salisse a venticinque milioni di quintali, sarebbe necessario mettere a coltura anche la quinta tipologia, con cui produrre i tre quintali aggiuntivi (grafico B), che diventerebbe quella marginale che non dà diritto a una rendita. La quarta conseguentemente percepirebbe la rendita differenziale di uno, la terza di due e così via. Rispetto al caso precedente, è aumentata di una unità la rendita in tutti i terreni non marginali e quindi, a parità di salari, diminuiscono i profitti. Nel terzo caso (grafico C), dovendo produrre venticinque quintali, è necessario, per ottenere i due quintali aggiuntivi, mettere a coltura anche l’ultima tipologia di terreno che, in quanto marginale, non percepirebbe rendita. La quinta darebbe diritto alla rendita di uno, e così via. In questo modo, però, i margini di profitto si azzerano. Questa è la ragione per cui Ricardo, supponendo che il fabbisogno di prodotti agricoli cresca all’aumentare della popolazione e/o del benessere, prevede una tendenza al declino del saggio del profitto in agricoltura. Dato che i capitali si spostano verso i settori che offrono maggiori profitti, nel mercato si verifica una tendenza a eguagliare i saggi del profitto fra i vari rami produttivi. Per questo Ricardo conclude che il saggio del profitto determinato in agricoltura coinciderà con quello generale, che diminuirà insieme a quello del comparto agricolo. Si avrà così una tendenza storica alla diminuzione del saggio del profitto.
Anche tale diminuzione è un tema che Marx affronterà, individuando cause ben diverse da quella qui descritta.
Nonostante il riconoscimento dell’esistenza di interessi contrapposti fra le classi, permane il carattere liberale di fondo di questa teoria. Per quanto riguarda i salari, per esempio, Ricardo ritiene che debbano essere rimessi alla “libera concorrenza del mercato” senza “controlli e interferenze” da parte dello Stato.
Poiché la terra marginale, l’ultima, meno fertile, messa a coltura, non riscuote rendita, il prezzo “naturale” si determina in questo contesto e quindi include solo profitti e salari, due spicchi di una medesima torta. Occorre tenere presente che Ricardo nella voce “profitti” include anche gli interessi per il capitale a prestito.
La teoria dei vantaggi comparati
Un altro contributo di Ricardo alla teoria economica è la cosiddetta “teoria dei vantaggi comparati” in materia di commercio internazionale, secondo la quale tali scambi, consentendo la specializzazione delle produzioni di ciascuna nazione e quindi la produzione di ciascuna merce laddove vi sono le condizioni più favorevoli, determina vantaggi per tutti.
Se Smith aveva elaborato una legge simile, che per lui funzionava però solo nel caso che una nazione avesse un vantaggio assoluto a specializzarsi nella produzione di una certa merce, cioè fosse in grado di produrla a un costo inferiore a quello dei concorrenti internazionali, Ricardo amplia la casistica, dimostrando che ciascuna nazione ha un vantaggio a specializzarsi nella produzione per lei meno costosa relativamente alle altre merci, anche se più costosa rispetto al costo di produzione di altre nazioni. Quello che spenderebbe in più aumentando la produzione di tale merce anziché importarla sarebbe più che compensato dai risparmi derivanti dall’importare, anziché produrre, le merci relativamente più costose.
Appare evidente che anche questo strumento teorico serva a Ricardo – anche di più di quanto sia servito a Smith – per sostenere l’abbattimento delle barriere del commercio internazionale, per esempio i dazi sul grano, e in generale per supportare le politiche liberali.
La moneta
Riguardo al sistema monetario, Ricado aderisce alla cosiddetta teoria quantitativa secondo la quale il livello dei prezzi è direttamente proporzionale alla quantità di moneta emessa e alla sua velocità di circolazione.
Indicati con M la quantità di moneta in circolazione, Q la quantità del prodotto, V la velocità di circolazione e P il livello dei prezzi, sussiste l’identità
PQ=MV (1)
Pertanto, la causa dell’inflazione starebbe esclusivamente nella politica monetaria e proprio per questo Ricardo è un sostenitore del cosiddetto “gold standard”, secondo cui le banconote di Stato dovrebbero rappresentare una precisa quantità di oro ed essere convertibili in qualsiasi momento in oro. In più, egli ritiene che i fenomeni monetari siano del tutto autonomi rispetto a quelli dell’economia reale e che possano incidere solo sul livello generale dei prezzi, non sulle grandezze relative alla produzione. In particolare, ritiene che l’emissione di moneta non possa servire da stimolo alla produzione stessa, perché genera esclusivamente inflazione, né possa la riduzione delle monete in circolazione deprimere l’economia reale.
L’identità (1) è un fatto oggettivo. I prezzi delle merci moltiplicati per per le quantità oggetto di scambi, cioè il valore globale scambiato in un determinato periodo, deve essere uguale al corrispettivo in moneta, cioè la moneta in circolazione moltiplicata per le volte che quella data quantità torna in circolo dopo ogni singola transazione nel medesimo arco temporale. Tuttavia è erroneo attribuire a questa identità un valore esplicativo del livello dei prezzi in quanto la moneta emessa può non entrare nella circolazione delle merci ma essere tesaurizzata oppure impiegata nella finanza. Inoltre l’istituto di emissione, per esempio la Bce, non è l’unico soggetto che crea moneta in quanto anche gli istituti di credito emettono moneta bancaria, come potremo vedere trattando la scuola del circuito monetario.
Questa teoria sarà confutata prima da Marx e poi da Keynes, ma ritornerà in auge con la moderna scuola dei monetaristi, che hanno ispirato anche le attuali regole monetarie, economiche e fiscali dell’Unione Europea.
Il progresso tecnologico
Per quanto riguarda il progresso tecnologico, Ricardo è convinto che l’introduzione delle macchine comporti un beneficio per tutte le classi. Producendo più a buon prezzo i beni di consumo dei lavoratori, si possono abbassare i salari senza ridurre il loro tenore di vita, o addirittura aumentandolo. La riduzione dei salari permette l’incremento dei profitti e quindi degli investimenti, sviluppando così il potenziale produttivo. Pur ammettendo che temporaneamente le macchine possano creare disoccupazione, Ricardo ritiene che alla lunga si sarebbe trovato un nuovo equilibrio di piena occupazione sia impiegando i lavoratori per la produzione delle nuove macchine, sia grazie agli investimenti aggiuntivi per produrre ulteriori merci, resi possibili dal risparmio di manodopera, di capitali fissi e dallo stesso risparmio in consumi dei capitalisti per effetto del ribasso dei prezzi dovuto all’impiego di macchine. La possibilità, però, che i capitalisti siano indotti a investire di più in capitale “fisso” e di meno in lavoratori, diminuirebbe temporaneamente l’occupazione e con essa i consumi dei lavoratori; con ciò sono giustificati i loro timori riguardo all’introduzione delle macchine.
La legge di Say
In generale Ricardo nega che a lungo andare vi sia la possibilità di una crisi di sovrapproduzione e della conseguente disoccupazione, e ritiene che tutto il reddito debba essere speso. Si tratta dell’adesione alla cosiddetta legge di Say, dal nome dell’economista Jean Baptiste Say ma che in realtà venne formulata per primo da James Mill, secondo cui ogni produzione genera la sua domanda. Riportiamo le stesse parole di Ricardo: “Nessuno produce, se non allo scopo di consumare o vendere, né vende se non con l’intento di comprare altre merci, che gli possano essere immediatamente utili, o contribuire alla produzione futura. Producendo, quindi, egli diventa necessariamente o il consumatore delle proprie merci o il compratore e consumatore di merci altrui. Non si può ipotizzare che egli sia male informato delle merci che può più vantaggiosamente produrre per raggiungere il suo scopo, cioè il possesso di altri beni; perciò, non è probabile che egli continui a produrre un bene di cui non c’è domanda. Quindi non si può accumulare in un paese un qualsiasi ammontare di capitale che non possa essere impiegato produttivamente.” [1]
Anche questa legge verrà confutata da Marx prima e, con argomenti del tutto sovrapponibili a quelli marxiani, da Keynes poi.
Note:
[1] D. Ricardo, On the principles of Political Economy and Taxation, in The Work and correspondence of D. Ricardo, Vol. I, p. 290, traduzione mia.
* * * *
IV: introduzione a Karl Marx
Come introduzione alla teoria economica di Marx se ne traccia Il percorso intellettuale e politico, il rapporto fra teoria e prassi e fra struttura e sovrastruttura, la dialettica di Hegel e il metodo dell'economia politica che sono alla base dei successivi scritti economici.
Karl Marx (1818–83) fu un tenace studioso dei maggiori economisti che lo avevano preceduto e di alcuni suoi contemporanei. In particolare riconobbe ampiamente il suo debito verso Quesnay, Smith e Ricardo che tese a distinguere dagli economisti “volgari” il cui scopo prevalente era l’apologia del capitalismo. Tuttavia, pur riconoscendo alcuni meriti scientifici di questi tre grandi economisti, elaborò nei loro confronti una critica radicale per fornire alla classe lavoratrice strumenti teorici idonei a superare il modo di produzione capitalistico.
Da giovane si occupò di filosofia antica all’Università di Berlino e di tale argomento trattò anche nella sua tesi di laurea, Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro. È significativo che del pensiero del secondo sottolineasse la sua idoneità a un uso pratico di critica dell’idealismo. Lo stretto rapporto fra teoria e prassi fu un punto cardine del lascito marxiano ben espresso nella nota tesi 11 su Feuerbach: “I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo ma si tratta di trasformarlo”[1].
All’Università di Berlino erano dominanti allora le idee di Hegel. E Marx iniziò la sua attività teorica fra i “giovani hegeliani”, distaccandosene solo in epoca successiva. Di Hegel apprezzò e utilizzò la dialettica attraverso la quale vengono presi in esame il carattere contraddittorio dei processi reali e i mutamenti che queste contraddizioni determinano. Già i filosofi antichi utilizzarono la dialettica come dialogo della ragione con se stessa o fra persone che rappresentano diversi punti di vista. Ma nella dialettica hegeliana il pensiero logico non è limitato al solo processo discorsivo, ma si applica anche alla realtà sensibile. La distinzione tra realtà e pensiero come nella vecchia logica, afferma Hegel, era cara all’intelletto astratto, ma non più sostenibile da un punto di vista razionale, Invece la contraddittorietà costituisce una proprietà essenziale di ogni determinazione, sia dell’essere sia del pensiero.
Marx considerò la dialettica come uno strumento poderoso in quanto metodo più appropriato per esaminare sia la contraddittorietà della realtà, sia il suo movimento incessante. Infatti nel loro interagire i caratteri opposti rendono la realtà in equilibrio instabile, in continuo movimento e si superano in una nuova e più ricca sintesi che presenta nuove opposizioni dando luogo a un processo a spirale in base al quale le contraddizioni si risolvono in nuovi stadi evolutivi. Siamo perciò do fronte alla logica della trasformazione contro le visioni conservatrici di una realtà immobile. Marx ritiene in aggiunta che la realtà empirica debba essere assunta nel pensiero non in modo acritico e senza mediazioni, bensì analizzando “la realtà come processo storico” al fine di coglierne le contraddizioni “materiali” in movimento al suo interno.
Applicato questo metodo alla storia si può vedere che ogni sua fase ha prodotto tensioni al suo interno, il cui risultato è stato il passaggio a una nuova, più alta, fase della società. Come il feudalesimo lasciò il posto al capitalismo, quest’ultimo a sua volta avrebbe lasciato il posto a uno stadio più evoluto della società umana.
Essendogli stata chiusa la porta della docenza universitaria, nei primi anni Quaranta dell’Ottocento lavorò come giornalista occupandosi anche di questioni economiche, come il libero scambio e la legislazione sul furto del legno, in cui spezzò una lancia in favore del diritto dei proletari di impossessarsi del legname dei boschi.
Vagando per l’Europa in quanto perseguitato politico, incontrò a Parigi, nel 1844, Friedrich Engels, un industriale del cotone, e fra i due sorse una profonda amicizia e una stretta collaborazione. Fu proprio Engels a sollecitarlo a occuparsi di economia politica.
Dopo la stesura dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, scrisse, insieme a Engels fra il 1845 e il 1846, un manoscritto, non pubblicato e lasciato volentieri “alla critica rodente dei topi” che tuttavia costituisce un passaggio essenziale dell’elaborazione teorica dei due e che sarà pubblicato, come L’ideologia tedesca, solo nel 1932. In tale scritto si ha la rottura definitiva con la sinistra hegeliana e la prima elaborazione del materialismo storico.
Nella sua visione più matura la radice di ogni problema consisterà nell’organizzazione della produzione e nei rapporti a essa connessi. Per Marx e il suo amico Engels, tenace compagno di lotta, già in gioventù è consolidato il pensiero sul proletariato, la classe che deve emancipare se stessa e l’umanità, ma non sono ancora perfezionate la teoria e la definizione scientifica di proletariato che (come vedremo) può scaturire solo da quella di forza-lavoro come merce produttrice di plusvalore. Il fine di questa teoria non è meramente conoscitivo, bensì finalizzato alla trasformazione dello “stato di cose presenti”. Marx ed Engels vedono nell’azione rivoluzionaria del proletariato il legame inscindibile fra teoria e prassi, che rappresentano i due aspetti dell’unica emancipazione. Una teoria diviene “pratica”, dice Marx, quando afferra la radice dei problemi e “s’impadronisce delle masse”.
Il materialismo storico si differenzia dal materialismo settecentesco proprio perché, a differenza di quest’ultimo, considera la realtà come esposta al movimento e alla trasformazione da parte dell’uomo, soprattutto attraverso il processo lavorativo, all’interno del quale l’attività umana, come vedremo analizzando Il Capitale, si “oggettivizza”, diviene “lavoro morto”, cristallizzato nel prodotto, così come specularmente l’oggettività si presenta come risultato dell’azione dei soggetti.
Il punto di vista del materialismo storico è sintetizzato efficacemente da Marx ed Engels in un passo dell’Ideologia tedesca:
“La morale, la religione, la metafisica e ogni altra forma ideologica e le forme di coscienza che a esse corrispondono [non sono entità autonome...] ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza”[2].
Nel 1848 ebbe luce, sempre a due mani, il Manifesto del Partito Comunista che, oltre a dare alcune indicazioni pratiche di obiettivi da perseguire, sintetizzò la filosofia politica dei nascente movimento comunista: la storia come storia di lotte di classi, il ruolo inizialmente progressivo del capitalismo che ha sviluppato e rivoluzionato le forze produttive fino al punto di divenire un involucro di ostacolo al loro ulteriore sviluppo (“lo stregone che non può più dominare le potenze sotterranee da lui evocate”[3]), la progressiva scissione della società in due classi fondamentali e avverse fra di loro, il ruolo rivoluzionario dei comunisti per la formazione del proletariato in classe e il rovesciamento del dominio borghese.
Le ricorrenti persecuzioni lo portarono esule a Londra, dove si immerse nella biblioteca del British Museum a divorare la letteratura di molti economisti, traendone una rilevantissima mole di appunti, i cosiddetti Manoscritti di Londra.
Da qui sorse il progetto di una trattazione scientifica maggiormente sistematica della critica dell’economia politica. Tale progetto, assai ambizioso, in sei libri, di cui Il Capitale doveva costituire il primo, non fu portato a termine, ma ci sono rimasti in dote numerosissimi manoscritti, abbozzi ecc. oltre al primo libro del Capitale, l’unico da lui pubblicato. Dei libri che avrebbero dovuto trattare la rendita fondiaria, il salario, il commercio internazionale, il mercato mondiale, lo Stato ci ha lasciato solo alcuni spunti inseriti nel Capitale. Abbandonato Il progetto in 6 libri si concentrò in questa sua principale opera, che a sua volta avrebbe dovuto suddividersi in 4 libri. Tuttavia riuscì a pubblicare solo il primo libro che tratta il capitale in generale o, come recita il sottotitolo, “Il processo di produzione del capitale” di cui esistono diverse edizioni in più lingue da lui stesso curate, nessuna delle quali lo soddisfece pienamente. Del secondo libro, “Il processo di circolazione del capitale”, esistono stesure non definitive, alcune delle quali redatte in epoca più o meno contemporanea alla stesura definitiva del primo libro, e quindi abbastanza mature nello sviluppo della ricerca. Del terzo libro invece, “Il processo complessivo della produzione capitalistica”, i manoscritti esistenti, che risalgono a diversi anni prima, sono assai meno elaborati e maturi. Alcuni sono solo grossolanamente abbozzati e incompiuti. Engels curò la pubblicazione postuma di questi elaborati e, specialmente per quanto riguarda il terzo libro, dovette metterci del suo, integrando talvolta ai testi o decidendo la ripartizione in sezioni e capitoli. Altri manoscritti preparatori, i famosi Grundrisse, sono stati pubblicati negli anni Sessanta del Novecento. Per quanto riguarda il quarto libro, che avrebbe dovuto trattare la storia delle teorie economiche, Kautsky a sua volta pubblicò alcuni manoscritti assai incompiuti, le Teorie sul plusvalore, in tre volumi, titolandoli Storia delle teorie economiche, come se si trattasse veramente di un abbozzo del quarto libro e non una serie di appunti, in cui le citazioni abbondano, preliminari probabilmente alla vera e propria stesura del quarto libro.
Il primo lavoro che pubblicò in materia fu una breve introduzione all’argomento, Per la critica dell’economia politica, risalente al 1859 sintetizzata poi nella parte iniziale del primo libro del Capitale.
Nella prefazione a Per la critica Marx torna ancora sul rapporto fra la base materiale della produzione, la sua struttura economica, e la sovrastruttura che ne è condizionata, costituita da elementi di varia natura: giuridici, ideologici, culturali ecc. Un rapporto di dipendenza che molti hanno criticato come troppo meccanico, identificando il pensiero di Marx con alcune letture dogmatiche di tale teoria. Per comprendere il suo pensiero in merito è utile ricorrere a un altro inedito, l’introduzione ai Grundrisse [4], che tratta in maniera sistematica il metodo dell’economia politica. L’autore non volle pubblicarlo perché anticipava una serie di risultati che dovevano essere esposti nel Capitale.
In questo manoscritto si parla di “dialettica dei concetti di forza produttiva (mezzo di produzione) e rapporto di produzione, di cui vanno definiti i limiti” di “ineguale rapporto dello sviluppo della produzione materiale con lo sviluppo, per esempio artistico”: i rapporti di produzione hanno uno sviluppo ineguale, quindi non predeterminabile a priori, nel loro risolversi in “rapporti giuridici”. E in questa indeterminatezza rientra anche il caso, l’influenza dei mezzi di comunicazione ecc. Parlando dell’arte, e in particolare di quella greca, rileva che “i periodi di fioritura non stanno in rapporto con lo sviluppo generale della società”. Se certe manifestazioni artistiche, per esempio l’epica, sono possibili solo in certi stadi della società e sono incompatibili “con le filatrici automatiche, le locomotrici e il telegrafo” o Giove è incompatibile con il parafulmine, meno direttamente collegabile al grado di sviluppo sociale è la differenza fra la mitologia greca e quella egiziana. E comunque l’arte antica produce un godimento anche ai contemporanei.
Venendo al metodo dell’economia politica, Marx vi avvertì che, pur dovendo partire dai dati grezzi, dalla complessità di elementi demografici, economici, sociali ecc., limitarsi a questo avrebbe portato solo a una descrizione caotica dell’esistente. Doveva quindi essere utilizzato nell’analisi il metodo dell’astrazione cercando di pervenire alla cellula elementare della società che egli, a seguito di un processo di astrazione sempre più profondo, aveva individuato nella merce, per poi da essa risalire per gradi, introducendo sempre nuovi elementi, alla complessità dell’esistente. Ma questa volta non come una descrizione caotica bensì come una rappresentazione sistematica, una “totalità ricca, fatta di molte determinazioni e relazioni”. Vedremo come il metodo dialettico permette di qualificare questa risalita.
Riguardo al rapporto tra natura e storia nella produzione, si legge nell’Introduzione che la produzione in generale, prescindendo dalle specificità storiche e sociali, è il mezzo con cui l’uomo si appropria delle condizioni della natura, opera il ricambio organico tra sé e la natura. Ma ogni modo di produzione ha realizzato questo ricambio in forme diverse e, in particolare, il modo di produzione capitalistico, lo fa in forma di appropriazione privata dei mezzi di produzione da parte di pochi e mediante lo sfruttamento del lavoro salariato prestato dalla classe esclusa dalla disponibilità di tali mezzi. Così pure la distribuzione del prodotto tra le classi sociali, che in altre forme economiche avveniva in base ad altri criteri, per esempio in base a “diritti” considerati innati e alla dipendenza personale dei lavoratori (fossero essi schiavi o servi della gleba), nel sistema capitalistico, in cui esistono la libertà e l’uguaglianza formale di tutti, avviene attraverso il meccanismo impersonale del mercato, mentre i mezzi di produzione assumono la forma di capitale, la cui riproduzione perpetra ed estende le condizioni della sua esistenza, compresa l’esistenza di lavoratori “liberi”, da sfruttare.
Gli uomini hanno sempre prodotto usando i mezzi di produzione a loro disposizione, rudimentali quanto si voglia; un lavoro passato contenuto in questi mezzi o anche solo nella capacità lavorativa accumulata. Dal momento che nella nostra società questi mezzi e questo lavoro passato assumono la forma di capitale, per gli economisti borghesi il capitale diventa automaticamente una forma sempre esistita, necessaria, naturale e pertanto eterna. Ma una cosa è considerare i mezzi di produzione e il lavoro passato, in generale, altra e diversa cosa è invece considerarli nella loro forma capitalistica, che è specifica solo di questo modo di produzione. È forse superfluo osservare che il rifiuto del carattere “naturale” del capitalismo è indispensabile per prospettarne il superamento. Altrettanto si potrebbe dire per le forme che contraddistinguono la distribuzione e la circolazione dei prodotti, forme che sono differenziate nelle diverse epoche storiche.
È di estrema importanza, anche per la comprensione della crisi, che Marx abbia individuato i forti nessi tra produzione, distribuzione, circolazione e consumo, elementi distinti ma non separabili. È quindi errato vederne solo l’unità o solo la differenza. Intanto la produzione “è immediatamente anche consumo”, consumo di materie prime, di strumenti di produzione e di “forze vitali”. Gli economisti borghesi dell’epoca riconoscevano l’esistenza di questo “consumo produttivo”, ma consideravano il consumo vero e proprio, quello finale, solo come “antitesi distruttiva” della produzione, distruzione dei beni prodotti. Per Marx invece il consumo è anche “immediatamente” produzione, sotto molteplici aspetti; per esempio il consumo che serve all’uomo a riprodurre il proprio corpo, la sua forza lavoro. Così come la produzione è anche consumo: consumo di mezzi di produzione, consumo di capacità lavorativa. La produzione media il consumo creando l’oggetto da consumare. Senza la produzione non ci sarebbe consumo. Ma a sua volta il consumo media la produzione perché il prodotto raggiunge il suo scopo solo con il consumo: “una ferrovia sulla quale non si viaggia che quindi non viene consumata, è soltanto una ferrovia in potenza, non lo è nella realtà... un vestito diviene realmente tale soltanto attraverso l’atto di indossarlo”. Inoltre il consumo “crea il bisogno di una nuova produzione”, riproduce il bisogno senza il quale non vi sarebbe produzione. D'altra parte la produzione agisce sul consumo, “crea” il consumatore, i suoi bisogni soggettivi, li sviluppa, produce oggetti con caratteristiche nuove che modificano le abitudini di consumo. Nelle opere successive Marx affermerà che una causa importante delle crisi è proprio il fatto che produzione e consumo possono non raccordarsi come invece sarebbe necessario, e possono a tratti percorrere strade indipendenti fra di loro. L’unità di produzione, distribuzione, scambio e consumo sono invece una necessità che, se viene violata, deve essere ristabilita violentemente, proprio con la crisi.
Anche la distribuzione dipende dal modo di produzione. Il lavoratore percepisce un salario in quanto è un lavoratore salariato, in quanto non ha né terra né capitale né disponibilità di mezzi per poter lavorare in proprio, né disponibilità di mezzi di sostentamento; un proprietario terriero percepisce una rendita in quanto la terra è sua proprietà privata; un capitalista percepisce un profitto in quanto i mezzi di produzione sono in forma di capitale proprio. Ma a sua volta la distribuzione concentra la ricchezza nelle mani di pochi e riproduce il lavoratore privo di mezzi di produzione e di sussistenza, il cui prodotto è appropriato da altri. Se è vero che senza produzione non vi sarebbe distribuzione, è anche vero che la produzione capitalistica ha i suoi presupposti in questa distribuzione ineguale.
Cosa analoga si potrebbe dire del rapporto tra produzione e scambio, in quanto lo scambio privato dei prodotti presuppone la divisione del lavoro e la produzione privata, mentre il livello degli scambi dipende dal livello della produzione. Ma lo scambio media il rapporto tra produzione e distribuzione, per esempio attraverso la compravendita di forza-lavoro e tra produzione e consumo, attraverso la vendita dei prodotti. Quindi produzione, distribuzione, scambio e consumo, pur non essendo identici, sono articolazioni di una totalità in cui la produzione ha un ruolo predominante, ma non in maniera rigida e senza retroazione degli altri elementi sulla produzione stessa.
Marx è associato da molti agli economisti classici in quanto ha rielaborato le teorie di Smith e Ricardo, tra cui la teoria del valore. Tuttavia questa associazione fa perdere di vista la rottura di Marx con questi economisti. Come abbiamo già sottolineato per gli economisti classici, le leggi della produzione erano leggi della natura. Per Marx, invece, le leggi della produzione erano caratterizzate dai rapporti sociali di produzione e il capitalismo è solo una fase specifica della storia.
Note:
[1] K. Marx, Tesi su Feuerbach, appendice al saggio Engelsiano Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca, in Marx-Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, 1966, p. 190.
[2] K. Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca in Opere scelte, cit. p.240
[3] K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, in Opere scelte, cit. p. 297.
[4] K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, La Nuova Italia editrice, 1968, pp. 3-40.
* * * *
V. Marx e la merce
Dalla merce, “cellula elementare” del modo di produzione capitalistico, al denaro. Il lavoro quale unica fonte del valore. Le “sottigliezze metafisiche” che stanno dietro alla forma di valore e allo scambio mercantile.
La merce e il lavoro
Secondo il processo di astrazione che abbiamo visto trattando il metodo dell’economia politica, Marx inizia il Capitale con l’analisi della merce, individuata come la “cellula elementare” del modo di produzione capitalistico, il quale si presenta come una “immensa raccolta di merci”.
Già questa cellula elementare presenta al suo interno un’opposizione fra due caratteristiche: 1) da un lato, ha la proprietà di essere utile, di soddisfare bisogni umani: per questo suo aspetto è quindi valore d’uso; 2) l’altra sua proprietà è che può essere scambiata in determinate proporzioni con altre merci o con il denaro, l’equivalente generale utilizzato per gli scambi nelle economie di mercato: in questa veste è depositaria materiale del valore di scambio.
Se analizziamo la merce come valore d’uso, dobbiamo considerare quelle qualità che si realizzano nel consumo, le sue caratteristiche strutturali, estetiche, fisico-chimiche, la sua quantità fisica, la sua attitudine a soddisfare i bisogni umani prescindendo dal sacrificio necessario all’uomo per appropriarsene. Se invece la esaminiamo come depositaria del valore di scambio, dobbiamo prescindere da tutte quelle proprietà in quanto ciò che interessa sono i rapporti quantitativi che si instaurano tra questa e le altre merci e tra questa e il denaro. Per esempio, quanti euro occorrono per comprare uno smartphone o quanti chilogrammi di spaghetti corrispondono in termini di valore a un determinato tipo di abito.
Pertanto una merce può essere scambiata con tutte le altre ed è equivalente a ciascuna di esse, purché siano prese in determinate quantità. Poiché, nonostante la loro eterogeneità, sussiste questa possibilità, sussistono questi rapporti quantitativi di scambio, deve esserci un contenuto comune nelle merci, che è il loro valore. Quindi se dico che il valore di scambio di un certo personal computer è 400 euro, tale valore di scambio non è altro che il modo in cui si manifesta esteriormente questo suo intimo contenuto, questo suo valore. Per questo Marx precisa che il valore di scambio non è altro che la manifestazione esterna, fenomenica, di un contenuto immanente delle merci, del valore. Detto in altri termini, il valore di scambio indica i rapporti quantitativi di scambio visibili esteriormente fra più merci, ciascuna delle quali possiede una caratteristica intrinseca che si manifesta esteriormente nel valore di scambio.
Per capire meglio la distinzione fra manifestazione fenomenica e contenuto immanente delle cose, ricorriamo a un esempio dalla fisica. Sappiamo che tutti i corpi aventi un peso tendono a essere attratti verso il suolo dalla forza di gravità. Esistono degli strumenti per misurare l’entità di questa forza d’attrazione, le bilance, che stabiliscono il peso degli oggetti. Ma se andassimo a misurare il peso di un dato corpo sulla Luna, ci accorgeremmo che pesa molto meno che sulla Terra. Quindi il peso non è una proprietà stabile dei corpi, ma l’effetto prodotto sulla loro massa dalla forza di gravità operante nel luogo in cui detto corpo si trova, cioè il peso è la manifestazione fenomenica esterna di un’altra loro proprietà, la massa, che rimane tale in qualsiasi circostanza la osserviamo. Dividendo il peso per l’accelerazione gravitazionale, pari sulla Terra a 9,80665 m/s2, si ottiene approssimativamente la massa.
Fortunatamente, per molte esigenze pratiche, come per comprare frutta dall’ortolano, è sufficiente l’uso della bilancia, cioè di considerare la massa, la quantità di merce, indirettamente, tramite il peso, sua manifestazione esteriore. Ma per fare scienza non si può prescindere dal concetto di massa.
Analogamente, sempre per gli usi pratici, l’ortolano e il suo cliente si accontenteranno di sapere quanti euro al chilo costano le banane, ma per fare scienza non si può prescindere dal contenuto interno, dal valore delle merci, che si manifesta esteriormente nei rapporti di scambio, nel prezzo, per esempio di tre euro al chilo.
Questa distinzione fra proprietà immanenti e loro manifestazioni fenomeniche non è di lana caprina, perché, così come succede per il peso e la massa, anche il valore ha una sua grandezza immanente, un suo contenuto interno, assai complesso da misurare tanto che lo si rileva indirettamente, esteriormente, tramite il valore di scambio, tramite un prezzo di mercato. Non aver compreso questa distinzione ha indotto molti economisti successivi a Marx a considerazioni superficiali, quando non a grossolani errori.
Quale è dunque questa caratteristica comune delle merci? È il fatto di essere prodotti del lavoro. Nessuna società potrebbe riprodursi a lungo senza il lavoro, che è il dispendio di fatica, fisica o mentale che sia, occorrente per produrre i beni o i servizi utili a tale riproduzione.
Come si può constatare, Karl Marx riprende la teoria del valore dei classici, ma nello stesso tempo opera una rottura nei loro confronti. Ciò che mutua è l’idea, già rintracciabile in Adam Smith e fatta propria da David Ricardo, che il lavoro sia l’unica fonte della ricchezza e che il valore sia determinato dalla quantità di lavoro contenuto nelle merci. Quello che lo distingue è una riflessione più profonda sull’aspetto contraddittorio delle merci e del lavoro e soprattutto, vedremo, la scoperta di una merce speciale, la forza-lavoro.
Se le merci hanno un duplice carattere, altrettanto lo ha il lavoro che le produce. Da un lato è produttore di valori d’uso, di oggetti utili. In questa sua veste è lavoro concreto, utile, e hanno importanza, in analogia con le diverse utilità dei propri prodotti, le diverse qualità del lavoro: per esempio lavoro di metalmeccanico, distinto dal lavoro di edile, lavoro di informatico distinto da quello di infermiere ecc. D’altro canto, il lavoro è anche produttore di valore, è lavoro astratto in quanto in questa veste si astrae, si prescinde dalle diverse qualità dei vari lavori e lo si considera solo come dispendio di energia fisica o mentale, produttore di valore. La misura immanente, interna, di questo lavoro astratto (e quindi del valore) è il tempo di lavoro. La misura esterna, fenomenica, è invece, come abbiamo già rilevato, il valore di scambio, rappresentato da una somma di denaro.
Questa grandezza del lavoro non è però considerata individualmente, bensì socialmente. Infatti, se un lavoratore maldestro o operante in una fabbrica tecnologicamente arretrata o poco organizzata impiega il doppio del tempo di lavoro per una determinata produzione rispetto a un altro lavoratore, il suo prodotto non vale il doppio della merce prodotta in condizioni ottimali. Qui non conta il tempo di lavoro individualmente speso, ma il tempo di lavoro socialmente necessario, quello riconosciuto dal mercato sulla base del grado medio di sfruttamento del lavoro, del grado medio di abilità del lavoratore, della tecnologia prevalente nella società ecc. Il lavoro speso in più rispetto a questo standard, non è riconosciuto socialmente. Per la società è lavoro speso inutilmente che non conta come valore.
Quindi, il lavoro speso dai lavoratori può essere reso sociale dal punto di vista quantitativo solo annullandone le particolarità concrete e utili e riducendolo a lavoro astratto socialmente necessario, qualitativamente identico (non si possono sommare le mele con le pere), i cui prodotti sono proprio per questo equivalenti e quantitativamente comparabili.
Come abbiamo visto, Marx rifiuta la rappresentazione del modo di produzione capitalistico come qualcosa di astorico, naturale ed eterno, e lo ritiene invece solo una tappa dello sviluppo storico dell’umanità. Ne consegue che anche il lavoro e il valore sono considerati in relazione alle determinazioni specifiche, storiche, di tale modo di produzione.
Il concetto di lavoro è per Marx nettamente distinto da quello di forza-lavoro. Il lavoro, la fonte del valore, è il dispendio di energia fisica e psichica da parte del lavoratore, mentre la forza-lavoro costituisce la corporeità stessa del lavoratore, la sua capacità di erogare lavoro. Il capitalista, assumendo il lavoratore, acquista il valore d’uso della forza-lavoro, la possibilità di far lavorare il lavoratore per un determinato tempo contrattualmente previsto, non acquista il lavoro. E paga per tale uso il relativo valore. Quindi, occorre parlare di valore della forza-lavoro, mentre parlare, come fa Ricardo, di valore del lavoro è per Marx un non senso o una tautologia: sarebbe infatti come dire valore del valore, visto che il valore è dato dalla quantità di lavoro speso. Marx, in una lettera a Engels, afferma che quella della forza-lavoro, costituisce la sua più importante scoperta.
Già con l’analisi della merce, Marx rintraccia alcune caratteristiche universali e altre proprie del modo di produzione capitalistico. È universale il valore d’uso dei beni, la loro caratteristica di essere utili, come pure il fatto che il lavoro umano venga impiegato per produrre oggetti utili. Per esempio, anche nella comunità familiare o nell’antica comunità tribale i beni disponibili per il consumo assumono tale caratteristica, analogamente ai vari lavori necessari alla loro produzione. Al contrario, il lavoro diviene astratto solo con un tipo di produzione storicamente determinato, con la produzione di merci, e ancor di più con la produzione capitalistica sviluppata, che generalizza la forma di merce del prodotto, cioè produce beni da destinare allo scambio e riduce a merce la stessa forza-lavoro.
Nel duplice carattere della merce è insita una prima importante contraddizione. La merce, per chi la produce e la mette sul mercato, non conta come valore d’uso, non è utile in sé, altrimenti non verrebbe posta in vendita. Essa conta solo come valore, come depositaria di ricchezza astratta. Tale valore, però, prima dello scambio, è solo valore in potenza che deve essere validato nello scambio stesso. Solo dopo aver venduto la merce il capitalista realizza il suo valore. Al contrario, a chi la compra interessa la sua utilità o la soddisfazione di un bisogno diretto, oppure un impiego della merce stessa nella produzione, altrimenti non la comprerebbe. Per l’acquirente conta il valore d’uso. Naturalmente, il produttore deve immaginare quali merci possano essere considerate utili dagli acquirenti e pertanto vendibili. Questa sua valutazione non è però connessa alle proprie preferenze e ai propri bisogni. Egli deve stimare i bisogni e le preferenze altrui e quindi può sbagliarsi. Se si sbaglia, la merce è invenduta e il lavoro astratto in essa speso è lavoro perduto, non è valore realizzato, non acquisisce un riconoscimento sociale.
Questa opposizione tra valore d’uso e valore di scambio, latente all’interno della natura stessa della merce, si dispiega pienamente con l’estensione dello scambio, la generalizzazione della produzione di merci e soprattutto con la produzione capitalistica, il cui fine ultimo non è il valore d’uso, ma l’appropriazione e l’accumulazione di ricchezza astratta in forma monetaria.
Dalla merce al denaro
Lo scambio di merce con merce necessiterebbe che per esempio il bisogno di scarpe del fabbricante di computer si incontrasse direttamente con il bisogno di computer del produttore di scarpe. Questa necessità rappresenterebbe un serio ostacolo alla circolazione, e quindi alla stessa produzione, delle merci. È necessario quindi individuare una merce che possa funzionare da equivalente generale di tutte le altre, che sia accettata da tutti nello scambio perché utilizzabile da tutti per acquistare altre merci. Questo equivalente generale è il denaro, che può svolgere tale funzione in quanto contiene in sé una determinata quantità di lavoro sociale astratto, speso nella sua produzione. Il denaro è dunque l’equivalente generale di tutte le altre merci, depositario di valore e misura esterna del valore di scambio. Nella storia hanno svolto questa funzione varie merci: il bestiame, il sale (da cui il termine salario) ecc.. Già in molte civiltà antiche sono stati utilizzati per questo scopo i metalli preziosi, e soprattutto l’oro, in quanto omogenei, facilmente divisibili, poco deteriorabili e con valore relativamente costante, visto che la loro produzione corrente incide marginalmente rispetto al tesoro accumulato nei secoli. L’oro rappresentava quindi la cristallizzazione di una quantità di lavoro relativamente stabile. Finché è stato adottato il “gold standard” – cioè fino agli anni ’70 del ’900, quando fu abbandonata la convertibilità del dollaro – le merci si scambiavano con oro o con carta moneta o scritture bancarie che rappresentavano una certa quantità di oro. Per esempio, negli scambi internazionali la moneta accettata universalmente dopo il trattato di Bretton Woods era il dollaro che era convertibile con una certa quantità di oro. Le altre monete, valide per gli scambi interni, rappresentavano una quantità di oro indirettamente, in quanto avevano un rapporto di scambio con il dollaro, erano convertibili con dollari. In ogni caso, l’equivalente generale, il denaro, deve rappresentare una certa quantità di lavoro, a prescindere dall’oggetto in cui si cristallizza.
Nei cenni fatti sulla dialettica hegeliana avevamo visto che la contraddizione insita in un determinato oggetto determina un equilibrio instabile che deve essere risolto, dando luogo in tal modo a un nuovo oggetto. La contraddizione interna alla merce fra valore di scambio e valore d’uso si risolve in contraddizione esterna fra merce e denaro. Nello scambio, infatti, il denaro vale come ricchezza sociale astratta, tempo di lavoro, valore. La sua utilità esiste solo indirettamente, perché con esso si può acquistare qualsiasi valore d’uso, benché non abbia valore d’uso in sé. La merce conta invece solo come valore d’uso: il suo scambio con denaro è funzionale a procacciarsi un diverso valore d’uso. Il valore della merce esiste solo perché essa è scambiabile con una certa quantità di denaro, è rappresentato da tale quantità di denaro. Solo idealmente, nel prezzo impresso nell’etichetta, la merce è una quantità di denaro, è valore.
La rappresentazione del valore della merce, di tutte le merci, in una quantità di denaro, diviene quindi una necessità che si sviluppa a partire dall’equivalenza fra due merci. Marx, nelle varie edizioni del libro primo del Capitale da lui curate, curerà molto, e ne scriverà diverse varianti, la “forma valore”, introducendo diversi passaggi logici che portano dallo scambio immediato fra due merci allo scambio di tutte le merci con il loro rappresentante universale, il denaro.
Il feticismo della merce e del denaro
“A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. Finché è valore d’uso, non c’è nulla di misterioso in essa, sia che la si consideri dal punto di vista che soddisfa, con le sue qualità, bisogni umani, sia che riceva tali qualità soltanto come prodotto di lavoro umano. È chiaro come la luce del sole che l’uomo con la sua attività cambia in maniera utile a se stesso le forme dei materiali naturali. Per esempio quando se ne fa un tavolo, la forma del legno viene trasformata. Ciò non di meno, il tavolo rimane legno, cosa sensibile e ordinaria. Ma appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare”[1].
Questo espediente retorico di Marx è per dire che la merce rappresenta un potere sociale che va al di là del suo essere un oggetto d’uso in quanto contiene lavoro umano, dispendio di lavoro, e in quanto tale assume proprietà nuove e misteriose che debbono essere svelate. L’uguaglianza fra i lavori contenuti nelle merci scambiate appare come uguaglianza fra le merci stesse. Il carattere sociale del lavoro appare come un carattere del suo prodotto, delle merci. I rapporti sociali fra i produttori nello scambio sono condensati dentro la “cosalità” della merce, appaiono come rapporti fra cose. Specularmente i rapporti fra cose appaiono come rapporti sociali; il denaro, per esempio, acquista nella percezione comune una potenza sociale, permettendo di acquistare tutto, perfino i piaceri sessuali e le anime che sono in vendita, e i prodotti del lavoro appaiono come una “cosa sensibilmente sovrasensibile”, vale a dire sociale.
Come nelle credenze primitive i feticci erano oggetti cui venivano attribuite caratteristiche e poteri non insiti nella loro oggettualità, così alla merce vengono attribuiti caratteri sociali, e specularmente i rapporti sociali vengono identificati con una cosa, la merce o il denaro. Abbiamo già accennato, a proposito del metodo, che anche il capitale, il quale è un rapporto sociale, viene identificato dagli economisti borghesi con gli oggetti che lo compongono, i mezzi di produzione e i mezzi di sussistenza dei lavoratori. Questa lacuna dell’economia politica non è dovuta solo al suo carattere apologetico, ma alla stessa natura del rapporto mercantile e di quello capitalistico che si presta a invertire soggetto e oggetto.
Al venditore e al compratore interessa quanti prodotti altrui si possono acquistare cedendo il proprio prodotto, interessa il valore di scambio: per esempio, che un determinato vestito si possa scambiare con (valga quanto) due paia di un certo tipo di scarpe. Questi rapporti di scambio variano continuamente in relazione al variare delle condizioni di produzione dei beni e ad altri fattori di “disturbo”, come nel caso in cui le scarpe vengano prodotte in eccesso rispetto alla richiesta e quindi non possano realizzare tutto il loro valore, debbano essere svendute. Tutto questo sfugge però al controllo del singolo operatore, diventa il risultato di un meccanismo impersonale e tutto appare nella sua forma fenomenica, come rapporto di scambio fra cose, e non come uguaglianza fra il lavoro sociale in esse contenuto, in particolare se, come di norma nelle economie di mercato, lo scambio avviene contro denaro.
L’economia borghese non va oltre l’illustrazione, in modo più o meno accorto, di questa apparenza fenomenica. Ciò spiega, per esempio, perché essa si arrabatti nello stimare il ruolo della natura nella produzione di valore. Lo fa perché vede il contributo innegabile della natura nella creazione della ricchezza materiale, e considera il valore un fatto materiale, una proprietà delle cose, non accorgendosi che è un rapporto sociale in cui la natura non può intervenire. “Quanta natura c’è – ironizza Marx – in un corso dei cambi?”
Tutta la nebbia che non permette di vedere cosa sta dietro a questi rapporti fra cose si dissolve, però, se pensiamo a cosa avviene, per esempio, in un’economia tutta familiare, dove il lavoro viene speso e ripartito fra i vari componenti della famiglia e fra le varie produzioni utili alla sua riproduzione, compresi gli strumenti per realizzarle. Anche nei rapporti precapitalistici di sfruttamento del lavoro altrui la cosa è trasparente. Per esempio, il servo della gleba ha ben chiaro che deve spendere parte del suo tempo di lavoro nella corvée in favore del padrone. Ugualmente “la decima da fornire al prete è più chiara della sua benedizione”[2]. In casi del genere, i rapporti sociali si manifestano per quello che sono, come rapporti personali e non come rapporti fra cose.
Nel modo di produzione capitalistico, invece, lo sfruttamento non è così evidente e deve essere spiegato attraverso l’indagine scientifica.
L’umanità per millenni ha creduto che il Sole girasse intorno alla Terra, perché ogni giorno i nostri sensi percepivano che esso spunta da est e tramonta a ovest. Per certi comportamenti pratici questa visione non era controproducente. I giorni e le notti si alternano regolarmente e possiamo organizzare la vita e il lavoro su questa base. C’è voluta la scienza per comprendere che la nostra percezione è ingannevole e che dietro il fenomeno dell’alternarsi del giorno e della notte c’è il moto di rotazione della Terra. Analogamente alle difficoltà incontrate da Galileo per fare accettare questa conquista scientifica, i marxisti stanno incontrando analoghe difficoltà di fronte agli economisti mainstream, per fortuna non nel modo drammatico che ebbe a patire Galileo, ma più prosaicamente in termini di emarginazione fino a qualche esclusione dalle cattedre universitarie o dal circuito delle pubblicazioni.
Anche il denaro, la merce particolare che si distingue dalle altre perché non ha valore d’uso ma rappresenta il valore di scambio, non si sottrae al feticismo. Questa merce è denaro perché nel mercato il valore di tutte le altre viene espresso attraverso di essa. Al contrario, però, sembra che tutte le altre merci esprimano i loro valori in una merce particolare perché essa è denaro, cioè abbiano un valore non perché rappresentano una data quantità di lavoro sociale ma perché equivalgono a una somma di denaro.
“Non sembra che una merce diventi denaro soltanto perché le altre merci rappresentano in essa [...] i loro valori, ma viceversa sembra che le altre merci rappresentino generalmente in quella i loro valori, perché essa è denaro. Il movimento mediatore scompare nel proprio risultato senza lasciar traccia. Le merci trovano la loro propria figura di valore davanti a sé [...] come un corpo di merce esistente fuori e accanto a loro [...] Di qui la magia del denaro. [...] L’enigma del feticcio denaro è soltanto l’enigma del feticcio merce, divenuto visibile e che abbaglia l’occhio”[3].
Note:
[1] K. Marx, Il Capitale, Libro I, Ed. Riuniti, 1989, p. 103.
[2] Ivi p. 109. La decima era un tributo anticamente imposto agli agricoltori e costituito dalla decima parte dei prodotti agricoli che doveva essere devoluta ai sacerdoti.
[3] Ivi, p. 125.
* * * *
VI. La metamorfosi della merce e del capitale
Già la circolazione della merce contiene in sé la possibilità e la forma più astratta della crisi. Da qui la critica alla legge di Say secondo cui ogni offerta crea la propria domanda e quindi le crisi sarebbero impossibili. Il capitale va inteso come denaro, una potenza sociale resa autonoma dalle altre merci, che deve entrare incessantemente in circolazione per autovalorizzarsi.
La metamorfosi della merce e la critica alla legge di Say
La circolazione delle merci avviene attraverso una serie di cambiamenti di mano fra merci e denaro. Il venditore, per il quale la merce è immediatamente solo depositaria di valore e non valore d’uso, cerca di scambiarla con denaro, quale forma di equivalente socialmente valida, per realizzare così effettivamente il valore che tale merce conteneva in potenza. Avendo a disposizione il denaro realizzato, potrà appropriarsi di un’altra merce che sia finalmente per lui oggetto d’uso. Il fine della metamorfosi della merce è pertanto il cambiamento del valore d’uso a disposizione, per lui inutile con un altro. Tale cambiamento avviene con la mediazione del denaro e quindi si scinde in due mutamenti di forma: a) trasformazione della merce in denaro (Merce – Denaro o M-D); b) trasformazione del denaro in merce (Denaro – Merce o D-M).
In ciascuno di questi due momenti il soggetto trova al polo opposto un altro soggetto. Nella prima trasformazione (M-D), la vendita, il soggetto deve trovare un compratore; nella seconda (D-M) deve trovare un venditore. Secondo Marx la difficoltà maggiore, il “salto mortale della merce” è nel primo cambiamento (M-D) che può avvenire solo se il possessore della merce trova un compratore interessato al suo valore d’uso e che reputi congruo il suo prezzo, dunque solo se la merce è utile e prodotta senza spreco di lavoro. In altre parole, lo scambio avviene se il lavoro impiegato si dimostra a posteriori speso in forma socialmente utile.
Alla vendita del possessore di merce (M-D) deve corrispondere un acquisto da parte di un altro soggetto (D-M). Così pure la conclusione della metamorfosi, il secondo momento dello scambio, l’acquisto (D-M), coincide necessariamente con l’inizio di un altro scambio per un altro soggetto, cioè con la vendita da parte di quest’ultimo (M-D). In tal modo vengono a intrecciarsi fra di loro numerosissime metamorfosi della merce, come tanti anelli di una catena.
La mediazione del denaro è un vantaggio notevole: non rende necessario che si incontrino due soggetti che reciprocamente siano interessati l’uno al valore d’uso dell’altro. Come abbiamo visto, infatti, il compratore della mia merce non sarà in genere il venditore della merce che io acquisterò successivamente. Si superano in questo modo i limiti del baratto, dello scambio immediato fra merci, limiti spaziali (non è necessario che i due atti si svolgano nello stesso mercato) e temporali (non è necessario che avvengano nello stesso momento).
Il processo di scambio nel suo insieme, M-D-M, differisce dallo scambio immediato anche per un’altra caratteristica cruciale: la mediazione del denaro spezza questa metamorfosi in due fasi, M-D e D-M. L’inizio (M-D) coincide con la fine (D-M) di un ciclo analogo. La conclusione della mia metamorfosi (D-M) è anche l’inizio di un altro ciclo (M-D) per il soggetto che mi si contrappone. Se l’intero ciclo M-D-M va a buon fine, si realizza lo scopo della metamorfosi, quello di impossessarsi di un diverso valore d’uso. Ma i soggetti che ho avuto di fronte nel corso della metamorfosi sono due e non uno solo, e con il secondo movimento (D-M) il mio venditore ha iniziato un suo nuovo ciclo, un suo M-D e potrà (ma potrebbe anche non farlo) procedere all’acquisto di un altro valore d’uso (D-M). Le metamorfosi sono quindi concatenate fra di loro e ciascuna di esse costituisce l’anello di una catena, al di fuori del controllo dei soggetti in relazione. Pertanto, la rottura di un anello, perché una merce non può essere venduta, interrompe la catena e si propaga determinando altre rotture. Per esempio, se il produttore di bibbie non riesce a venderle, non potrà a sua volta comprare salsicce dal macellaio e quest’ultimo avrà meno denaro per comprare soprammobili, e così via. L’interruzione è resa possibile proprio dalla separazione del ciclo in due fasi. Tale possibilità costituisce anche la possibilità dell’esistenza delle crisi, ma solo la possibilità astratta, perché la spiegazione delle cause reali della crisi non è possibile esaminando la semplice circolazione della merce, ma presuppone di conoscere alcune contraddizioni presenti nella produzione e nella circolazione capitalistica.
Quindi Marx, partendo da questa forma astratta della metamorfosi della merce, formula una critica rigorosa alla legge degli sbocchi o legge di Say, dal nome dell’economista Jean Baptiste Say. Secondo questa legge, in realtà formulata per primo da James Mill, non può esserci crisi generalizzata di realizzo perché ognuno vende per acquistare, si procura cioè con la vendita il denaro che gli è utile per gli acquisti futuri, e quindi ogni offerta dà luogo a una domanda di pari importo. Marx osserva invece che lo spezzarsi in due fasi della metamorfosi, il fatto che il venditore possa differire il suo successivo acquisto, tesaurizzare il denaro o comprare una merce all’estero, determina la possibilità della crisi, anticipando un’analoga critica da parte di John Maynard Keynes il quale la formula senza ammettere debiti verso precedenti confutazioni, affermando che la legge di Say è valida solo per le economie basate sul baratto.
Criticando questa legge, Marx osserva che sebbene nella sua formulazione vi vengano immesse “di contrabbando le figure del venditore e del compratore mutuate dal processo di circolazione”, in realtà essa descrive il baratto. È vero che il fine della metamorfosi è lo scambio di un valore d’uso con un altro, M-M, ma tale cambiamento non avviene come un’unità, bensì in due fasi indipendenti. La distinzione tra queste due fasi costituisce anche “la forma generale della rottura e separazione” della catena di scambi, la “forma generale e astratta” delle crisi [1].
Il denaro non è solo l’intermediario dello scambio, ma anche il mezzo per dividerlo in due atti autonomi, separati nello spazio e nel tempo. Sono atti complementari: la loro unità è necessaria, devono realizzarsi entrambi, ma sono invece indipendenti fra di loro. Se non fossero separabili, se il denaro non potesse uscire dalla circolazione, per esempio tesaurizzandosi o rinviando nel tempo l’acquisto, non ci sarebbe la possibilità della crisi. “La difficoltà di trasformare le merci – il prodotto particolare del lavoro individuale –” nel suo opposto, cioè nel denaro che invece rappresenta lavoro sociale generale, è “insita nel fatto che chi ha venduto e quindi possiede la merce nella sua forma di denaro, non è obbligato a ricomprare immediatamente, a riconvertire il denaro in un prodotto particolare del lavoro individuale”. La facilità con cui il compratore può differire l’acquisto corrisponde alla difficoltà della vendita. “La crisi non è altro che l’affermazione violenta [della necessità] dell’unità di fasi [...] che si sono rese indipendenti l’una rispetto all’altra” [2].
L’affermazione che domanda e offerta sono di identico valore e devono corrispondersi non tiene conto del fatto che tale valore può realizzarsi, trasformarsi in denaro, solo se il valore d’uso della merce prodotta viene apprezzato nel mercato. L’incontro fra valore d’uso e valore non è però una certezza. L’“equilibrio metafisico” fra compera e vendita avviene perché a ogni compera corrisponde una vendita, per ogni compratore esiste un venditore. Tuttavia, in determinati periodi le merci diventano invendibili e chi non può vendere non può nemmeno comprare.
“Non ci può essere nulla di più sciocco del dogma che la circolazione delle merci implichi la necessità dell’equilibrio delle vendite e delle compere, poiché ogni vendita è compera e viceversa. Se ciò significa che il numero delle vendite compiute è identico allo stesso numero di compere, avremo una banale tautologia. Ma ciò dovrebbe dimostrare che ogni venditore porta al mercato il suo proprio compratore. Vendita e compera sono un atto identico come relazione reciproca fra due persone polarmente opposte, possessore di merce e possessore di denaro. Come azione della stessa persona, costituiscono due atti polarmente opposti. L’identità di vendita e compera implica quindi che la merce diventi inutile quando, gettata nell’alambicco alchimistico della circolazione, non ne esce come denaro, non è venduta dal possessore di merci, e dunque non è comprata dal possessore di denaro. [...] Nessuno può vendere senza che un altro comperi. Ma nessuno ha bisogno di comprare subito per il solo fatto di aver venduto” [3].
E qui compare di nuovo la critica alla confusione borghese fra carattere naturale della riproduzione sociale e sua forma storicamente determinata. La legge di Say, infatti, per dimostrare l’impossibilità della crisi identifica l’economia capitalistica con l’economia di baratto, privandola così di ogni determinazione specifica del modo di produzione capitalistico e della stessa economia di mercato.
“Per dimostrare che la produzione capitalistica non può condurre a crisi generali, vengono negate tutte le condizioni e tutte le determinazioni formali, tutti i principi e le differerntiae specificae, in breve la produzione capitalistica stessa, e in realtà si dimostra che, se il modo capitalistico di produzione, invece di essere una forma specificamente sviluppata, particolare della produzione sociale, fosse un modo di produzione rimasto dietro i suoi più rozzi inizi, non esisterebbero le sue antitesi particolari, le sue contraddizioni, e quindi neppure la loro esplosione nelle crisi” [4]
La merce, in cui esiste l’antitesi fra valore d’uso e valore di scambio, viene relegata a semplice prodotto, a solo valore d’uso. Si retrocede non solo dietro la produzione capitalistica, ma anche dietro la semplice produzione di merci. Si nega la crisi negando la produzione di merci e il loro scambio con denaro. Si nega ogni determinazione specifica del modo di produzione capitalistico. In sintesi, si potrebbe dire: se non ci fosse il capitalismo non ci sarebbe la crisi.
Marx respinge anche la teoria quantitativa della moneta, accettata pure da Ricardo. Questa teoria, partendo dall’identità fra la massa monetaria in circolazione (D) moltiplicata per la velocità di circolazione (V) e il valore complessivo delle merci (quantità, Q, per prezzi, P), in formula D*V = Q*P, afferma che un aumento della massa monetaria, per esempio attraverso l’emissione da parte dello Stato, non incide sul livello della produzione reale, ma solo su quello generale dei prezzi, generando inflazione. È evidente che al numero di transazioni nell’unità di tempo, per esempio un anno, moltiplicate per il prezzo unitario, cioè al valore delle transazioni, deve corrispondere un pari movimento di denaro (massa monetaria per velocità di circolazione, cioè per il numero di volte che quella massa entra in circolazione nella medesima unità di tempo). Se nella formula sopra riportata incrementiamo D, restando fermo tutto il resto, l’uguaglianza viene soddisfatta aumentando nella stessa proporzione P. E viceversa avviene una diminuzione dei prezzi nel caso di una riduzione della massa monetaria in circolazione. La moneta sarebbe quindi un “velo” che incide solo sul livello generale dei prezzi lasciando inalterata ogni altra grandezza economica. A questa deduzione Marx ribatte che è possibile che variazioni della massa monetaria incidano su V, e cioè che un’emissione di moneta suppletiva non necessariamente si traduca in una maggiore quantità di moneta in circolazione, determinando un aumento dei prezzi, ma possa essere trattenuta, riducendo la velocità di circolazione della moneta stessa. Anche in questo caso la teoria quantitativa prescinde dalle diverse funzioni del denaro, che non è solo quella di intermediario degli scambi, ma anche di stoccaggio della ricchezza, di mezzo di concessione dei crediti e di pagamento dei debiti o delle imposte, consentendo che la circolazione possa, entro determinati limiti, prescindere anche dalla quantità di denaro in circolazione. Ciò avviene a maggior ragione quando circola in forma cartacea o di semplici scritture contabili, per non dire delle attuali forme di pagamento digitale e dei bitcoin.
La metamorfosi del capitale
Proseguendo nello sviluppo della sua analisi, Marx introduce la “metamorfosi del capitale”, cioè la forma con cui circolano i capitali.
Abbiamo visto che il denaro è valore reso autonomo dalle altre merci. È un coagulo di lavoro astratto oggettivato, è valore, una potenza sociale. Il fine ultimo del modo di produzione capitalistica non è scambiare valori d’uso: lo scambio di merci è solo lo strumento per realizzare il vero fine, l’accumulazione di ricchezza astratta, di denaro.
Il ciclo M-D-M, quindi, non riesce a spiegare il fondamento di tutta una serie di fenomeni tipici di un modo di produzione che ha compiuto, attraverso il capitale, il balzo verso la generalizzazione della produzione di merci. Nella forma della metamorfosi della merce il primo e l’ultimo termine sono due merci di valore equivalente; il movente dello scambio è l’appropriazione di un valore d’uso che renda possibile la soddisfazione di determinati bisogni. Anche nella produzione capitalistica questo è un aspetto inevitabile del processo di scambio. Per esempio, ecco cosa si potrebbe affermare a proposito dello scambio tra capitale e forza-lavoro: 1) il capitalista cerca di realizzare, con la vendita, il valore dei suoi prodotti e trasformarli in denaro (M-D); 2) attraverso il denaro può ora appropriarsi di merci aventi una forma materiale a lui utile al fine di iniziare un nuovo ciclo produttivo, forza-lavoro e mezzi di produzione (D-M). Ugualmente il lavoratore trasforma ciò di cui dispone, la propria capacità lavorativa, l’uso della sua forza-lavoro, in denaro, cedendolo come una merce al capitalista in cambio di salario (M-D), visto che la forza-lavoro è anch’essa una merce, in modo che possa impiegare tale denaro per accedere ai mezzi di sussistenza disponibili in forma di merci (D-M).
Se le cose si presentano effettivamente in questi termini, l’analisi dei fenomeni da questa angolatura non riesce a svelare i rapporti cruciali del modo di produzione capitalistico. Non ci spiega sufficientemente, per esempio, quale sia il movente che induce a ripetere questo ciclo in forma capitalistica e su scala allargata.
Modificando il punto di partenza e quello finale del processo di scambio, partendo dal denaro e ritornando al denaro, interpretiamo più efficacemente la realtà. Non si tratta di un puro espediente analitico: porre il denaro all’inizio e alla fine del processo, quale forma generale della ricchezza, consente di percepire la reale natura della produzione capitalistica, la quale è produzione di ricchezza astratta fine a se stessa e il suo continuo incremento. Facendo astrazione dal contenuto materiale della circolazione delle merci, dallo scambio dei valori d’uso, troviamo che il suo ultimo prodotto è il denaro. Il denaro è la prima forma fenomenica del capitale. Nel processo D-M-D il processo di scambio ha senso solo se l’ultimo termine è superiore quantitativamente al primo, in quanto qualitativamente si tratta della stessa merce, denaro. Pertanto, è più consono rappresentarlo come D-M-D’ dove D’ è maggiore di D, è D più un delta. Il denaro immesso nella circolazione diviene valore che si conserva e si accresce, diviene cioè capitale.
Tuttavia, anche la quantità di denaro che esce dal ciclo, superiore a quella immessa, è limitata, come lo era quella anticipata. Se venisse spesa improduttivamente cesserebbe definitivamente di essere capitale; se venisse tesaurizzata non avrebbe la possibilità di accrescersi nuovamente. Essa deve essere messa di nuovo in circolazione. Il “capitale valorizzato”, la fine di ogni ciclo, diviene così per Marx l’inizio di un nuovo ciclo. Ecco perché solo con la produzione capitalistica si generalizzano la produzione e la circolazione delle merci.
“Il possessore di denaro diventa capitalista, nella sua qualità di veicolo consapevole di tale movimento. La sua persona, o meglio la sua tasca, è il punto di partenza e di ritorno del denaro. Il contenuto oggettivo di quella circolazione – la valorizzazione del valore – è il suo fine soggettivo. Egli funziona come capitalista, ossia come capitale personificato, dotato di volontà e di consapevolezza, solamente in quanto l’unico motivo propulsore delle sue operazioni è una crescente appropriazione della ricchezza astratta. Quindi il valore d’uso non deve essere mai considerato il fine immediato del capitalista. E neppure il singolo guadagno, ma soltanto il moto incessante del guadagnare” [5].









































Add comment