Il divorzio dal reale: alcune riflessioni economico-filosofiche per una anatomia della modernità
di Andrea Granato
Il testo che segue presenta l’abbozzo di una anatomia del mondo moderno, condotta attraverso un registro molteplice: filosofico, economico e storico insieme. Vedremo così, come in tre distinti punti di vista disciplinari, si presenti la medesima traiettoria complessiva che oggi, arrivata a un punto estremo, esige di essere pensata secondo un nuovo e diverso indirizzo
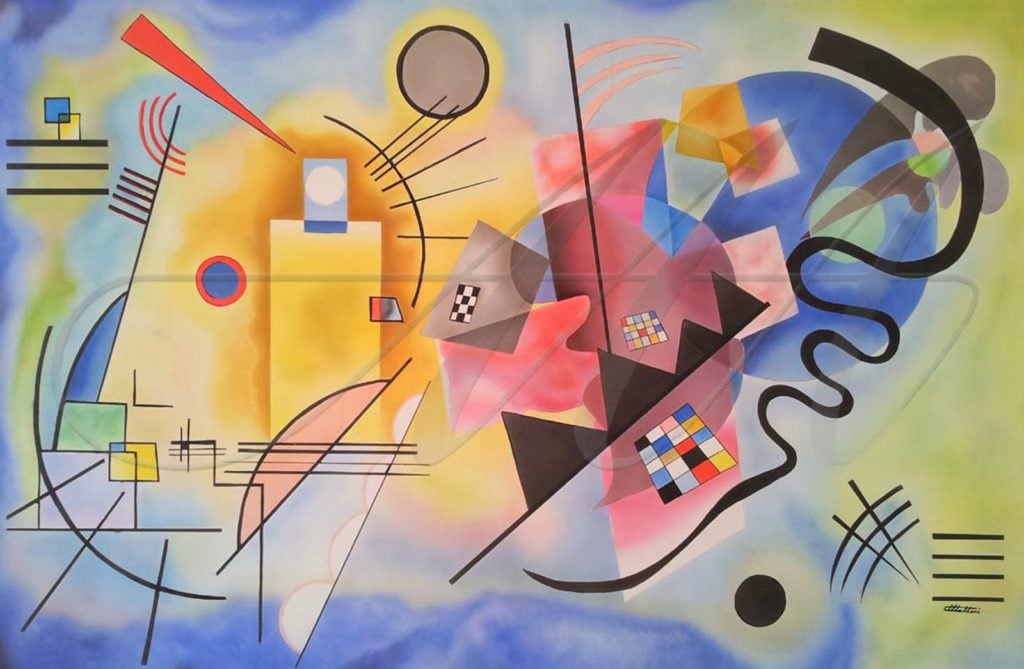 Definire il moderno non è, e non è mai stato, facile. Ma c’è poi davvero bisogno di una (ennesima) definizione teorica? Vorrei dunque iniziare altrimenti, in modo quasi obliquo, forse un po’ spiazzante: ogni soldato semplice di Napoleone aveva il bastone da ufficiale nello zaino. Era lo stesso Napoleone a dirlo loro – per incoraggiarli, ed è impossibile non pensare a come questo aneddoto rispecchi la storia di un certo semisconosciuto tenente d’artiglieria, corso, divenuto più tardi Imperatore dei Francesi e andato in sposa a una figlia delle famiglie più antiche dell’Ancien Régime…Ma com’era stato possibile ciò? Com’è possibile che tutto sia possibile? Cos’è il moderno? Nello sguardo di Napoleone ogni soldato era (in potenza) un ufficiale. Egli vedeva ciò che lui stesso incarnava: il campo del possibile disancorato da ogni ordine fisso e rigido, sia esso “naturale”, “genealogico”, “censitario”. Laddove la parola “ordine” indica semplicemente la realtà già in atto. La modernità – politica ed economica – segna il sopravanzare della potenza sul reale, della libertà sull’essere. Ricordiamo il rovesciamento idealista dell’adagio scolastico: esse sequitur operari. Il sogno americano, così come il mito napoleonico, consiste nella speranza o, a seconda, nell’illusione che si possa essere dal nulla, crescere in brevissimo tempo, senza bisogno di radici sufficientemente profonde. Di fatti la maggior parte dei protagonisti economico-finanziari del mondo americano – i cosiddetti robber barons – non erano «nessuno». Il carattere se vogliamo messianico della terra nordamericana, assimilata alla terra promessa biblica, sta’ appunto in ciò: quel che è nulla (in Europa, nel Vecchio Mondo), può divenire tutto (nel Nuovo). Questo movimento viene emblematicamente espresso dalla generazione dei Carnegie e dei Rockefeller, magnati dell’acciaio e del petrolio di fine ‘800: “Nessun milionario era o sembrava più drammaticamente self-made (venuto su dal nulla) di quelli statunitensi […] L’America era ancora il Nuovo Mondo, la società aperta in un paese aperto, dove era opinione diffusa che l’immigrante senza quattrino potesse rifarsi una vita (essere un self-made man) …”[1]
Definire il moderno non è, e non è mai stato, facile. Ma c’è poi davvero bisogno di una (ennesima) definizione teorica? Vorrei dunque iniziare altrimenti, in modo quasi obliquo, forse un po’ spiazzante: ogni soldato semplice di Napoleone aveva il bastone da ufficiale nello zaino. Era lo stesso Napoleone a dirlo loro – per incoraggiarli, ed è impossibile non pensare a come questo aneddoto rispecchi la storia di un certo semisconosciuto tenente d’artiglieria, corso, divenuto più tardi Imperatore dei Francesi e andato in sposa a una figlia delle famiglie più antiche dell’Ancien Régime…Ma com’era stato possibile ciò? Com’è possibile che tutto sia possibile? Cos’è il moderno? Nello sguardo di Napoleone ogni soldato era (in potenza) un ufficiale. Egli vedeva ciò che lui stesso incarnava: il campo del possibile disancorato da ogni ordine fisso e rigido, sia esso “naturale”, “genealogico”, “censitario”. Laddove la parola “ordine” indica semplicemente la realtà già in atto. La modernità – politica ed economica – segna il sopravanzare della potenza sul reale, della libertà sull’essere. Ricordiamo il rovesciamento idealista dell’adagio scolastico: esse sequitur operari. Il sogno americano, così come il mito napoleonico, consiste nella speranza o, a seconda, nell’illusione che si possa essere dal nulla, crescere in brevissimo tempo, senza bisogno di radici sufficientemente profonde. Di fatti la maggior parte dei protagonisti economico-finanziari del mondo americano – i cosiddetti robber barons – non erano «nessuno». Il carattere se vogliamo messianico della terra nordamericana, assimilata alla terra promessa biblica, sta’ appunto in ciò: quel che è nulla (in Europa, nel Vecchio Mondo), può divenire tutto (nel Nuovo). Questo movimento viene emblematicamente espresso dalla generazione dei Carnegie e dei Rockefeller, magnati dell’acciaio e del petrolio di fine ‘800: “Nessun milionario era o sembrava più drammaticamente self-made (venuto su dal nulla) di quelli statunitensi […] L’America era ancora il Nuovo Mondo, la società aperta in un paese aperto, dove era opinione diffusa che l’immigrante senza quattrino potesse rifarsi una vita (essere un self-made man) …”[1]
Possiamo a questo punto fare un passo in avanti e chiederci, in maniera un po’ impertinente: qual è il senso di questo riflessivo che incontriamo nella formula: “l’uomo si fa’ da sé”?. Da sé significa, precisamente,dal nulla di sé e di tutto quanto gli è presupposto: ex nihilo sui et subiecti per riprendere la celebre formula scolastica. Mancando un presupposto manca un fondamento, ordine o legge che sta’ prima (prae-) e sotto (-sub). Il moderno è ciò che non ha alle spalle nulla di già dato. Ciò che inizia ora, svoltando pagina.
Se la tradizione filosofica premoderna e aristotelica, parlando di potenza intendeva quasi sempre riferirsi alla possibilità di qualcosa, cioè a una potenza legata a un atto determinato, la modernità si presenta la situazione ontologica di una possibilità pura, cioè assoluta, slegata dall’altro polo, quello della realtà (e dunque, in senso più ampio, da un “ordine” cosmico, sacrale, giuridico-politico etc. già dato). Ciò che, per i dettami della tradizione aristotelica era un semplice monstrum, ovvero una potenza illimitata, si trascrive nell’uomo nel segno della libertà; termine che acquista, con Kant ma soprattutto con il suo allievo, Fichte, una ampiezza fondativa ben più ampia del ristretto campo morale del libero arbitrio. La libertà, nelle parole stesse di Fichte, è Uroffenbarung, Rivelazione originaria. Perciò Goethe, nel suo Faust, può osare riscrivere il prologo di Giovanni secondo le parole della Wissenschaftlehre fichtiana:
«Im Anfang war die Tat»[2]
Il regno moderno della libertà è la situazione preminenza dell’infinitezza del possibile sulla finitezza dell’atto compiuto (cioè esaurito e cristallizzatosi in una Werk, che è sempre finitudine, cioè determinazione). L’infinità è invece il puro agire (il Tun o Wirken) senza atto, il verbo all’infinito non ancora irrigidito nella morta quiete del sostantivo, l’attività che, ancora priva di opera, cioè non limitata da nessuna sua estrinsecazione, rinvia e afferma solo sé stessa: l’io pone sé stesso[3].
Penso altresì che per afferrare appieno questo movimento del pensiero dobbiamo, in un certo senso, fare un salto al di là del pensiero stesso. Non è già in un ambito teoretico o puramente accademico che questo movimento scava le sue conseguenze più gravide, ma nella falda storica che divide il sistema economico di produzione pre-moderno da quello proprio della modernità, il sistema capitalistico.
Se dunque la modernità segue una traiettoria complessiva che ha il senso ontologico di uno sganciamento della potenza dall’atto, del possibile dal reale, bisognerà rintracciare proprio in alcune forme del mondo economico i segni di questo divorzio dal reale. Cosa significa cioè dal punto di vista della struttura economica di produzione, la supremazia del possibile sul reale? Che rapporto c’è fra l’autocoscienza moderna dello spirito come libertà e possibilità pura e lo scatenamento delle forze tecnico-produttive nel campo materiale? Non sarà che quella rivelazione compiuta dello spirito a sé stesso si concluda non già in un libro pubblicato per un editore di Bamberga nel 1807, ma nell’inferno delle fabbriche dell’industria meccanica inglese, e poi tedesca e americana, e infine mondiale?
Possiamo offrire, in questa direzione, solo un’esemplificazione fra le molte che si posson fare: la sequenza Denaro-Merce-Denaro[4], che – seppur parzialmente – illustra l’ingresso nella realtà capitalista[5], è – nelle parole stesse di Marx – un movimento senza fine[6]. Il sistema capitalistico risponde, a differenza di quello feudale, a una logica dell’infinità che Marx chiama, alternativamente, valorizzazione del valore, autovalorizzazione o valore in processo.
Sarebbe tuttavia unilaterale spiegare questo carattere tendenzialmente senza limiti dell’accrescimento del valore riducendolo al dato psicologico-antropologico dell’“avidità” congenita del capitalista in quanto uomo. Il capitalista, detto altrimenti, non va’ considerato come un uomo ma come espressione del capitale (cioè della struttura oggettiva del sistema di produzione). Non possiamo qui approfondire la problematicità di questa scissione dell’interiorità soggettiva e dell’esteriorità oggettiva che si rivelerà poi decisiva non a caso proprio per il concetto marxiano di Rivoluzione[7]. Ciò che si guadagna mediante di essa è, in ogni caso, la possibilità teorica di rendere conto dei tratti unici e irriducibili del sistema moderno di produzione. E ciò che in esso è in gioco, prima di ogni considerazione sulla natura teologicamente o moralmente “viziata” dell’uomo, è precisamente il rapporto fra capitale e potenza: innanzitutto, visibile nel carattere modale del verbo stesso “potere”. Capitale non è il prodotto finito o il profitto che se ne ricava, ma tutto ciò con cui possiamo produrre: Capitale sono i mezzi di produzione, la forza-lavoro e anche il denaro nella misura in cui permette di comprare entrambi. È il come, non la cosa.
L’infinità del processo di valorizzazione rientra pienamente nel movimento moderno di esplosione della potenza umana che non ha più limiti, consuetudini o leggi naturali date cui dover rispondere.
Così in D-M-D si compra per vendere, cioè: si compra per poter comprare di più, in una spirale di accrescimento indefinito del proprio potere di acquisto. L’accumulo non riguarda le merci come tali, fruibili e dunque finite, ma il denaro come virtualità di tutte le merci e i mezzi di produzione. Cosa acquistiamo quindi con il denaro? Non una merce, reale, tangibile, gustosa, odorosa etc. ma il potere di acquistare o produrre qualsiasi merce. Il passaggio epocale dal feudalesimo al capitalismo vede la supremazia della virtualità sulla realtà, della liquidità sempre in circolazione del patrimonio sulla fissità del bene stanziale, immobile. Il capitalista rifiuta la stagnazione del morto e quieto possesso. Perciò “la tesaurizzazione, nella forma astratta in cui è considerata arricchimento, diminuisce insieme con lo sviluppo della produzione borghese…”[8]
Se il signore feudale “consuma ciò che c’è”[9] il capitale rifiuta il godimento, rifiuta la finitezza dell’usufrutto a favore dell’infinità (potenziale) della circolazione, nel quale i vincoli anche più arcaici e sacri – come quello del γένος aristocratico alla sua terra – vengono mobilitati, cioè letteralmente liquidati, resi liquidi-alienabili affinché pecunia pecuniam parit. A differenza del profitto, la rendita tende alla stabilità: in quanto è ancorata alla terra, con la disponibilità limitata delle sue risorse, i suoi ritmi e i suoi tempi – che non sono i nostri etc. – in tanto è ancorata a un riferimento reale. Nel linguaggio degli idealisti: non posto, ma dato(gegeben) o trovato(vorgefunden). Le forze di produzione sono qui (“qui” – in questo sistema) ancora incatenate. Dipendono da quella che gli sempre gli idealisti avrebbero chiamato la Gegebenheit della natura. Ciò che essa può offrire non è manipolabile nel senso di un incremento infinito. Il possibile non fluttua ancora sopra il reale. Ciò che essa offre è ciò che può offrire. La finitezza è infatti l’identità del possibile e del reale che innovazioni tecnologiche in campo agrario (dal XIII-XIV secolo in avanti, fino agli odierni concimi chimici) non possono violare, più di tanto. E tuttavia “la coltivazione dei campi è stata presa nel vortice di un diverso tipo di coltivazione (Bestellens) che richiede (stellt) la natura. Essa la richiede nel senso della pro-vocazione. L’agricoltura è diventata industria meccanizzata dell’alimentazione […] In modo diverso appare il terreno che un tempo il contadino coltivava […] l’opera del contadino non pro-voca la terra del campo.”[10] Le riflessioni di Heidegger convergono qui in modo sostanziale con quelle di Marx sulla sottomissione della proprietà fondiaria feudale alle logiche e ai ritmi del sistema industriale: “giunge necessariamente un momento in cui la proprietà fondiaria, come ogni altra proprietà, deve andare a finire nella categoria del capitale che si riproduce con profitto, e certamente questo è il risultato dello stesso movimento industriale.”[11]
Gran parte delle contraddizioni economiche della società industriali precipitano così nel nostro pianeta, che ne porta le cicatrici. La terra, in quanto finita, ricusa la sua trasformazione in una riserva di estrazione infinita di valore, rifiuta la sua capitalizzazione: così le forze produttive, che tendono per loro natura all’illimitato, si scontrano necessariamente con la Terra, che sancisce il limite, e le chiude in esso. È a questo punto che la logica economico-produttiva dell’infinità – che non è legata soltanto al fatto “psicologico” dell’avidità del capitalista, ma all’espansione della potenza tecnica dell’uomo – diviene ciò che già era all’inizio: una questione antropologica.
Molte delle sfide che ci presenta l’attuale transizione ecologica ci chiedono di comporre la finitezza del nostro pianeta con l’infinità della nostra creatività, espressa economicamente come forze e mezzi tecnici di produzione; ci chiedono cioè una conciliazione la cui esigenza, seppur in un senso ancora solamente teoretico, era già perfettamente chiara ai grandi pensatori della filosofia classica tedesca. Non era solo per una ipoteca teologica che il linguaggio pudico degli idealisti non si sbilanciava a parlare di creare o di creazione, rifugiandosi nel vocabolo, teoreticamente più gestibile, setzen. L’idealismo classico si è sempre assegnato come compito la conciliazione con il realismo, e dunque la sua esibizione come ideal-realismo (in Fichte) o come superamento di un idealismo soltanto soggettivo (in Hegel) in una nuova forma di metafisica.
Oggi però questa antica sfida filosofica acquista l’urgenza storica di una conciliazione dell’uomo con la sua terra perché è l’uomo stesso, ormai divorziato da ogni realtà, a rappresentare il più grave pericolo per la terra e per sé stesso. Persino la possibilità di una manipolazione del patrimonio genetico dell’uomo, presentata da alcune correnti del post-umanesimo, è una delle possibilità che rientra nell’unica possibilità che l’uomo è a sé stesso. In effetti Il contemporaneo incontra il pericolo di uno sganciamento della soggettività da ogni ordine o legge dati in un modo che non è ormai più neanche teoretico o soltanto intellettuale, ma direttamente storico-esistenziale. L’esplosione di un principio di creatività anarchica e assoluta suscita oggi uno scandalo essenzialmente diverso di quello che l’Europa borghese benpensante poteva avvertire di fronte alle tesi di Stirner o di Nietzsche o anche di molta Avanguardie, il Dada. Eppure si tratta della stessa traiettoria, che oggi, diviene tecnicamente capace di intervenire perfino sulla sfera biologica (ritenuta data e immutabile una volta per tutte) e non più solo su quella, economica o giuridico-politica (com’era stato nella modernità)
Inservibili e puerili sono quelle vie di fuga puramente reattive, antimoderne e neoluddiste, cui occhieggia tutto un certo pensiero della “destra” e della “tradizione”. Piuttosto, se le strutture ontologiche, antropologiche ed economiche risultano così strettamente intrecciate – come ci siamo proposti di mostrare – è forse possibile indicare almeno in un lavoro di rifondazione teorica e culturale complessiva una via in questo senso. Questo potrebbe assumere i contorni di un ritorno a una forma temperata di idealismo: una affermazione della soggettività creativa inserita armonicamente e liberamente in un ordine dato che la preceda, potrebbe forse rappresentare una chiave teorica capace di corrispondere anche alle questioni economiche suesposte.
Ciò richiede che lo stesso concetto di Rivoluzione che, scrivevamo nella nota 8, modifica in Marx soltanto il piano esteriore-oggettivo, quale rivoluzione della proprietà privata dei mezzi di produzione, subisca una nuova semantizzazione capace di portarlo al di là non solo della scissione fra piano interno-soggettivo e piano esterno, da cui scaturisce, ma anche dall’ingenua credenza (propria dello stesso Marx) che il compiuto umanesimo discenda, come per magia, dalla soluzione delle contraddizioni economico-sociali. Perché ciò sia possibile è necessario che l’uomo impari a stare sulla terra senza che il potere tecnico che ha fra le mani ne sancisca la devastazione, ma piuttosto giocando con esso, in una forma di gioco però, si noti bene, nel quale non è solo lui a dare le regole. Un gioco, dunque, che non significa più arbitrio illimitato, un idealismo che è anche un realismo, una libertà assoluta che è anche assoluta obbedienza. Questo potrebbe essere il senso, ancora tutto da capire di un nuovo idealismo, se è questo il tempo in cui, come dice Kant, “una grande quantità di ricerche può essere ridotta alla formula di un unico problema”[12]









































Comments
Per restare sul piano analitico, la più sofisticata prospettiva teologica di gloria di Marx, la cui, en passant, soteriologia “panteistica” lo renderebbe pure colpevole di radicale individualismo, non include fragili causalità: infatti, in termini marxiani, se il processo può essere scientificamente descritto, non così per i caratteri della sua effettiva realizzazione, per comprendere una superiore configurazione spirituale.
Tuttavia, per restare sul piano storico e terreno, se tale sbocco di gloria appare logicamente plausibile, la specifica dinamica vettoriale privilegiata da Marx presenta dei problemi, sui quali la riflessione dovrebbe farsi matura e non perdersi in scappatoie di altre dimensioni.
Per esempio, la traiettoria del salario marxiano, che la classe dominante, intuendone le potenzialità marxiano-eversive, ha drasticamente respinto nel paradigma del capitalismo neoliberale fascista, ha evidenziato degli effetti comportamentali e psicologici rilevanti, per quanto messi in secondo piano da Marx: cioè l’incremento di reddito reale delle classi inferiori ha generato in queste la formazione di aspettative di valorizzazione del valore di scambio non strettamente compatibili con la dinamica lineare della teologia della gloria. In concreto, prendendo a esempio la Gran Bretagna, ma, a suo modo, lo stesso accadde in Italia, come mise in evidenza il disilluso e astuto notevole politico democristiano Forlani, i laburisti, artefici dell’incremento di reddito, si trovarono in grossa difficoltà a contenere gli idioti slogan, dai prevedibili effetti distruttivi sulle classi inferiori, di una mentecatta ideologizzata piccoloborghese come la Thatcher. Ovviamente intensamente sostenuta dall’oligarchia e dalle cialtrone/i e ciarlatane/i degli organi della disinformazione e propaganda.
Nel regime neoliberale fascista attuale il modello è diventato lo standard. L’oligarchia sceglie le marionette politiche minorate mentali e le propone come al supermercato alle classi inferiori. Le ciarlatane/i della propaganda e disinformazione le celebrano, come celebrano la guerra, a cui le classi inferiori dovrebbero dare il massimo contributo.