
La lingua come arma. E noi come bersaglio
di M. Alessandra Filippi
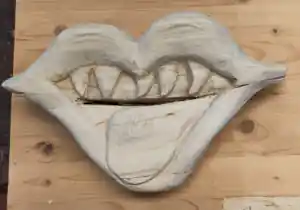 Dal Covid a Gaza, il potere ha riscritto la realtà attraverso il linguaggio. Disinformazione è verità, controllo è sicurezza, aggressione è autodifesa: la neolingua che prepara alla guerra.
Dal Covid a Gaza, il potere ha riscritto la realtà attraverso il linguaggio. Disinformazione è verità, controllo è sicurezza, aggressione è autodifesa: la neolingua che prepara alla guerra.
C’è un filo rosso che attraversa questi anni e che si tende sempre di più, quasi a volerci soffocare: il controllo del linguaggio come forma di governo. Lo aveva immaginato Orwell con la neolingua, ma quello che abbiamo davanti agli occhi è un’operazione ben più sofisticata: non è solo la riduzione del vocabolario, è la riscrittura del senso, l’inversione semantica, la trasformazione delle parole in trappole.
La neolingua del potere
La tecnica è sempre la stessa: prendi un concetto, svuotalo, sostituiscilo, rovescialo. Alla triade orwelliana “Guerra è pace / Libertà è schiavitù / Ignoranza è forza”, oggi si affianca quella transnazionale del potere senza nome e senza faccia: Disinformazione è Verità, Controllo è Sicurezza. Aggressione è Autodifesa.
Un processo che non nasce oggi: ha iniziato a infiltrarsi quasi in sordina durante il Covid, quando l’immaginario bellico, la trincea, la prima linea, il nemico invisibile, ha colonizzato la narrazione pubblica. Era il primo passo: introdurre un linguaggio di guerra in un contesto non bellico, normalizzarne la sintassi, abituare l’orecchio.
Poi è arrivata l’Ucraina: la guerra con al comando un attore che prima di diventarlo nella realtà, è stato presidente in una serie TV. Con Zelensky, interprete e portavoce del dramma, la guerra è diventata un talk show infinito, come hanno osservato numerosi analisti dei media. Un distopico intrattenimento politico permanente. Non importava più capire, ma schierarsi. O Slava Ukraini o putiniano. La propaganda ha fatto un nuovo salto di qualità: non solo si è militarizzato il lessico, ma si è santificata la guerra, rendendo sospetta perfino la parola “negoziato”.
Nel giro di pochi mesi l’idea stessa di diplomazia – la spina dorsale del diritto internazionale – è stata dipinta come debolezza morale. Chi parlava di trattative veniva etichettato come “filorusso”, “pacifinto”, “utile idiota”. Ed è ancora così.
Le tre fasi del consenso
Lo dimostra l’ultima dichiarazione fatta dal presidente del comitato militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone qualche giorno fa: secondo lui l’Alleanza dovrebbe diventare “più aggressiva”, persino valutare “misure preventive” nei confronti della Russia. E quel “preventive” è la parola chiave: una parola che scivola via dolcemente nell’orecchio, come se fosse una misura profilattica, un vaccino geopolitico, qualcosa che si fa “per evitare guai”.
Ma la verità è brutale: un attacco preventivo a una potenza nucleare equivale a una dichiarazione di guerra. Lo capirebbe anche un bambino. Eppure, generali, editorialisti, ministri, pronunciano quella formula, guerra preventiva, con l’innocenza artificiale di chi sa perfettamente cosa sta facendo: normalizzare l’anomalia. Intanto, sulle testate mainstream campeggiano titoli che ancora una volta ribaltano la realtà, riportando una reazione come se fosse un attacco: “La Russia dichiara guerra all’Europa”.
Questa è la neolingua del presente: non più un meccanismo letterario, ma un dispositivo operativo, una tecnologia del consenso che prepara i cittadini a fuoco lento portandoli ad accettare l’inaccettabile. È un processo a tre stadi: il primo introduce le metafore della guerra anche dove non esistono; il secondo rende la guerra un’opzione legittima, quasi inevitabile; il terzo ribalta i significati, fino a far sembrare “difensivo” ciò che è aggressivo, “necessario” ciò che è suicida. È così che si prepara una popolazione alla catastrofe: non con le armi, ma con le parole.
Gaza, il punto di ebollizione
E oggi siamo arrivati al punto culminante di cottura della rana bollita: Gaza. Qui la distorsione linguistica ha superato perfino la fantasia distopica di Orwell. La realtà è stata sovvertita in diretta, alla luce del sole, con una sfacciataggine che fa quasi paura: i bambini uccisi vengono giustificati con l’accusa mai provata di essere usati come “scudi umani” da Hamas; la fame, provocata deliberatamente da Israele, viene ribaltata come accusa su Hamas, che sottrarrebbe viveri e rifornimenti per arricchirsi; la distruzione sistematica di un popolo viene presentata come “legittima difesa” di un altro che deve difendersi da Hamas che vuole distruggerlo.
Narrazioni costruite a tavolino, non fatti. Non esiste una sola prova concreta di quel che dice l’IDF, né sugli ospedali che secondo loro nascondono centri militari, né sui centri umanitari usati da Hamas come ricovero di armi e di uomini, né sui presunti “bunker” sotto le scuole. Più realisticamente, suonano come mistificazioni utili a coprire un progetto di annientamento che risponde alla definizione della Convenzione ONU sul genocidio («sterminare in tutto o in parte» un gruppo), e che colpisce soprattutto i bambini perché rappresentano il futuro demografico dei palestinesi.
Criticare Israele è davvero un crimine?
Si. Ogni critica a Israele e all’ideologia sionista è stata trasformata in antisemitismo, una manipolazione calcolata che non serve a proteggere gli ebrei ma a silenziare qualunque dissenso politico, storico, etico. Il linguaggio è diventato una gabbia. E nella gabbia, oggi, hanno deciso di chiudere anche la politica estera. Non a caso negli ultimi mesi in Italia sono fioccate proposte di legge volte ad adottare la controversa definizione operativa di “antisemitismo” fissata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), una definizione molto criticata perché, di fatto, livella ed equipara la critica politica allo stato di Israele all’odio razziale e religioso.
Il più noto è il DDL 1627, presentato al Senato a ottobre 2025 dal senatore Maurizio Gasparri, che mira a rendere vincolante per scuole, università e istituzioni pubbliche la definizione IHRA, compresi i suoi “esempi esplicativi” che equiparano critica a Israele o sostegno alla causa palestinese ad antisemitismo. Un secondo testo, a firma del senatore della Lega Massimiliano Romeo, propone analoghe misure restrittive sotto la “lotta all’antisemitismo” ed è segnalato come potenziale “bavaglio al dissenso”. Un terzo disegno, il DDL S.1575, presentato da un esponente di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, si trova attualmente in commissione e propone analoghe misure, finalizzate all’adozione della definizione IHRA.
Tutte queste proposte, pur con dettagli diversi, condividono la stessa matrice: rendere giuridico e sanzionabile ciò che secondo la definizione IHRA può ricadere sotto “antisemitismo”, inclusa la critica politica allo Stato di Israele e al sionismo. L’equiparazione sistematica di “antisionismo = antisemitismo” è non solo una pericolosa deriva antidemocratica e verso una plateale manipolazione delle radici delle parole, ma rischia di trasformare il dissenso in crimine, in reato politico semplici opinioni, analisi, reportage, manifestazioni, con conseguenze concrete e imprevedibili su libertà di espressione, di ricerca, di insegnamento. L’approvazione di uno o più di questi ddl significherebbe non solo un controllo semantico sui media o sulla piazza, ma un’effettiva regolamentazione del pensiero critico. Questo non è accanimento retorico: è una strategia politica repressiva che si serve della legge per imporre un confine invalicabile tra ciò che è lecito dire e ciò che invece è reato anche solo pensare.
Asimmetrie morali
Ma la distorsione linguistica non si ferma qui: produce effetti tangibili, immediati, mostruosi. Soprattutto, produce una gerarchia morale in cui alcune vite contano infinite volte più di altre. Lo si è visto pochi giorni fa: Fadi e Jumaa, due fratellini palestinesi, 9 e 12 anni, sono stati uccisi da un drone israeliano nella Striscia di Gaza mentre raccoglievano legna. Non c’era alcuno scontro, nessun combattente, nessuna “minaccia”. Solo due bambini che avevano osato superare una linea immaginaria di sicurezza imposta da Israele. Colpiti, dilaniati, cancellati. La notizia è scivolata presto nei feed come un rumore di fondo: nessuna apertura dei telegiornali, nessun editoriale furibondo, nessun comunicato dell’Unione europea, nessun cordoglio istituzionale. Un massacro classificato come “incidente”, cioè come rumore.
A due giorni di distanza, a Roma, sono apparse quattro scritte su un muro accanto alla Sinagoga di Monteverde e sulla targa dedicata al piccolo Stefano Taché, il bambino di due anni ucciso nell’attentato al Tempio di Roma del 1982. In un attimo si è scatenato l’inferno: conferenze stampa, dichiarazioni furibonde della Comunità ebraica, del sindaco, della Regione, del Presidente della Repubblica Mattarella, che pure sui bambini palestinesi aveva taciuto. Nulla da eccepire, gli atti vandalici vanno condannati senza esitazioni. Ma è l’asimmetria che sconcerta. È la sproporzione etica che si inserisce perfettamente nella logica della neolingua: la parola incisa sul muro diventa più grave di un bambino vaporizzato da un drone.
Quando il linguaggio annienta la realtà, tutto diventa possibile
Questo è il punto di non ritorno. Un mondo in cui quattro scritte indignano più dell’esecuzione di due bambini non è un mondo confuso: è un mondo perso, alla deriva, programmato per non vedere il naufragio. È un mondo in cui il linguaggio non descrive più la realtà, la annienta. E quando ciò accade, tutto diventa possibile: l’impunità, il rovesciamento dei significati, la repressione del dissenso, perfino la criminalizzazione di chi ancora si ostina a dire che due bambini morti valgono più di una vernice su un muro.
La realtà è stata messa fuorilegge. Siamo a un passo dal rendere, stavolta per davvero, come scriveva Orwell, il crimine di pensiero un reato perseguibile. E allora sì: il filo rosso che parte dal Covid, attraversa l’Ucraina e arriva a Gaza, non è solo un mutamento del linguaggio. È la costruzione di un sistema politico che ha deciso di governare non attraverso la verità, ma attraverso il controllo del senso. Disinformazione è Verità, Controllo è Sicurezza. Aggressione è Autodifesa. E questo, più di ogni altra cosa, dovrebbe farci paura.



 gmail.com
gmail.com Like
Like 






































Del resto, ciascuno è libero di smentire le mie osservazioni coll'arma della critica, magari trascorrendo dal vernacolo da bari dello sport - le "sciocchezze" - ad argomentazioni concettualmente acribiche e dottrinariamente articolate.
Non crediamo nella parola.
Noi chi?