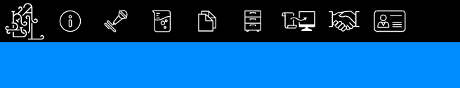Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1335
La temperie moderna sullo sfondo de L’uomo senza qualità
di Alvise Marin
 La parabola del moderno, il cui delinearsi lasciava intravedere esiti trionfalistici, tende invece a chiudersi con un momento terminale di crisi. Quest’ultima si manifesta nel cambiamento della percezione che l’individuo ha di sé, ma altresì nel modificarsi del tessuto connettivo della società. L’uomo tende a non cogliere più il proprio Ego come il centro delle proprie azioni e queste ultime, orfane di un autore, gli accadono suo malgrado e lo sorprendono quasi non gli appartenessero. Eccentrico rispetto a un centro che non c’è, egli cerca la sua vera identità nel rifrangersi di quest’ultima negli innumerevoli ruoli che la società gli confeziona addosso. Società, che del resto, è diventata un palcoscenico, sul quale si avvicendano ruoli, idee e visioni del mondo diversi, nessuno dei quali possiede però la forza di impadronirsi della scena; di qui il continuo stato di sommovimento in cui essa si trova e la sua tendenza a destrutturarsi.
La parabola del moderno, il cui delinearsi lasciava intravedere esiti trionfalistici, tende invece a chiudersi con un momento terminale di crisi. Quest’ultima si manifesta nel cambiamento della percezione che l’individuo ha di sé, ma altresì nel modificarsi del tessuto connettivo della società. L’uomo tende a non cogliere più il proprio Ego come il centro delle proprie azioni e queste ultime, orfane di un autore, gli accadono suo malgrado e lo sorprendono quasi non gli appartenessero. Eccentrico rispetto a un centro che non c’è, egli cerca la sua vera identità nel rifrangersi di quest’ultima negli innumerevoli ruoli che la società gli confeziona addosso. Società, che del resto, è diventata un palcoscenico, sul quale si avvicendano ruoli, idee e visioni del mondo diversi, nessuno dei quali possiede però la forza di impadronirsi della scena; di qui il continuo stato di sommovimento in cui essa si trova e la sua tendenza a destrutturarsi.
Se questa è la temperie in cui langue la modernità dei primi decenni del Novecento, questo è anche il panorama della Vienna descritta da Robert Musil nel suo capolavoro incompiuto, L’uomo senza qualità. Ulrich, il personaggio principale del romanzo, è proprio un uomo come quello descritto sopra e la società in cui vive è proprio sul punto di disgregarsi.
Per spiegare questa trasformazione sociale e mentale, è necessario partire, in ambito filosofico, dal soggetto cartesiano, il quale nasce radicando la sua certezza nel Cogito e pensandosi nella sua unità sostanziale. In Cartesio il soggetto è l’autore dei propri pensieri e delle proprie azioni ed è dotato di un centro inamovibile.
- Details
- Hits: 1057
Dialettica dell’irrazionalismo
di Enzo Traverso
Da Dialettica dell’irrazionalismo. Lukács tra nazismo e stalinismo, Ombre Corte, Verona 2022
 Paradossalmente, ciò che manca ne La distruzione della ragione è l’irrazionalismo nazista. Dopo aver dedicato centinaia di pagine a spiegare come la maggior parte delle correnti della filosofia tedesca si fossero così profondamente allontanate dall’eredità dell’Aufklälrung, il libro non cerca di studiare la loro incorporazione in una nuova forma razzista e imperialista di irrazionalismo. Non dedica alcun capitolo alla Weltanschauung nazista, che viene quasi ignorata ad eccezione, come abbiamo visto, di alcune citazioni tratte da Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts di Alfred Rosenberg. Lukács insiste fin dall’inizio sul fatto che, invece di seguire una dinamica interna e “immanente”, la storia dell’irrazionalismo dovrebbe essere messa in relazione con alcune tendenze strutturali del capitalismo tedesco, ma non sembra molto interessato ad analizzare il modo in cui nichilismo, anti-umanesimo, razzismo, nazionalismo e imperialismo siano infine confluiti in una nuova ideologia sincretica. Egli segue il percorso del razzismo europeo da Gobineau a Rosenberg, passando per Gumplowicz, Woltmann e Chamberlain, cioè da un razzismo contemplativo a un razzismo “rigenerativo” che accoglieva le istanze del darwinismo sociale, ma non esamina la nascita di una nuova teoria razziale fondata sul “nordicismo”, l’eugenetica e una nuova concezione geopolitica – biologista e vitalista – dello “spazio vitale” (Lebensraum). Così, i nomi di Hans Günther, il pensatore ufficiale del razzismo nazista (Rassenkunde), Karl Haushofer, il geografo che teorizzò l’espansionismo tedesco in Europa orientale, e Friedrich Ratzel, il geografo del XIX secolo che forgiò il concetto di “spazio vitale”, non appaiono nel libro di Lukács.
Paradossalmente, ciò che manca ne La distruzione della ragione è l’irrazionalismo nazista. Dopo aver dedicato centinaia di pagine a spiegare come la maggior parte delle correnti della filosofia tedesca si fossero così profondamente allontanate dall’eredità dell’Aufklälrung, il libro non cerca di studiare la loro incorporazione in una nuova forma razzista e imperialista di irrazionalismo. Non dedica alcun capitolo alla Weltanschauung nazista, che viene quasi ignorata ad eccezione, come abbiamo visto, di alcune citazioni tratte da Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts di Alfred Rosenberg. Lukács insiste fin dall’inizio sul fatto che, invece di seguire una dinamica interna e “immanente”, la storia dell’irrazionalismo dovrebbe essere messa in relazione con alcune tendenze strutturali del capitalismo tedesco, ma non sembra molto interessato ad analizzare il modo in cui nichilismo, anti-umanesimo, razzismo, nazionalismo e imperialismo siano infine confluiti in una nuova ideologia sincretica. Egli segue il percorso del razzismo europeo da Gobineau a Rosenberg, passando per Gumplowicz, Woltmann e Chamberlain, cioè da un razzismo contemplativo a un razzismo “rigenerativo” che accoglieva le istanze del darwinismo sociale, ma non esamina la nascita di una nuova teoria razziale fondata sul “nordicismo”, l’eugenetica e una nuova concezione geopolitica – biologista e vitalista – dello “spazio vitale” (Lebensraum). Così, i nomi di Hans Günther, il pensatore ufficiale del razzismo nazista (Rassenkunde), Karl Haushofer, il geografo che teorizzò l’espansionismo tedesco in Europa orientale, e Friedrich Ratzel, il geografo del XIX secolo che forgiò il concetto di “spazio vitale”, non appaiono nel libro di Lukács.
- Details
- Hits: 1610
Il Nietzsche metafisico di Heidegger
di Gianni Vattimo*
Martin Heidegger, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, ed. orig. 1961, trad. dal tedesco di Franco Volpi.
 Nei corsi universitari degli anni ‘36-40 e negli altri testi (degli stessi anni) che sono raccolti nel volume su Nietzsche Heidegger legge il pensiero di Nietzsche in maniera del tutto originale rispetto alle interpretazioni che ne erano state date nei decenni precedenti, e che, sebbene avessero colto in generale il significato globale e radicale della critica nietzscheana, non aveva mai preso così intensamente sul serio la “pretesa” del filosofo di rappresentare una svolta epocale nella storia dello spirito europeo. Espressioni come quella che fa da titolo a un capitolo di Ecce homo, “Perché io sono un destino”, il più delle volte erano arse da mettere sul conto dell’incipiente pazzia di Nietzsche. Heidegger le prende invece sul serio, a modo suo; e proprio per questo la sua lettura di Nietzsche innova profondamente rispetto a quelle precedenti, anche quando abbiano la densità speculativa dello studio di Jaspers (uscito nel 1936) o di quello di Alfred Baeumler (forse troppo ingiustamente messo da parte, oggi, come nazista, uscito nel 1931). Il punto è che Nietzsche era stato generalmente inteso, prima di Heidegger, come un critico della Zivilisation o, secondo l’espressione di Dilthey, come un Lebensphilosoph — che non significa anzitutto un “filosofo vitali, ma un pensatore “esistenziale”, che non crede più alla filosofia come metafisica, come teoria generale dell’essere, ma che la esercita come una riflessione personale, spesso di carattere saggistico, secondo un modello che risale a Montaigne o anche al pensiero della tarda antichità.
Nei corsi universitari degli anni ‘36-40 e negli altri testi (degli stessi anni) che sono raccolti nel volume su Nietzsche Heidegger legge il pensiero di Nietzsche in maniera del tutto originale rispetto alle interpretazioni che ne erano state date nei decenni precedenti, e che, sebbene avessero colto in generale il significato globale e radicale della critica nietzscheana, non aveva mai preso così intensamente sul serio la “pretesa” del filosofo di rappresentare una svolta epocale nella storia dello spirito europeo. Espressioni come quella che fa da titolo a un capitolo di Ecce homo, “Perché io sono un destino”, il più delle volte erano arse da mettere sul conto dell’incipiente pazzia di Nietzsche. Heidegger le prende invece sul serio, a modo suo; e proprio per questo la sua lettura di Nietzsche innova profondamente rispetto a quelle precedenti, anche quando abbiano la densità speculativa dello studio di Jaspers (uscito nel 1936) o di quello di Alfred Baeumler (forse troppo ingiustamente messo da parte, oggi, come nazista, uscito nel 1931). Il punto è che Nietzsche era stato generalmente inteso, prima di Heidegger, come un critico della Zivilisation o, secondo l’espressione di Dilthey, come un Lebensphilosoph — che non significa anzitutto un “filosofo vitali, ma un pensatore “esistenziale”, che non crede più alla filosofia come metafisica, come teoria generale dell’essere, ma che la esercita come una riflessione personale, spesso di carattere saggistico, secondo un modello che risale a Montaigne o anche al pensiero della tarda antichità.
- Details
- Hits: 2234
In terra ostile: il destino della modernità occidentale e i suoi critici
di Carlo Magnani
 Il pubblico de “La fionda” è costituito per lo più da persone che – come lo scrivente – “vengono” da sinistra, si sono cioè formate sui testi e sui temi classici della sinistra novecentesca, votandone i partiti storici o le frattaglie derivanti da scissioni e rifondazioni varie. Tutte queste persone sono però altamente insoddisfatte della sinistra, in tutte le sue varianti, nella sua configurazione attuale: europeismo a prescindere, oblio dei diritti sociali e precarizzazione del lavoro, atlantismo “senza se e senza ma”, sono alcuni dei punti di forte critica verso la narrazione progressista. Questo pubblico può risultare, al massimo dell’eresia, ben propenso verso il “momento populista”, vedendo nell’attenzione a temi socialmente sentiti da larghe masse della popolazione collocate fuori dalla fatidica “Ztl” una opportunità per ri-creare finalmente una “vera” sinistra. Questa breve premessa solo per illustrare che il compito che mi sono dato – segnalare ai lettori de “La fionda” il libro di Boni Castellane “In terra ostile” – è una impresa ardua, che va però compiuta. Come sostenere di fronte a tale comunità la bontà di una riflessione che si colloca del tutto al di fuori dei margini del perimetro della sinistra, anzi, che sta proprio dalla parte opposta?
Il pubblico de “La fionda” è costituito per lo più da persone che – come lo scrivente – “vengono” da sinistra, si sono cioè formate sui testi e sui temi classici della sinistra novecentesca, votandone i partiti storici o le frattaglie derivanti da scissioni e rifondazioni varie. Tutte queste persone sono però altamente insoddisfatte della sinistra, in tutte le sue varianti, nella sua configurazione attuale: europeismo a prescindere, oblio dei diritti sociali e precarizzazione del lavoro, atlantismo “senza se e senza ma”, sono alcuni dei punti di forte critica verso la narrazione progressista. Questo pubblico può risultare, al massimo dell’eresia, ben propenso verso il “momento populista”, vedendo nell’attenzione a temi socialmente sentiti da larghe masse della popolazione collocate fuori dalla fatidica “Ztl” una opportunità per ri-creare finalmente una “vera” sinistra. Questa breve premessa solo per illustrare che il compito che mi sono dato – segnalare ai lettori de “La fionda” il libro di Boni Castellane “In terra ostile” – è una impresa ardua, che va però compiuta. Come sostenere di fronte a tale comunità la bontà di una riflessione che si colloca del tutto al di fuori dei margini del perimetro della sinistra, anzi, che sta proprio dalla parte opposta?
Boni Castellane è un nome di fantasia, impiegato da un opinionista che scrive sul quotidiano “LaVerità”: il successo della rubrica ha dato l’abbrivio per una iniziativa editoriale sfociata nella pubblicazione del libretto titolato appunto “In terra ostile”. A sentire l’anonimo Autore, molto attivo su X (ex Twitter), le vendite hanno ad oggi raggiunto, dopo una seconda edizione, quota 15.000, che non solo per la saggistica ma anche per la narrativa costituisce per il mercato nazionale una quota quasi eccezionale: nessun giornale o media ne ha chiaramente parlato.
- Details
- Hits: 1891
Mario Tronti: il Regno, se noi lo vogliamo
di Marcello Tarì
 Vi ho voluto bene, adesso vado
Vi ho voluto bene, adesso vado
Sono stato un comunista
Avevo un sogno, una speranza
Arrivederci amore, addio (Baustelle, L’uomo del secolo).
Mario Tronti è morto il 7 agosto, nella sua casa di Ferentillo, a 92 anni da poco compiuti; un’«età da patriarchi» disse per i 90 anni di Ingrao[1], così come poi dovette dire di sé stesso con un pizzico della sua consueta ironia, tagliente e dolce allo stesso tempo.
Per buona parte del piccolo e grande pubblico, il suo nome è legato al suo primo e giovanile libro, Operai e capitale, pubblicato da Einaudi nel 1966[2], che fu in seguito definito «la bibbia dell’operaismo». Un libro che, comunque lo si voglia giudicare, segnò, a ridosso del ’68, e specialmente delle grandi lotte operaie del 1969, una grande novità ma anche una forte rottura teorica nel marxismo del secondo Novecento, questo secolo duro e difficile a cui lui è sempre rimasto fedele.
L’opera prima
In quelle pagine Tronti compiva infatti la cosiddetta «rivoluzione copernicana» nell’interpretazione del conflitto epocale tra capitale e lavoro: prima viene il soggetto operaio e le sue lotte, dopo il capitale e il suo sviluppo; quindi, al partito va la tattica, al movimento operaio la strategia, proprio quella che in uno dei passaggi più celebri e densi di conseguenze chiamò la «strategia del rifiuto».
C’era già, a ben guardare, in quel rovesciamento di prospettiva, un aspetto della radicalità evangelica a cui più tardi Tronti avrebbe fatto direttamente riferimento: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi.
- Details
- Hits: 1455
Gramsci e Benjamin, la lotta contro la catastrofe
Salvatore Cannavò intervista Dario Gentili
Un libro confronta le idee dei due pensatori eterodossi, entrambi critici del progresso come arma ideologica della conservazione. Due interpreti della controrivoluzione sempre aperti alla possibilità di un’alternativa
 Potrebbe essere uno dei lavori inediti a livello internazionale che mettono a confronto il pensiero di Walter Benjamin con quello di Antonio Gramsci. Un incontro mancato: Walter Benjamin e Antonio Gramsci (a cura di Dario Gentili, Elettra Stimilli e Gabriele Guerra, 268 pgg. 21 euro, Quodlibet) è un volume collettaneo che affronta sostanzialmente quattro filoni: «Filosofia della storia e materialismo storico»; «Rivoluzione, controrivoluzione, rivoluzione passiva»; «Modi capitalisti di produzione e produzione di soggettività»; «Traduzione e critica, avanguardia e cultura popolare». Il libro è poi completato da un’introduzione redatta dai curatori. Ne abbiamo discusso con Dario Gentili, che insegna Filosofia morale all’Università di Roma Tre e che all’opera di Benjamin ha dedicato diversi scritti.
Potrebbe essere uno dei lavori inediti a livello internazionale che mettono a confronto il pensiero di Walter Benjamin con quello di Antonio Gramsci. Un incontro mancato: Walter Benjamin e Antonio Gramsci (a cura di Dario Gentili, Elettra Stimilli e Gabriele Guerra, 268 pgg. 21 euro, Quodlibet) è un volume collettaneo che affronta sostanzialmente quattro filoni: «Filosofia della storia e materialismo storico»; «Rivoluzione, controrivoluzione, rivoluzione passiva»; «Modi capitalisti di produzione e produzione di soggettività»; «Traduzione e critica, avanguardia e cultura popolare». Il libro è poi completato da un’introduzione redatta dai curatori. Ne abbiamo discusso con Dario Gentili, che insegna Filosofia morale all’Università di Roma Tre e che all’opera di Benjamin ha dedicato diversi scritti.
* * * *
Qual è l’intuizione originaria di questo lavoro che voi stessi considerate «il primo che a livello internazionale cerca di mettere a confronto il pensiero di Gramsci e Benjamin»?
L’operazione è nata innanzitutto dalla discussione avvenuta nell’Associazione Italiana Walter Benjamin [i tre curatori fanno parte del Consiglio direttivo e Guerra ne è il presidente, N.d.R.], che da diversi anni propone letture attuali, anche in senso politico, del pensiero benjaminiano. Questo approccio a Benjamin ha finito per incontrare l’interesse che alcuni di noi nutrono anche per Gramsci. A colpire innanzitutto, dei due grandi pensatori, è l’elemento biografico: si tratta di due coetanei, il cui destino, tra il 1937 e il 1940, è piuttosto simile, entrambi vittime del nazi-fascismo, suicida in Spagna Benjamin mentre cerca di fuggire dai nazisti e ucciso in carcere Gramsci dal Fascismo.
- Details
- Hits: 1593

Pecorismo cerimoniale
di Salvatore Bravo
 Ci sono filosofi intramontabili, perché hanno testimoniato e vissuto la filosofia della prassi. L’appellativo di filosofo in un’epoca di “pecorismo cerimoniale” è inflazionato. Si elargiscono generosamente titoli onorifici, in modo che gli “intellettuali incoronati” possano far cadere le loro parole sulla massa come ambrosia. Si tratta di una tecnica per consentire il silenzio dei sudditi, i quali devono nutrirsi dei dogmi degli intellettuali organici al capitalismo assoluto. Si tratta di figure che reiterano con le loro parole il sistema, lo consolidano fino a rendere il “capitalismo assoluto” una divinità totemica a cui niente e nessuno può sfuggire. Il pecorismo cerimoniale (oratores nel linguaggio di Costanzo Preve) ha il compito di annichilire la prassi e la speranza. Gli oratores sono i testimoni di un’epoca astratta, quasi dei neoplatonici, in quanto rappresentano il tempo contemporaneo come aspaziale e atemporale. Tempo che non passa, pertanto resilienza e libero adattamento coercitivo sono la ricetta per integrarsi e sopportare l’insopportabile. Il fatalismo è il figlio degenere del pecorismo cerimoniale.
Ci sono filosofi intramontabili, perché hanno testimoniato e vissuto la filosofia della prassi. L’appellativo di filosofo in un’epoca di “pecorismo cerimoniale” è inflazionato. Si elargiscono generosamente titoli onorifici, in modo che gli “intellettuali incoronati” possano far cadere le loro parole sulla massa come ambrosia. Si tratta di una tecnica per consentire il silenzio dei sudditi, i quali devono nutrirsi dei dogmi degli intellettuali organici al capitalismo assoluto. Si tratta di figure che reiterano con le loro parole il sistema, lo consolidano fino a rendere il “capitalismo assoluto” una divinità totemica a cui niente e nessuno può sfuggire. Il pecorismo cerimoniale (oratores nel linguaggio di Costanzo Preve) ha il compito di annichilire la prassi e la speranza. Gli oratores sono i testimoni di un’epoca astratta, quasi dei neoplatonici, in quanto rappresentano il tempo contemporaneo come aspaziale e atemporale. Tempo che non passa, pertanto resilienza e libero adattamento coercitivo sono la ricetta per integrarsi e sopportare l’insopportabile. Il fatalismo è il figlio degenere del pecorismo cerimoniale.
Costanzo Preve non fu tutto questo. Il filosofo del capitalismo assoluto e della deduzione sociale delle categorie fu un resistente in perenne esodo dalle asfissianti categorie ideologiche del nostro tempo. Dove vi è filosofia vi è il coraggio del nuovo. Il rischio è grande, i risultati non sono assicurati, ma non vi è filosofo che non abbia il coraggio etico e veritativo di intraprendere un percorso autonomo.
Il dominio marginalizza i pensatori liberi, poiché essi dimostrano che è possibile uscire dai binari del politicamente corretto nel rispetto della natura umana razionale ed etica.
- Details
- Hits: 2399
In difesa dell’umano: corpo e intelligenza artificiale
di Luciano De Fiore e Roberto Finelli
 L’essere umano accede alla rappresentazione attraverso il sentire corporeo ed emozionale, perciò la nostra è una mente incarnata. Contro i tecno-profeti dell’IA che annunziano un futuro liberato dai limiti della materialità del corpo bisogna riaffermare il fondamento biologico-animale della vita umana e la funzione ineliminabile del linguaggio. Conversazione con Roberto Finelli.
L’essere umano accede alla rappresentazione attraverso il sentire corporeo ed emozionale, perciò la nostra è una mente incarnata. Contro i tecno-profeti dell’IA che annunziano un futuro liberato dai limiti della materialità del corpo bisogna riaffermare il fondamento biologico-animale della vita umana e la funzione ineliminabile del linguaggio. Conversazione con Roberto Finelli.
* * * *
Luciano De Fiore (LDF) – L’intelligenza artificiale generativa sembra basarsi del tutto sul nutrimento che riceve dal web: anche i computer quantici mimano l’intelligenza elaborando quantità insondabili di dati e ricavandone modelli. Così, ChatGPT è in grado di scrivere un saggio di livello passabile su quasi ogni argomento, anche in ambito medico-sanitario, come DALL-E 2 è in grado di produrre immagini alla Picasso avendo analizzato e metabolizzato qualcosa come l’intera storia dell’arte. Più le macchine si allenano, più appaiono intelligenti. Di cosa mancano perché le si possa considerare soggetti a pieno titolo, magari dotati di una psiche e moralmente imputabili?
Roberto Finelli (RF) – La differenza di fondo tra una macchina e un organismo vivente è che la prima è costituita da un assemblaggio di parti, da un insieme di pezzi che vengono collegati tra loro uno dopo l’altro, dopo essere stati concepiti e costruiti come ciascuno a sé stante, mentre un organismo vivente è un corpo profondamente unitario, fin dalla sua nascita. L’organismo umano nasce da una sola cellula, l’ovulo fecondato, che si sviluppa moltiplicandosi e differenziandosi, mantenendo come scopo primario della sua attività la riproduzione e la salvaguardia della sua unità.
- Details
- Hits: 1768
Nietzsche nel laboratorio teorico di Domenico Losurdo. Una proposta di rilettura
di Francesco Fistetti (Università di Bari)
 1. La critica della modernità coloniale: Domenico Losurdo e i postcolonialisti
1. La critica della modernità coloniale: Domenico Losurdo e i postcolonialisti
È ormai universalmente riconosciuto che uno dei filoni di ricerca che Domenico Losurdo ha fino alla fine coltivato è quello della questione coloniale. Al punto che essa, a suo avviso, può essere considerata il centro focale della Grande Divisione tra marxismo orientale e marxismo occidentale (come Mimmo mostra nel suo ultimo importante libro pubblicato in vita nel 20171). Altrove ho avuto modo di argomentare che la questione coloniale oltrepassa la dicotomia marxismo orientale/marxismo occidentale, dal momento che diviene una griglia epistemologica del tutto inedita attraverso la quale è possibile rileggere l’intera storia della moderna cultura occidentale e, per questa via, cogliere i limiti del marxismo come paradigma scientifico e come guida per l’agire politico. Su questo terreno la convergenza di Losurdo con gli studi postcoloniali e subalternisti è un dato innegabile, anche se finora del tutto sottovalutato e sottaciuto: il terreno comune è la centralità della questione coloniale come ermeneutica della modernità e chiave privilegiata di ricostruzione della sua storia. Per l’uno e gli altri la modernità occidentale non può essere adeguatamente esplorata se non si tiene conto di ciò che il colonialismo e l’imperialismo hanno significato sia per l’affermazione del modo di produzione capitalistico nelle metropoli europee, sia per l’edificazione degli Stati nazionali. Una lettura incrociata di Controstoria del liberalismo (2005), e dei testi più significativi dei postcolonialisti, a cominciare dal testo seminale di E. Said, Orientalismo (1978), fino ad autori come Homi Bhabha, Gayatri Ch. Spivak, Achille Mbembe o a quell’area pluridisciplinare che include molti autori dell’America latina come Enrique Dussel, Anibal Quijano, Walter Mignolo, Boaventura De Sousa Santos, una lettura incrociata, dicevo, evidenzierebbe un’aria di famiglia attorno al ruolo cruciale che la questione coloniale ha giocato nella formazione della coscienza moderna.
- Details
- Hits: 1224
Filosofie della simulazione: le “più realtà” di Chalmers
di Roberto Paura
Il filosofo della mente David Chalmers sul tema della realtà virtuale e l’argomento della simulazione
 Sono trascorsi esattamente trent’anni tra l’uscita del ponderoso tomo di David Chalmers Più realtà (2022 nell’edizione originale) e due testi che nel 1992 provarono a riflettere sulle conseguenze filosofiche e sociali della realtà virtuale: Reale e virtuale di Tomás Maldonado e Mondi virtuali di Benjamin Woolley. Lettrici e lettori ci scuseranno dunque se nella prima parte di questo articolo, anziché entrare da subito nel discorso dell’ultima fatica di Chalmers, noto filosofo della mente che già da tempo lavora sul tema della simulazione, cercheremo innanzitutto di capire cosa sia successo in questi trent’anni nel discorso sulla realtà virtuale (VR).
Sono trascorsi esattamente trent’anni tra l’uscita del ponderoso tomo di David Chalmers Più realtà (2022 nell’edizione originale) e due testi che nel 1992 provarono a riflettere sulle conseguenze filosofiche e sociali della realtà virtuale: Reale e virtuale di Tomás Maldonado e Mondi virtuali di Benjamin Woolley. Lettrici e lettori ci scuseranno dunque se nella prima parte di questo articolo, anziché entrare da subito nel discorso dell’ultima fatica di Chalmers, noto filosofo della mente che già da tempo lavora sul tema della simulazione, cercheremo innanzitutto di capire cosa sia successo in questi trent’anni nel discorso sulla realtà virtuale (VR).
Le estati e gli inverni della VR
Nel discorso tecnologico possiamo usare per la VR alcuni elementi caratteristici del discorso sull’intelligenza artificiale (IA). Entrambi sono caratterizzati dal succedersi di cicli di hype e di “inverni”: gli studiosi riconoscono due “inverni dell’IA”, rispettivamente negli anni Settanta e nel periodo a cavallo tra la seconda metà degli anni Ottanta e la prima metà dei Novanta, in cui a facili entusiasmi seguirono altrettante delusioni e frenate; i cicli di hype sono stati invece, finora, tre: quello inaugurato dalla celebre conferenza di Dartmouth (1956), in cui si credeva di poter risolvere i principali problemi dell’IA entro “un semestre”, sulla scorta del già da tempo scricchiolante edificio della logica simbolica; quello degli anni Ottanta, con lo sviluppo dei sistemi esperti e i primi esperimenti di reti neurali; quello a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, con la rivoluzione del machine learning consolidata poi dall’accesso all’immenso oceano dei Big Data per addestrare gli algoritmi evolutivi (Russell e Norvig, 2021).
- Details
- Hits: 1265
Ecosistemi cognitivi
Ovvero l’individuo come rete autopoietica
di Raffaele Guarino
 “Il mondo è come te lo metti in testa”
“Il mondo è come te lo metti in testa”
Nel film Everything everywhere all at once, la protagonista scopre l’esistenza di alcuni universi paralleli generati dopo ogni scelta avvenuta nel corso della sua vita. Ognuno di questi rappresenta una versione di lei che ha preso esattamente la decisione opposta. Attraverso una tecnologia sviluppata in uno di questi universi, Michelle Yeoh ha la possibilità di fare visita alle diverse versioni di sé e acquisirne le capacità e le competenze. Le sliding doors, come il trasferimento della mente in corpi diversi, rappresentano uno dei topoi più diffusi nel panorama fantascientifico e sono, per questa ragione, perfette rappresentazioni sia delle fantasie più diffuse che del metodo scientifico maggiormente affermato basato sulla separazione tra soggetto e oggetto. In questo caso, la trama del film è un utile stratagemma per mettere in risalto quei caratteri del pensiero che riguardano i concetti di individuo e degli universi spazio-temporali che questo attraversa. La possibilità di trasferimento della propria individualità in corpi diversi presuppone, infatti, la possibile separazione tra il processo cognitivo, affidato dall’immaginario collettivo al cervello, e la macchina motrice, ovvero il corpo. Non è un caso che nel film la tecnologia che consente il trasferimento sia un dispositivo da indossare proprio sulla testa. Da questa prospettiva, il sistema nervoso è la sede del governo centrale dell’individualità e può essere ospitato da diverse macchine corporee da utilizzare in base alle informazioni in suo possesso. In questa visione si presuppone anche che i prodotti dei processi cognitivi, come per esempio le abilità nella lotta, siano codificati in una sequenza di informazioni acquisibili da chiunque sia in grado di decifrarla.
- Details
- Hits: 1347
La speranza che diviene
di Neil Novello
 Quando scrive il suo libro forse più disperato, Realismo capitalista, da Spettri di Marx di Jacques Derrida Mark Fisher eredita una categoria: hauntology. È un concetto che vale un destino comunitario. Per il pensatore di Leicester, la cognizione esprime una nostalgia, appunto una malattia del ritorno. Essa però è rovesciata nel significato temporale e riqualificata come impossibilità a realizzarsi nella storia. Hauntology allora non si declina al passato, non è una nostalgia memoriale né consente una gratificazione finale, il possesso sentimentale, culturale dell’oggetto nostalgico. Per Fisher, il sovvertimento del passato si fa nostalgia del futuro ed essa appare senza speranza, vuota di ogni escatologia secolare, vacua. Ecco allora che hauntology ammette l’immagine di un futuro destoricizzato dell’accadente, un futuro perduto come perduta è la stessa possibilità di immaginarlo addirittura quale presenza di sé nel mondo.
Quando scrive il suo libro forse più disperato, Realismo capitalista, da Spettri di Marx di Jacques Derrida Mark Fisher eredita una categoria: hauntology. È un concetto che vale un destino comunitario. Per il pensatore di Leicester, la cognizione esprime una nostalgia, appunto una malattia del ritorno. Essa però è rovesciata nel significato temporale e riqualificata come impossibilità a realizzarsi nella storia. Hauntology allora non si declina al passato, non è una nostalgia memoriale né consente una gratificazione finale, il possesso sentimentale, culturale dell’oggetto nostalgico. Per Fisher, il sovvertimento del passato si fa nostalgia del futuro ed essa appare senza speranza, vuota di ogni escatologia secolare, vacua. Ecco allora che hauntology ammette l’immagine di un futuro destoricizzato dell’accadente, un futuro perduto come perduta è la stessa possibilità di immaginarlo addirittura quale presenza di sé nel mondo.
Nell’appendice a Speranza e utopia. Conversazioni 1964-1975 di Ernst Bloch, a cura di Rainer Traub e Harald Wieser, Mimesis, 2022, la soglia di Laura Boella, icastica e perentoria, richiama proprio un’immagine hauntologica. Specie quando la filosofa scrive che «“speranza” e “futuro”», nel «filosofo della speranza» e dell’«utopia concreta» esprimono un carattere di «incompiutezza», di naturale «incognito». Ma il sentimento del «non-ancora» come orizzonte del realizzabile appare già qualcosa di più aperto in confronto alla recisa, assoluta coscienza fisheriana del mai più. Le conversazioni blochiane pongono quindi un’estrema domanda, l’interrogazione ultimativa sul concreto significato dello sperare.
- Details
- Hits: 1399
De libertate: da Hegel a Corto Maltese
di Giuseppe Imperatore
 “Hegel è un pensatore aperto”, così argomenta Zizek alla presentazione del suo testo Hegel e il cervello postumano, e ancora: “più che il pensatore della sintesi, per me è il vero teorico dell’assioma che se pianifichi qualcosa, non importa quali sono i tuoi piani, le cose andranno sempre per il verso sbagliato. Un esempio viene offerto dalla rivoluzione francese, in cui la voglia di libertà è sfociata nel terrore. Rinconciliazione per Hegel non significa arrivare a un punto in cui va tutto bene, ma è il momento in cui ci si riappacifica con il fallimento”.
“Hegel è un pensatore aperto”, così argomenta Zizek alla presentazione del suo testo Hegel e il cervello postumano, e ancora: “più che il pensatore della sintesi, per me è il vero teorico dell’assioma che se pianifichi qualcosa, non importa quali sono i tuoi piani, le cose andranno sempre per il verso sbagliato. Un esempio viene offerto dalla rivoluzione francese, in cui la voglia di libertà è sfociata nel terrore. Rinconciliazione per Hegel non significa arrivare a un punto in cui va tutto bene, ma è il momento in cui ci si riappacifica con il fallimento”.
La sintesi non è luogo di appiattimento o di negazione delle profonde rotture e delle laceranti ferite, ma è manifestazione di queste nel loro ricomporsi.
La sintesi presuppone dunque una presa d’atto, per questo non si può rinunciare al soggetto, che è l’espressione non del vuoto compromesso, ma del pieno vivere dello Spirito nel mondo anche senza mediazioni alcune.
L’atto del sintetizzare non deriva dalla pura ragione, ma la supera, va ben oltre la stessa.
La Ragione che trova quindi fondamento nella non-Ragione, ovvero la verità noumenica come non tutto, o ancora più precisamente come eterna parzialità del Tutto.
Hegel non nasconde mai il negativo, anzi è il primo a farlo affiorare, quindi ne dà una lettura tendente al superamento (Aufhebung), così che si possa realizzare, in un punto di apparente quiete, il mondo.
Il moto si arresta solo per una frazione d’attimo e poi riprende la sua vorticosa ed incessante marcia.
- Details
- Hits: 1955
Un commento a: Roberto Finelli, Filosofia e tecnologia
di Alvise Marin
Roberto Finelli, Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale, Rosenberg&Sellier, 2022
 Il nuovo libro di Roberto Finelli, Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale (Rosenberg & Sellier, 2022), ci pone di fronte a un problema quanto mai attuale, quello di quale sia il modo più adeguato di rapportarsi alle nuove tecnologie digitali, per poterne utilizzare le straordinarie opportunità che mettono a disposizione dell’uomo, senza che quest’ultimo ne diventi una mera appendice. E’ del resto plausibile, dal mio punto di vista, quanto tali tecnologie stiano inducendo, soprattutto nei più giovani, una trasformazione del rapporto con la realtà, delle relazioni sociali e finanche della mente, del corpo e della psiche umane. In particolare, la connettività planetaria, attraverso “l’automa cognitivo globale” della rete, come ci ricorda Franco Berardi, porta con sé conseguenze su diversi piani: “c’è un legame tra connettività e prossemica sociale, c’è un legame tra connettività e perdita dell’empatia, c’è un legame tra connettività e precarietà del lavoro, e dissoluzione del sentimento sociale della solidarietà […] c’è un rapporto tra connettività e suicidio”[1]. Sembra quindi si stia realizzando una sorta di cablatura digitale dell’essere umano, una “modellazione biosociale della sensibilità, ovvero un’incorporazione di automatismi cognitivi nella percezione, nell’immaginazione, nel desiderio”[2].
Il nuovo libro di Roberto Finelli, Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente digitale (Rosenberg & Sellier, 2022), ci pone di fronte a un problema quanto mai attuale, quello di quale sia il modo più adeguato di rapportarsi alle nuove tecnologie digitali, per poterne utilizzare le straordinarie opportunità che mettono a disposizione dell’uomo, senza che quest’ultimo ne diventi una mera appendice. E’ del resto plausibile, dal mio punto di vista, quanto tali tecnologie stiano inducendo, soprattutto nei più giovani, una trasformazione del rapporto con la realtà, delle relazioni sociali e finanche della mente, del corpo e della psiche umane. In particolare, la connettività planetaria, attraverso “l’automa cognitivo globale” della rete, come ci ricorda Franco Berardi, porta con sé conseguenze su diversi piani: “c’è un legame tra connettività e prossemica sociale, c’è un legame tra connettività e perdita dell’empatia, c’è un legame tra connettività e precarietà del lavoro, e dissoluzione del sentimento sociale della solidarietà […] c’è un rapporto tra connettività e suicidio”[1]. Sembra quindi si stia realizzando una sorta di cablatura digitale dell’essere umano, una “modellazione biosociale della sensibilità, ovvero un’incorporazione di automatismi cognitivi nella percezione, nell’immaginazione, nel desiderio”[2].
Lo sviluppo più recente dell’intelligenza artificiale (AI), dal canto suo, comincia a nutrire l’ambizione di poter duplicare le funzionalità fisico cognitive dell’essere umano, attraverso replicanti robotizzati la cui anima è un algoritmo evoluto che autoapprende (learning machine), il cui corpo è composto da materiali sintetici e la cui alimentazione è a base di sterminate basi di dati[3].
- Details
- Hits: 1931
L’ambivalenza di tre sentimenti del disincanto
di Paolo Virno
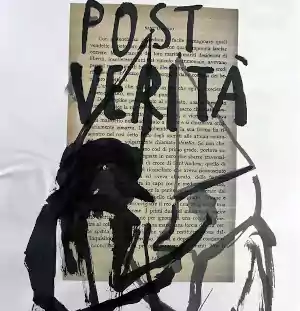 Nell'ambito del lavoro sui «decenni smarriti» che stiamo portando avanti, pubblichiamo questo significativo articolo di Paolo Virno, originariamente pubblicato il 3 marzo 1988 su «il Manifesto» e che oggi è possibile leggere in Negli anni del nostro scontento. Diario della controrivoluzione (DeriveApprodi, 2023), che poi sarà sviluppato nel testo «Ambivalenza del disincanto» contenuto in Sentimenti dell'aldiqua. Opportunismo paura cinismo nell'età del disincanto, di cui uscirà a breve una nuova edizione per DeriveApprodi. Intorno a questo libro si articolerà il Festival di DeriveApprodi, che si terrà a Bologna il 9-10-11 giugno.
Nell'ambito del lavoro sui «decenni smarriti» che stiamo portando avanti, pubblichiamo questo significativo articolo di Paolo Virno, originariamente pubblicato il 3 marzo 1988 su «il Manifesto» e che oggi è possibile leggere in Negli anni del nostro scontento. Diario della controrivoluzione (DeriveApprodi, 2023), che poi sarà sviluppato nel testo «Ambivalenza del disincanto» contenuto in Sentimenti dell'aldiqua. Opportunismo paura cinismo nell'età del disincanto, di cui uscirà a breve una nuova edizione per DeriveApprodi. Intorno a questo libro si articolerà il Festival di DeriveApprodi, che si terrà a Bologna il 9-10-11 giugno.
Lo pubblichiamo su «Transuenze» perché è un testo capace di riassumere bene le trasformazioni nella produzione, nel lavoro e nelle soggettività che si sono determinate negli anni Ottanta.
Per Virno la formazione di soggettività si compie ormai per l'essenziale fuori dal lavoro. Dunque, nell'analizzare la situazione emotiva e il suo rapporto sempre più stretto con le nuove forme di vita, del lavoro e della produzione individua tre sentimenti prevalenti in quegli anni (l'opportunismo, la paura e il cinismo) che combaciano con la versatilità e la flessibilità delle moderne tecnologie elettroniche e che dunque, entrano in produzione.
Inoltre, se è vero che in questa costellazione sentimentale non c'è nulla di buono, essa rappresenta il dato di fatto irreversibile da cui pensare le nuove istanze di trasformazione.
* * * *
Una disamina della situazione emotiva degli anni Ottanta non è svagata peripezia letteraria, né pausa ricreativa posta a mezzo di ricerche ben altrimenti rigorose. Tutt’al contrario, questo approccio ha di mira questioni preminenti e concretissime: rapporti di produzione e forme di vita, acquiescenza e conflitto. È un «prologo in terra» sordo a ogni stormire angelico, inteso a regolare i conti con il decennio in corso, con il senso comune e l’ethos che ne sono scaturiti, con le categorie prevalse nella sua autocomprensione.
Page 5 of 40