Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 1795
Domenico Losurdo legge Nietzsche
di Leo Essen
 Losurdo dice di Nietzsche che è il più grande pensatore tra i reazionari e il più grande reazionario tra i pensatori. E chiude la faccenda. Centra i tre temi del suo pensiero (Innocenza dell’avvenire, Eterno ritorno, Volontà di potenza), ma li liscia tutti e tre, fornendo un’interpretazione banale e ingenerosa.
Losurdo dice di Nietzsche che è il più grande pensatore tra i reazionari e il più grande reazionario tra i pensatori. E chiude la faccenda. Centra i tre temi del suo pensiero (Innocenza dell’avvenire, Eterno ritorno, Volontà di potenza), ma li liscia tutti e tre, fornendo un’interpretazione banale e ingenerosa.
Dell’eterno ritorno dice che viene usato per liquidare la tradizione (messianica) ebraico-cristiana.
La critica del messianesimo e di ogni forma di teologia o filosofia della storia, dice, va a sfociare nella critica della speranza socialista nell’avvento di un mondo nuovo – un mondo nuovo per gli schiavi.
Lasciate ogni speranza, abbandonate ogni messianesimo, per voi la schiavitù sarà sempre e solo schiavitù, ora e per sempre, in un eterno ritorno, in un eterno presente.
Nietzsche, dice Losurdo, liquida la fiduciosa attesa, mediante la contrapposizione alla visione unilineare del tempo, propria della tradizione ebraico-cristiana, della tesi, mutuata dall’antichità classica, dell’eterno ritorno dell’identico. E così Nietzsche sembra voler ritornare al punto di partenza.
Il sentimento della speranza e la visione unilineare del tempo su cui esso si fonda, dice Losurdo, viene messa definitivamente fuori causa con la tesi o con il mito dell’eterno ritorno
dell’identico.
L’Eterno ritorno viene connesso da Losurdo al tema dell’Innocenza dell’avvenire.
Non fatevi illusione, non attendetevi niente. Tutto ciò che sarà è già stato, e ciò che è già stato lo avete davanti agli occhi, è la vostra schiavitù. Non abbiate speranza nell’avvenire. Non c’è avvenire, non c’è messia. Non c’è nessun piano, nessun progetto, nessuna filosofia della storia. C’è solo questo presente che gira intorno al suo asse.
- Details
- Hits: 1442
Democrazia rivoluzionaria
di Giacomo Croci
Il pensiero di Cornelius Castoriadis e il rapporto tra individuo, società e storia
 Non credo e non voglio che i giochi siano fatti.” Questa frase, che ritroviamo nel volume La rivoluzione democratica, racchiude il pensiero di Cornelius Castoriadis. Per giochi si intende l’attività politica, cioè l’attività collettiva e individuale di organizzazione e riorganizzazione della realtà sociale e materiale. Per Castoriadis, essere un individuo socializzato, cioè qualcuno che può agire in un mondo sociale e materiale, presuppone che questo mondo, per quanto regolato, possa sempre essere cambiato. Cioè: non posso che credere e volere che i giochi non siano fatti, altrimenti non c’è niente da credere e da volere.
Non credo e non voglio che i giochi siano fatti.” Questa frase, che ritroviamo nel volume La rivoluzione democratica, racchiude il pensiero di Cornelius Castoriadis. Per giochi si intende l’attività politica, cioè l’attività collettiva e individuale di organizzazione e riorganizzazione della realtà sociale e materiale. Per Castoriadis, essere un individuo socializzato, cioè qualcuno che può agire in un mondo sociale e materiale, presuppone che questo mondo, per quanto regolato, possa sempre essere cambiato. Cioè: non posso che credere e volere che i giochi non siano fatti, altrimenti non c’è niente da credere e da volere.
C’è un profondo ottimismo in questo pensiero, quello che forse Ernst Bloch chiamerebbe “ottimismo militante.” Ottimismo che non riposa però sugli allori dell’ingenuità, ma su quello che, secondo Castoriadis, viene praticato dagli esseri umani sotto il nome di democrazia – pratica che sarebbe essenzialmente rivoluzionaria. Castoriadis sostiene che una pratica e un pensiero che si muovono al di qua o al di là della soglia rivoluzionaria non sono democratici, e che le istituzioni democratiche si lasciano valutare solo dal punto di vista della rivoluzione. La tesi è accattivante e controversa. Andiamo per gradi.
La carriera di Castoriadis è piuttosto eterodossa: non solo filosofo, ma anche economista per l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e psicoanalista, prima nella scuola fondata da Jacques Lacan e poi più critico rispetto all’impostazione lacaniana. I tre elementi ricorrono nei suoi scritti, come emerge chiaramente in La rivoluzione democratica.
- Details
- Hits: 2324
Storia e coscienza di classe di György Lukács
di Paolo Cassetta
Destini e significati di un grande classico marxista del XX secolo a cento anni dalla pubblicazione
 Storia e coscienza di classe è un libro difficile [1]. La circostanza era abbastanza evidente già al tempo della sua pubblicazione; e non è detto che questa difficoltà, questo linguaggio talora un po’ astruso destinato ad agire sul lettore quasi come una barriera, non abbia contribuito alla sua disgrazia politica negli ambienti del Comintern, abituati a modi spicci e all’empirismo altalenante di Zinoviev, che, come sappiamo, pronunciò la famosa condanna nell’estate del 1924, al V congresso dell’Internazionale.
Storia e coscienza di classe è un libro difficile [1]. La circostanza era abbastanza evidente già al tempo della sua pubblicazione; e non è detto che questa difficoltà, questo linguaggio talora un po’ astruso destinato ad agire sul lettore quasi come una barriera, non abbia contribuito alla sua disgrazia politica negli ambienti del Comintern, abituati a modi spicci e all’empirismo altalenante di Zinoviev, che, come sappiamo, pronunciò la famosa condanna nell’estate del 1924, al V congresso dell’Internazionale.
Ma Storia e coscienza di classe è un libro che, come scrive Lukács stesso nell’Introduzione licenziata a Vienna, nel natale del 1922, è nato “in mezzo al lavoro di partito”. Lukács parla esplicitamente di un “tentativo”. Il tentativo, leggo dall’Introduzione, di “chiarire a se stesso ed ai suoi lettori questioni teoriche del movimento rivoluzionario” [2].
Dunque sono “questioni teoriche”. Ma sono questioni teoriche del movimento rivoluzionario. Dobbiamo avere chiaro che Lukács si riferisce all’ondata internazionale messa in moto dagli effetti della Grande Guerra e della Rivoluzione russa. Quando Lukács scrive queste parole, egli e tutto il movimento comunista hanno già alle spalle l’insurrezione tedesca repressa nel gennaio del 1919, la rivoluzione bavarese dei consigli e quella ungherese fallite nella primavera-estate dello stesso anno, gli scontri armati provocati dal putsch di Kapp in Germania nel marzo del 1920, la sconfitta sovietica nella guerra con la Polonia in agosto, il movimento di occupazione delle fabbriche italiane nel settembre dello stesso anno, il tentativo insurrezionale comunista conosciuto come l’“azione di marzo” in Germania del 1921. In Russia la guerra civile è finita con la vittoria del governo bolscevico. Ma il passo del cambiamento attenua la sua velocità.
- Details
- Hits: 1491
Per la critica della libertà
di Gigi Roggero
 A fine marzo sarà in libreria, per la collana Input di DeriveApprodi, un nuovo libro di Gigi Roggero: Per la critica della libertà. Frammenti di pensiero forte. Utilizzando differenti registri teorici, armato di spilli acuminati e pazienti riflessioni, l’autore mostra come nella modernità capitalistica la libertà sia diventata un valore e un dogma, legata alla proprietà privata, all’individuo borghese e al totalitarismo democratico. Solo voltando le spalle all’opinione pubblica, si può allora guardare in faccia una libertà che è un campo di battaglia, che ci pone di fronte alle più mostruose paure e alle più grandi possibilità. Anticipiamo la prefazione, l’introduzione e la postfazione del volume.
A fine marzo sarà in libreria, per la collana Input di DeriveApprodi, un nuovo libro di Gigi Roggero: Per la critica della libertà. Frammenti di pensiero forte. Utilizzando differenti registri teorici, armato di spilli acuminati e pazienti riflessioni, l’autore mostra come nella modernità capitalistica la libertà sia diventata un valore e un dogma, legata alla proprietà privata, all’individuo borghese e al totalitarismo democratico. Solo voltando le spalle all’opinione pubblica, si può allora guardare in faccia una libertà che è un campo di battaglia, che ci pone di fronte alle più mostruose paure e alle più grandi possibilità. Anticipiamo la prefazione, l’introduzione e la postfazione del volume.
* * * *
Avviso ai naviganti
Questo pamphlet ha cominciato a essere scritto nell’estate del 2021. Da un anno e mezzo la pandemia aveva inghiottito l’attenzione mediatica e dunque dell’opinione pubblica. Sembrava che non si potesse parlare d’altro, che bisognasse velocemente schierarsi tra sì vax e no vax, che fosse necessario scegliere i virologi di fiducia con la stessa cura con cui si sceglie la squadra del cuore. Nei luoghi di lavoro, al bar, sui bus, per la strada, c’era un solo argomento di cui chiacchierare.
Un anno e mezzo dopo, con buona pace del mantra rituale, tutto è esattamente come prima. Maledettamente identico, banalmente normale. La pandemia è quasi dimenticata, ovvero ridotta a trafiletto marginale. Non è passato molto tempo, si potrebbe dire. Ma la durata del tempo dipende dall’unità di misura che si adotta. E questo specifico tempo in cui viviamo, non il tempo presente bensì il tempo del presentismo, pretende di abolire la durata. L’istante è tutto, il processo è nulla.
- Details
- Hits: 1403
György Lukács | Sulla responsabilità degli intellettuali
di Antiper
Tratto da György Lukács, Marxismo e politica culturale, Einaudi
 Durante la seconda guerra mondiale molti hanno sperato che distruggendo il regime hitleriano si sarebbe anche sradicata l’ideologia fascista. Ma quanto si è visto dalla fine della guerra in poi nella Germania occidentale indica che la reazione anglosassone ha addirittura salvato e favorito le basi economiche e politiche di una rinascita del fascismo hitleriano. Le conseguenze si sentono anche nel campo ideologico. Perciò l’ideologia dell’hitlerismo rappresenta ancora oggi un problema attuale e non meramente storico.
Durante la seconda guerra mondiale molti hanno sperato che distruggendo il regime hitleriano si sarebbe anche sradicata l’ideologia fascista. Ma quanto si è visto dalla fine della guerra in poi nella Germania occidentale indica che la reazione anglosassone ha addirittura salvato e favorito le basi economiche e politiche di una rinascita del fascismo hitleriano. Le conseguenze si sentono anche nel campo ideologico. Perciò l’ideologia dell’hitlerismo rappresenta ancora oggi un problema attuale e non meramente storico.
Se ripensiamo al sorgere del fascismo, vediamo quali gravi responsabilità portino gli intellettuali per la formazione dell’ideologia fascista. Qui, purtroppo, le eccezioni lodevoli sono pochissime.
Vorrei pregare i cosiddetti uomini pratici di non sottovalutare le questioni ideologiche. Faccio solo un esempio. Sappiamo benissimo come la politica hitleriana abbia portato con ferrea necessità agli orrori di Auschwitz e Majdanek. Ma non si deve neppure ignorare che uno dei fattori che permisero questi orrori fu la sistematica demolizione del principio dell ‘uguaglianza di tutti gli uomini. Sarebbe stato molto più difficile mettere in atto la bestialità organizzata del fascismo contro milioni di persone se Hitler non fosse riuscito a far radicare nelle più larghe masse tedesche la convinzione che chi non era «di razza pura» non era «propriamente» un uomo.
Questo è solo un esempio fra tanti. Deve soltanto dimostrare che un’ideologia reazionaria innocente non può esistere.
- Details
- Hits: 1464
Finalmente torna l'Ontologia
Grandezza e attualità dell'ultimo Lukàcs
di Carlo Formenti
Le pagine che seguono contengono ampi stralci della mia Prefazione alla nuova edizione della Ontologia dell'essere sociale di Gyorgy Lukács, che l'editore Meltemi manda in libreria fra pochi giorni. Per rendere più scorrevole la lettura ho eliminato una buona metà delle note contenute nel testo originale, lasciando solo quelle indispensabili. Inoltre le citazioni del testo di Lukács che trovate in queste note si riferiscono all'edizione precedente (PIGRECO) dell'Ontologia in quanto non ho avuto tempo né modo di aggiornare i riferimenti alla nuova edizione
 Se la Ontologia dell'essere sociale fosse stata pubblicata nel 1971 (l'anno di morte dell'autore) avrebbe certamente influito sulla valutazione della grandezza di Lukács, elevandolo al ruolo di più importante filosofo marxista - e fra i maggiori filosofi in generale – del Novecento. Invece quest'opera monumentale, la cui stesura richiese un decennio di lavoro, tardò a vedere la luce perché l'autore continuava a rimaneggiare il testo dei Prolegomeni che, malgrado la loro funzione di sintesi introduttiva ai temi della Ontologia, furono scritti per ultimi; inoltre perché gli allievi che ebbero a disposizione il manoscritto dopo la sua morte ne ritardarono la diffusione (la traduzione italiana della seconda parte uscì nel 1981, mentre la versione originale apparve in tedesco dal 1984 al 1986), ma soprattutto alimentarono un pregiudizio negativo nei confronti dell'opera prima che fosse resa disponibile ai lettori. Questi motivi, unitamente al clima storico, ideologico e culturale antisocialista e antimarxista degli anni Ottanta generato dalla rivoluzione neoliberale, dalla svolta eurocomunista di quei partiti europei che interpretarono la crisi del socialismo come “crollo del marxismo”, nonché dalla svolta libertaria e individualista dei “nuovi movimenti” post sessantottini, ha fatto della Ontologia una delle opere più sottovalutate del Novecento. Al punto che il pensiero di Lukács, mentre è rimasto oggetto di culto per minoranze intellettuali non convertitesi al mainstream neoliberale, ha continuato ad essere identificato con opere precedenti come la Distruzione della ragione, e ancor più con Storia e coscienza di classe (1), un libro che lo stesso autore considerava “giovanile” e superato (...).
Se la Ontologia dell'essere sociale fosse stata pubblicata nel 1971 (l'anno di morte dell'autore) avrebbe certamente influito sulla valutazione della grandezza di Lukács, elevandolo al ruolo di più importante filosofo marxista - e fra i maggiori filosofi in generale – del Novecento. Invece quest'opera monumentale, la cui stesura richiese un decennio di lavoro, tardò a vedere la luce perché l'autore continuava a rimaneggiare il testo dei Prolegomeni che, malgrado la loro funzione di sintesi introduttiva ai temi della Ontologia, furono scritti per ultimi; inoltre perché gli allievi che ebbero a disposizione il manoscritto dopo la sua morte ne ritardarono la diffusione (la traduzione italiana della seconda parte uscì nel 1981, mentre la versione originale apparve in tedesco dal 1984 al 1986), ma soprattutto alimentarono un pregiudizio negativo nei confronti dell'opera prima che fosse resa disponibile ai lettori. Questi motivi, unitamente al clima storico, ideologico e culturale antisocialista e antimarxista degli anni Ottanta generato dalla rivoluzione neoliberale, dalla svolta eurocomunista di quei partiti europei che interpretarono la crisi del socialismo come “crollo del marxismo”, nonché dalla svolta libertaria e individualista dei “nuovi movimenti” post sessantottini, ha fatto della Ontologia una delle opere più sottovalutate del Novecento. Al punto che il pensiero di Lukács, mentre è rimasto oggetto di culto per minoranze intellettuali non convertitesi al mainstream neoliberale, ha continuato ad essere identificato con opere precedenti come la Distruzione della ragione, e ancor più con Storia e coscienza di classe (1), un libro che lo stesso autore considerava “giovanile” e superato (...).
- Details
- Hits: 1833
Il perturbante contro Freud
di Paolo Virno
Pubblichiamo un estratto di una riflessione di Paolo Virno a partire dal saggio Il perturbante di Freud. Per il testo completo rimandiamo allo «scavi» Sintomi. Per un'antropologia linguistica del mondo contemporaneo, scaricabile qui: https://www.machina-deriveapprodi.com/post/sintomi-per-un-antropologia-linguistica-del-mondo-contemporaneo.
 Convenevoli
Convenevoli
Propongo una riflessione sul buon uso di una operetta di Freud, Il perturbante. La mia lettura è schiettamente unilaterale, sicché darò poca o nessuna importanza ad alcuni temi lì presenti, a spudorato vantaggio di altri. Del resto, chiunque si sia imbattuto in questo minuscolo e famosissimo saggio, ne ha sperimentato l’indole magmatica, centrifuga, a tratti incoerente. Un approccio partigiano e selettivo, oltre che giustificato, è raccomandabile, anzi necessario.
La riflessione prevede due movimenti distinti, che si sostengono a vicenda come avversari di lotta libera, in lizza tra loro e però solidali. Quel che cambia è la postura teorica, nonché la passione predominante. Lo stato d’animo del chiosatore scontento e supercilioso cede il posto a quello di chi, liberatosi da una ipnosi resinosa, dice serenamente come stanno davvero le cose.
Da principio, in preda alla buona educazione, perlustro e recensisco Il perturbante. Sia pure con la preannunciata unilateralità, mi sforzo di mettere in rilievo le sue articolazioni interne e i chiodi fissi su cui batte e ribatte. Il commento del testo, in qualche caso minuzioso, si prefigge di criticare a fondo le principali convinzioni che vi sono espresse, ventilando possibili deviazioni e alternative. Ma le deviazioni, anche se brusche, e le alternative, talvolta ambiziose, traggono comunque spunto dall’ordito argomentativo dello scritto di Freud. Non sono altro che reazioni polemiche, e una reazione è la conseguenza subalterna, spesso simile a una smorfia o a uno starnuto, delle tesi che l’hanno suscitata.
In seguito (ma la convivenza dei due movimenti rivali si avverte, credo, fin dall’inizio), mi addosso l’onere di delineare una teoria autonoma del perturbante, radicalmente non freudiana, quindi antifreudiana.
- Details
- Hits: 2014
Tra limiti e possibile: un’antropologia per l’era complessa
di Paolo Bartolini
L’identità è un’opera, un farsi continuo, che non coincide mai con un “dato definitivo” e nemmeno può ambire a “essere tutto”. Ecco la complessità, che piaccia o meno
 Chiunque viva con disagio la deriva antropologica e sociale a cui il tecno-capitalismo ci condanna, sa bene che le forze in campo per una democrazia insorgente sono frammentate, spesso in contrasto tra loro, vittime di un misto epocale di impotenza e agitazione frenetica. Una finta sinistra immemore dei suoi valori fondativi, e una destra neoliberale onnipervasiva, hanno stabilizzato, da almeno quarant’anni a questa parte, un gioco di specchi tossico che sfocia – come avrebbe detto Domenico Losurdo – in un sostanziale monopartitismo competitivo. “Privatizzare i profitti, socializzare le perdite” è il diktat che rimane al centro delle azioni delle élite contemporanee, quelle neocon e quelle che sul versante dei diritti civili e del costume si autodefiniscono progressiste.
Chiunque viva con disagio la deriva antropologica e sociale a cui il tecno-capitalismo ci condanna, sa bene che le forze in campo per una democrazia insorgente sono frammentate, spesso in contrasto tra loro, vittime di un misto epocale di impotenza e agitazione frenetica. Una finta sinistra immemore dei suoi valori fondativi, e una destra neoliberale onnipervasiva, hanno stabilizzato, da almeno quarant’anni a questa parte, un gioco di specchi tossico che sfocia – come avrebbe detto Domenico Losurdo – in un sostanziale monopartitismo competitivo. “Privatizzare i profitti, socializzare le perdite” è il diktat che rimane al centro delle azioni delle élite contemporanee, quelle neocon e quelle che sul versante dei diritti civili e del costume si autodefiniscono progressiste.
Anche la gestione confusa e autoritaria della sindemia Covid-19 testimonia il fatto che il pilota automatico neoliberale, nella fantasia dei ceti dominanti, non può essere disinnescato per quanto riguarda le sue coordinate essenziali. Il mondo multipolare è già tra noi e il declino del blocco angloamericano impatta con questa transizione gigantesca, nella vana speranza di poter arrestare un riequilibrio tra le potenze mondiali. Da qui la violenza del nostro tempo, dove – voglio essere chiaro – non ci sono “buoni” e “cattivi”, ma diversi modi di esercitare il dominio, più o meno “liberal” eppure omogenei per quanto riguarda il loro scopo ultimo: conservare, a favore di pochi, gerarchie e asimmetrie funzionali al sequestro del valore prodotto dalla collettività. Le logiche di potenza della geopolitica sono il problema, insieme alle concentrazioni di denaro che riguardano multinazionali, mass media, centri finanziari e così via. La gestazione di un mondo nuovo è turbolenta, minacciata da numerosi interessi contrapposti.
- Details
- Hits: 1564
Il senso dei futuri possibili
di Fredric Jameson
In questo saggio scritto per Jacobin, il grande critico marxista Fredric Jameson indaga il concetto di utopia come rottura dello status quo e accenno concreto al cambiamento
 I.
I.
Innanzitutto permettetemi di spiegare il dibattito intorno all’utopia o, forse dovrei dire, intorno agli usi politici dell’utopia. Immagino che la maggior parte delle persone concordi sul fatto che gli utopisti della fine del diciottesimo e dell’inizio del diciannovesimo secolo fossero tutti essenzialmente progressisti, nel senso che le loro visioni o fantasie puntavano a migliorare la condizione della razza umana. Il momento che mi interessa è quello dell’analisi amplificata in cui queste utopie e i loro entusiasti sostenitori vengono imputati in quanto destinati per forza di cose ad avere esiti nefasti. In seguito, ciò arriverà a far sostenere che l’utopismo rivoluzionario porta alla violenza e alla dittatura e che tutte le utopie, in un modo o nell’altro, portano a Josif Stalin: meglio ancora, che Stalin era lui stesso un utopista, su larga scala.
Ora, a dire il vero, ciò è già implicito nella denuncia della Rivoluzione francese da parte di Edmund Burke, e nella sua idea – uno dei più geniali argomenti controrivoluzionari – che sia la hybris degli esseri umani che induca a sostituire la lenta crescita naturale della tradizione con i piani artificiali della ragione, e che questa rivoluzione rappresenti di per sé sempre un disastro. Tutto ciò rivive durante la Guerra fredda: il comunismo si identifica con l’utopia, entrambi con la rivoluzione, e tutti con il totalitarismo (A volte si insinua anche il nazismo: non è tanto la sua identificazione con l’utopia quanto l’equivalenza di Adolf Hitler e Stalin, e i dibattiti che ne derivano sul vincitore nella competizione relativa al numero di morti).
- Details
- Hits: 2545
Tappe e percorsi della dialettica hegeliana: la Rivoluzione d’ottobre e il pensiero di Hegel
di Giovanni Sgro’*
 1. I contributi raccolti nel volume che qui si presenta1, ricostruiscono dettagliatamente un incontro “epocale” nella storia della filosofia (e non solo della filosofia!) contemporanea: la recezione e l’influenza della filosofia di Hegel nel e sul pensiero filosofico e politico russo. Questo incontro non inizia però - né, tanto meno, termina - con la Rivoluzione d’Ottobre. Infatti, prima ancora che l’opera di Hegel giungesse in Russia, fu l’intelligencija russa a recarsi a Berlino per conoscere e studiare l’opera di Hegel2. Anzi, come è stato giustamente osservato3, lo stesso incontro tra il pensiero di Hegel e gli intellettuali russi è di tipo dialettico: è avvenuto molto presto ma, allo stesso tempo, anche molto tardi. Molto presto cronologicamente, in quanto i primi contatti si sono avuti già all’indomani della morte di Hegel (1831), negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento ( Vormarz); ma a un livello di elaborazione molto tardo, in quanto l’immagine di Hegel che gli intellettuali russi assimilarono e che poi si adoperarono a diffondere e a propagandare nel loro paese era profondamente formata e mediata dall’interpretazione dei Giovani hegeliani.
1. I contributi raccolti nel volume che qui si presenta1, ricostruiscono dettagliatamente un incontro “epocale” nella storia della filosofia (e non solo della filosofia!) contemporanea: la recezione e l’influenza della filosofia di Hegel nel e sul pensiero filosofico e politico russo. Questo incontro non inizia però - né, tanto meno, termina - con la Rivoluzione d’Ottobre. Infatti, prima ancora che l’opera di Hegel giungesse in Russia, fu l’intelligencija russa a recarsi a Berlino per conoscere e studiare l’opera di Hegel2. Anzi, come è stato giustamente osservato3, lo stesso incontro tra il pensiero di Hegel e gli intellettuali russi è di tipo dialettico: è avvenuto molto presto ma, allo stesso tempo, anche molto tardi. Molto presto cronologicamente, in quanto i primi contatti si sono avuti già all’indomani della morte di Hegel (1831), negli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento ( Vormarz); ma a un livello di elaborazione molto tardo, in quanto l’immagine di Hegel che gli intellettuali russi assimilarono e che poi si adoperarono a diffondere e a propagandare nel loro paese era profondamente formata e mediata dall’interpretazione dei Giovani hegeliani.
Vissarion Grigor’evic Belinskij (1811-1848), Michail Aleksandrovic Bakunin (1814-1876) e Aleksandr Ivanovic Herzen (1812-1870) distinguevano nettamente il metodo rivoluzionario dal sistema conservatore, consideravano quindi la dialettica hegeliana come un’arma rivoluzionaria, offrivano un’interpretazione in chiave dinamica dei rapporti tra reale e razionale e, nel complesso, aderivano pienamente a una lettura in chiave progressista e rivoluzionaria della filosofia hegeliana4.
- Details
- Hits: 16719
Relazioni pericolose
di Enzo Traverso
Da Dialettica dell’irrazionalismo. Lukács tra nazismo e stalinismo, Ombre Corte, Verona 2022
 Queste considerazioni sull’esistenzialismo giovanile di Lukács potrebbero essere estese a molte altre correnti di pensiero esaminate ne La distruzione della ragione. Valgono ad esempio per la critica di Weber alla razionalità occidentale, che Lukács stesso aveva incorporato nel proprio concetto di reificazione in Storia e coscienza di classe, un testo fondamentale del marxismo occidentale1. Valgono anche per Nietzsche, la cui appropriazione da parte dell’ideologia nazista non impedì a diversi studiosi marxisti o anarchici di considerarlo un pensatore stimolante. Sia Ernst Bloch che Herbert Marcuse accolsero le potenzialità emancipatrici di una rivolta dionisiaca contro la civiltà repressiva. Il pensiero di Nietzsche, ha sottolineato Marcuse, conteneva ben più di un rifiuto aristocratico della modernità e di una nefasta apologia della schiavitù; portava con sé anche “l’aria liberatrice” di una filosofia che tracciava la propria strada attaccando “la Legge e l’Ordine”2. Adorno e Horkheimer non ignoravano le ambiguità del nichilismo di Nietzsche, che già conteneva alcune premesse di un’ideologia “prefascista”, ma lo consideravano uno dei pochi, dopo Hegel, ad aver riconosciuto la dialettica dell’illuminismo3. E considerazioni analoghe valgono anche per Heidegger, il cui convinto sostegno al regime nazista non invalidava le molteplici direzioni del suo pensiero ontologico, in cui pensatori marxisti come Marcuse e Günther Anders hanno trovato preziose munizioni per la loro critica radicale della tecnologia e dell’alienazione capitalista. Adorno, che non esprimeva alcun compiacimento verso Heidegger nel suo Il gergo dell’autenticità (1964), non poteva accettare la tendenza di Lukács ad assimilare al fascismo tutte le forme di irrazionalismo che, in tempi diversi, erano affiorate in seno alla filosofia tedesca.
Queste considerazioni sull’esistenzialismo giovanile di Lukács potrebbero essere estese a molte altre correnti di pensiero esaminate ne La distruzione della ragione. Valgono ad esempio per la critica di Weber alla razionalità occidentale, che Lukács stesso aveva incorporato nel proprio concetto di reificazione in Storia e coscienza di classe, un testo fondamentale del marxismo occidentale1. Valgono anche per Nietzsche, la cui appropriazione da parte dell’ideologia nazista non impedì a diversi studiosi marxisti o anarchici di considerarlo un pensatore stimolante. Sia Ernst Bloch che Herbert Marcuse accolsero le potenzialità emancipatrici di una rivolta dionisiaca contro la civiltà repressiva. Il pensiero di Nietzsche, ha sottolineato Marcuse, conteneva ben più di un rifiuto aristocratico della modernità e di una nefasta apologia della schiavitù; portava con sé anche “l’aria liberatrice” di una filosofia che tracciava la propria strada attaccando “la Legge e l’Ordine”2. Adorno e Horkheimer non ignoravano le ambiguità del nichilismo di Nietzsche, che già conteneva alcune premesse di un’ideologia “prefascista”, ma lo consideravano uno dei pochi, dopo Hegel, ad aver riconosciuto la dialettica dell’illuminismo3. E considerazioni analoghe valgono anche per Heidegger, il cui convinto sostegno al regime nazista non invalidava le molteplici direzioni del suo pensiero ontologico, in cui pensatori marxisti come Marcuse e Günther Anders hanno trovato preziose munizioni per la loro critica radicale della tecnologia e dell’alienazione capitalista. Adorno, che non esprimeva alcun compiacimento verso Heidegger nel suo Il gergo dell’autenticità (1964), non poteva accettare la tendenza di Lukács ad assimilare al fascismo tutte le forme di irrazionalismo che, in tempi diversi, erano affiorate in seno alla filosofia tedesca.
- Details
- Hits: 1724
Il marxismo secondo Bloch, una mappa del mondo che contiene il paese Utopia
di Fabio Ciabatti
Ernst Bloch, Speranza e Utopia. Conversazioni 1964-1975, Mimesis, Milano 2022, pp. 142, € 15,81
 “Rompere l’assedio, tentare il futuro” è uno degli slogan scelti dal collettivo di fabbrica della GKN, impegnato nel difficile tentativo di salvare 300 posti di lavoro riconvertendo il sito produttivo in uno stabilimento “pubblico e socialmente integrato”. “Quanto stiamo tentando – sostengono i lavoratori della fabbrica fiorentina – è completamente nuovo e al contempo affonda pienamente le radici nella storia di questo nostro territorio”. L’accostamento potrebbe apparire eccessivo, ma in queste parole sembra di ascoltare la lontana eco del “principio speranza” di Ernst Bloch. Per il filosofo tedesco, infatti, il futuro autentico, l’avvenire propriamente utopico, è ciò che non è accaduto mai e in alcun luogo. Allo stesso tempo, “non tutto ciò che è scomparso è ciarpame, perché c’è del futuro nel passato, qualcosa che non è stato liquidato, che ci è dato in eredità”.1
“Rompere l’assedio, tentare il futuro” è uno degli slogan scelti dal collettivo di fabbrica della GKN, impegnato nel difficile tentativo di salvare 300 posti di lavoro riconvertendo il sito produttivo in uno stabilimento “pubblico e socialmente integrato”. “Quanto stiamo tentando – sostengono i lavoratori della fabbrica fiorentina – è completamente nuovo e al contempo affonda pienamente le radici nella storia di questo nostro territorio”. L’accostamento potrebbe apparire eccessivo, ma in queste parole sembra di ascoltare la lontana eco del “principio speranza” di Ernst Bloch. Per il filosofo tedesco, infatti, il futuro autentico, l’avvenire propriamente utopico, è ciò che non è accaduto mai e in alcun luogo. Allo stesso tempo, “non tutto ciò che è scomparso è ciarpame, perché c’è del futuro nel passato, qualcosa che non è stato liquidato, che ci è dato in eredità”.1
Bisogna fare attenzione, però, perché in questa duplicità si apre anche lo sciagurato spazio per un futuro inautentico, quello rappresentato, per esempio, dalla traboccante retorica del “Führer che ci conduce a nuove imprese”; quello che si spaccia per un nuovo inizio ma risale fino alla notte dei tempi per riscoprire una patria concepita come “sangue e suolo”. In realtà, la vera patria è un luogo dove nessuno è mai stato, ma che dobbiamo cercare di raggiungere, ammesso che si intenda la categoria di Heimat nella sua vecchia accezione filosofica e mistica: “essere a casa”, trovarsi finalmente in un posto in cui cessa l’alienazione e gli oggetti non sono più estranei, ma prossimi al soggetto.
- Details
- Hits: 2054
Ernst Bloch: perché ci si alza la mattina?
di Rocco Ronchi
 Ci sono delle buone ragioni per sperare? Oppure, detto più prosaicamente ma anche in modo maledettamente più concreto, “perché ci si alza la mattina?”. Se nella notte ci si è rigirati insonni nel letto era proprio perché quella domanda non sembrava trovare risposta. La speranza in certe ore notturne è proprio come morta. “Perché ci si alza allora la mattina?” chiede il filosofo Ernst Bloch nella sua conversazione del 1964 con Theodor W. Adorno, da lui chiamato amichevolmente Teddy (Qualcosa manca… sulla contraddizione dell’anelito utopico contenuta in Ernst Bloch, Speranza e utopia, Conversazioni 1964-1975, a cura di R. Traub e H. Wieser, Mimesis, Milano 2022). Quali sono le radici metafisiche di quella folle speranza in un giorno migliore senza la quale l’esistenza sarebbe intollerabile? Il curatore italiano del libro Eliano Zigiotto, come Laura Boella, che lo correda con una breve e intensa post-fazione (dal titolo: Il coraggio di sperare e di disperare) insistono nel “datare” queste conversazioni: sono, ripetono, di cinquanta – sessanta anni fa quando il mondo era profondamente diverso, quando la guerra fredda imperava e la filosofia era praticata come atto critico e sovversivo.
Ci sono delle buone ragioni per sperare? Oppure, detto più prosaicamente ma anche in modo maledettamente più concreto, “perché ci si alza la mattina?”. Se nella notte ci si è rigirati insonni nel letto era proprio perché quella domanda non sembrava trovare risposta. La speranza in certe ore notturne è proprio come morta. “Perché ci si alza allora la mattina?” chiede il filosofo Ernst Bloch nella sua conversazione del 1964 con Theodor W. Adorno, da lui chiamato amichevolmente Teddy (Qualcosa manca… sulla contraddizione dell’anelito utopico contenuta in Ernst Bloch, Speranza e utopia, Conversazioni 1964-1975, a cura di R. Traub e H. Wieser, Mimesis, Milano 2022). Quali sono le radici metafisiche di quella folle speranza in un giorno migliore senza la quale l’esistenza sarebbe intollerabile? Il curatore italiano del libro Eliano Zigiotto, come Laura Boella, che lo correda con una breve e intensa post-fazione (dal titolo: Il coraggio di sperare e di disperare) insistono nel “datare” queste conversazioni: sono, ripetono, di cinquanta – sessanta anni fa quando il mondo era profondamente diverso, quando la guerra fredda imperava e la filosofia era praticata come atto critico e sovversivo.
Bloch e Adorno (per non parlare di György Lukács, compagno di studi filosofici del giovane Ernst, anche lui fugacemente presente in questi dialoghi) erano filosofi che nell’hegelo-marxismo avevano il loro orizzonte di riferimento teorico e nel socialismo quello pratico. Le loro strade certo divergono, anche drammaticamente, ma tutti condividono la speranza in una trasformazione radicale dello stato di cose, anzi il loro dissidio nasce proprio dai diversi modi in cui questa comune speranza può essere declinata.
- Details
- Hits: 1067
Relazioni pericolose
di Enzo Traverso
Da Dialettica dell’irrazionalismo. Lukács tra nazismo e stalinismo, Ombre Corte, Verona 2022
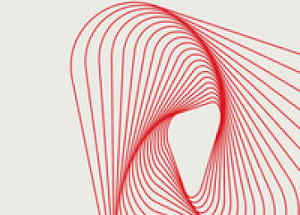 Queste considerazioni sull’esistenzialismo giovanile di Lukács potrebbero essere estese a molte altre correnti di pensiero esaminate ne La distruzione della ragione. Valgono ad esempio per la critica di Weber alla razionalità occidentale, che Lukács stesso aveva incorporato nel proprio concetto di reificazione in Storia e coscienza di classe, un testo fondamentale del marxismo occidentale1. Valgono anche per Nietzsche, la cui appropriazione da parte dell’ideologia nazista non impedì a diversi studiosi marxisti o anarchici di considerarlo un pensatore stimolante. Sia Ernst Bloch che Herbert Marcuse accolsero le potenzialità emancipatrici di una rivolta dionisiaca contro la civiltà repressiva. Il pensiero di Nietzsche, ha sottolineato Marcuse, conteneva ben più di un rifiuto aristocratico della modernità e di una nefasta apologia della schiavitù; portava con sé anche “l’aria liberatrice” di una filosofia che tracciava la propria strada attaccando “la Legge e l’Ordine”2. Adorno e Horkheimer non ignoravano le ambiguità del nichilismo di Nietzsche, che già conteneva alcune premesse di un’ideologia “prefascista”, ma lo consideravano uno dei pochi, dopo Hegel, ad aver riconosciuto la dialettica dell’illuminismo3. E considerazioni analoghe valgono anche per Heidegger, il cui convinto sostegno al regime nazista non invalidava le molteplici direzioni del suo pensiero ontologico, in cui pensatori marxisti come Marcuse e Günther Anders hanno trovato preziose munizioni per la loro critica radicale della tecnologia e dell’alienazione capitalista. Adorno, che non esprimeva alcun compiacimento verso Heidegger nel suo Il gergo dell’autenticità (1964), non poteva accettare la tendenza di Lukács ad assimilare al fascismo tutte le forme di irrazionalismo che, in tempi diversi, erano affiorate in seno alla filosofia tedesca.
Queste considerazioni sull’esistenzialismo giovanile di Lukács potrebbero essere estese a molte altre correnti di pensiero esaminate ne La distruzione della ragione. Valgono ad esempio per la critica di Weber alla razionalità occidentale, che Lukács stesso aveva incorporato nel proprio concetto di reificazione in Storia e coscienza di classe, un testo fondamentale del marxismo occidentale1. Valgono anche per Nietzsche, la cui appropriazione da parte dell’ideologia nazista non impedì a diversi studiosi marxisti o anarchici di considerarlo un pensatore stimolante. Sia Ernst Bloch che Herbert Marcuse accolsero le potenzialità emancipatrici di una rivolta dionisiaca contro la civiltà repressiva. Il pensiero di Nietzsche, ha sottolineato Marcuse, conteneva ben più di un rifiuto aristocratico della modernità e di una nefasta apologia della schiavitù; portava con sé anche “l’aria liberatrice” di una filosofia che tracciava la propria strada attaccando “la Legge e l’Ordine”2. Adorno e Horkheimer non ignoravano le ambiguità del nichilismo di Nietzsche, che già conteneva alcune premesse di un’ideologia “prefascista”, ma lo consideravano uno dei pochi, dopo Hegel, ad aver riconosciuto la dialettica dell’illuminismo3. E considerazioni analoghe valgono anche per Heidegger, il cui convinto sostegno al regime nazista non invalidava le molteplici direzioni del suo pensiero ontologico, in cui pensatori marxisti come Marcuse e Günther Anders hanno trovato preziose munizioni per la loro critica radicale della tecnologia e dell’alienazione capitalista. Adorno, che non esprimeva alcun compiacimento verso Heidegger nel suo Il gergo dell’autenticità (1964), non poteva accettare la tendenza di Lukács ad assimilare al fascismo tutte le forme di irrazionalismo che, in tempi diversi, erano affiorate in seno alla filosofia tedesca.
- Details
- Hits: 1106
Da Hitler a Schelling
di Enzo Traverso
Da Dialettica dell’irrazionalismo. Lukács tra nazismo e stalinismo, Ombre Corte, Verona 2022
 La distruzione della ragione è un libro costruito come l’atto d’accusa di uno spietato procuratore che chiama alla sbarra gli imputati, vale a dire i protagonisti di due secoli di filosofia tedesca. Egli scruta attentamente le prove, frammentarie ma strettamente correlate, di un unico processo che alla fine svela la magnitudine del crimine. Le accuse descrivono un paesaggio variegato e impressionante. Per molti aspetti, l’atto d’accusa di Lukács evoca la procedura ermeneutica del romanzo poliziesco brillantemente studiato da Siegfried Kracauer all’inizio degli anni Venti. La hall dell’hotel dove, alla fine del romanzo, il detective riunisce tutti i personaggi per svelare l’assassino, illustrare il misfatto e comprenderne i moventi, è una sorta di “immagine rovesciata della casa di Dio”1. Dio è sostituito dalla ragione – Kracauer preferisce il termine Ratio – e l’investigatore svolge il ruolo di un sacerdote laico che celebra la liturgia della ragione trionfante. La ragione sconfigge la follia e i suoi argomenti sono inconfutabili, grazie alle molteplici prove che ne corroborano le accuse. Kracauer stesso adottò questo metodo inquisitorio nella sua opera più famosa, Da Caligari a Hitler (1946), che presenta molte affinità con La distruzione della ragione. Il crimine è stato perpetrato, conosciamo l’assassino e l’investigatore ricostruisce rigorosamente la genealogia dei suoi orribili misfatti, citando i complici, la dinamica delle azioni, le circostanze che hanno accompagnato ogni suo passo e che sono state “oggettivamente” – poco importa se consapevolmente o inconsapevolmente favorite da molti altri testimoni e personaggi secondari. Secondo Kracauer, i film di Weimar hanno senza dubbio rivelato “la preponderanza di tendenze autoritarie” che divenne “un fattore decisivo” per l’avvento del nazional-socialismo. “Irrimediabilmente piombata in uno stato di regressione – egli conclude – la maggior parte del popolo tedesco non poté fare a meno di sottomettersi a Hitler”2.
La distruzione della ragione è un libro costruito come l’atto d’accusa di uno spietato procuratore che chiama alla sbarra gli imputati, vale a dire i protagonisti di due secoli di filosofia tedesca. Egli scruta attentamente le prove, frammentarie ma strettamente correlate, di un unico processo che alla fine svela la magnitudine del crimine. Le accuse descrivono un paesaggio variegato e impressionante. Per molti aspetti, l’atto d’accusa di Lukács evoca la procedura ermeneutica del romanzo poliziesco brillantemente studiato da Siegfried Kracauer all’inizio degli anni Venti. La hall dell’hotel dove, alla fine del romanzo, il detective riunisce tutti i personaggi per svelare l’assassino, illustrare il misfatto e comprenderne i moventi, è una sorta di “immagine rovesciata della casa di Dio”1. Dio è sostituito dalla ragione – Kracauer preferisce il termine Ratio – e l’investigatore svolge il ruolo di un sacerdote laico che celebra la liturgia della ragione trionfante. La ragione sconfigge la follia e i suoi argomenti sono inconfutabili, grazie alle molteplici prove che ne corroborano le accuse. Kracauer stesso adottò questo metodo inquisitorio nella sua opera più famosa, Da Caligari a Hitler (1946), che presenta molte affinità con La distruzione della ragione. Il crimine è stato perpetrato, conosciamo l’assassino e l’investigatore ricostruisce rigorosamente la genealogia dei suoi orribili misfatti, citando i complici, la dinamica delle azioni, le circostanze che hanno accompagnato ogni suo passo e che sono state “oggettivamente” – poco importa se consapevolmente o inconsapevolmente favorite da molti altri testimoni e personaggi secondari. Secondo Kracauer, i film di Weimar hanno senza dubbio rivelato “la preponderanza di tendenze autoritarie” che divenne “un fattore decisivo” per l’avvento del nazional-socialismo. “Irrimediabilmente piombata in uno stato di regressione – egli conclude – la maggior parte del popolo tedesco non poté fare a meno di sottomettersi a Hitler”2.
Page 6 of 40
Gli articoli più letti degli ultimi tre mesi
Domenico Moro: Sequestro di Maduro: un episodio della terza guerra mondiale a pezzi
Marco Travaglio: A chi inviamo le armi?
Andrea Zhok: Diario politico di un martirio – Palestina, 2023-2025
Il Pungolo Rosso: L’inesistente “buona guerra” di Massimo Cacciari
Luigi Alfieri: Trumpismo, malattia senile dell’americanismo?
Antonio Martone: Giovani d’oggi
Carlo Formenti: Diritto internazionale? Non fatemi ridere!
comidad: Lindsey Graham è il vero Trump (e non solo)
Alessandro Volpi: Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono
Gli articoli più letti dell'ultimo anno
Carlo Di Mascio: Il soggetto moderno tra Kant e Sacher-Masoch
Salvatore Bravo: "Sul compagno Stalin"
Alessio Mannino: Il Manifesto di Ventotene è una ca***a pazzesca
Andrea Zhok: "Io non so come fate a dormire..."
Fabrizio Marchi: Gaza. L’oscena ipocrisia del PD
Massimiliano Ay: Smascherare i sionisti che iniziano a sventolare le bandiere palestinesi!
Guido Salerno Aletta: Italia a marcia indietro
Alessandro Mariani: Quorum referendario: e se….?
Elena Basile: Nuova lettera a Liliana Segre
Michelangelo Severgnini: Le nozze tra Meloni ed Erdogan che non piacciono a (quasi) nessuno
Michelangelo Severgnini: La Libia e le narrazioni fiabesche della stampa italiana
Diego Giachetti: Dopo la fine del comunismo storico novecentesco
comidad: La fintocrate Meloni e l'autocrate Mattarella
Carlo Di Mascio: Diritto penale, carcere e marxismo. Ventuno tesi provvisorie
Manlio Dinucci: Washington caput mundi
Il Chimico Scettico: Bias per la "scienza": perché l'intelligenza artificiale non critica
Lavinia Marchetti: Il giornalista perfetto per un mondo impresentabile: Enrico Mentana e il consenso
Massimo Zucchetti: Grazie, Volodymir Zelensky!
Andrea Zhok: Vogliamo lasciarci alle spalle la vicenda pandemica?
Barbara Spinelli: La follia bellica Ue e l’arma di Čechov
Giorgio Agamben: Il medioevo prossimo venturo
Ilan Pappé: Sul panico morale e il coraggio di parlare
Marco Della Luna: Trump al ballo dei vampiri
Daniela Danna: Che cosa è successo nel 2020?

Qui una presentazione del libro e il link per ordinarlo
Paolo Botta: Cos'è lo Stato

Qui la prefazione di Thomas Fazi
E.Bertinato - F. Mazzoli: Aquiloni nella tempesta
Autori Vari: Sul compagno Stalin

Qui è possibile scaricare l'intero volume in formato PDF
A cura di Aldo Zanchetta: Speranza
Tutti i colori del rosso
Michele Castaldo: Occhi di ghiaccio

Qui la premessa e l'indice del volume
A cura di Daniela Danna: Il nuovo volto del patriarcato

Qui il volume in formato PDF
Luca Busca: La scienza negata

Alessandro Barile: Una disciplinata guerra di posizione
Salvatore Bravo: La contraddizione come problema e la filosofia in Mao Tse-tung

Daniela Danna: Covidismo
Alessandra Ciattini: Sul filo rosso del tempo
Davide Miccione: Quando abbiamo smesso di pensare

Franco Romanò, Paolo Di Marco: La dissoluzione dell'economia politica

Qui una anteprima del libro
Giorgio Monestarolo:Ucraina, Europa, mond
Moreno Biagioni: Se vuoi la pace prepara la pace
Andrea Cozzo: La logica della guerra nella Grecia antica

Qui una recensione di Giovanni Di Benedetto








































