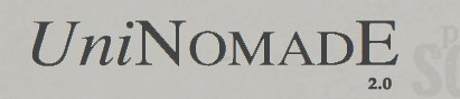
Il mito dello sciopero generale
di Collettivo Uninomade
 Che cosa significa sciopero generale oggi? Questo è il problema. Susanna Camusso sembra avere le idee piuttosto chiare. Al momento del suo insediamento ha subito generosamente messo in guardia i suoi avversari, dentro e fuori la Cgil, dicendo in buona sostanza: voi poveri illusi fate una campagna per lo sciopero generale, ma il sindacato ne ha fatti più di uno negli ultimi anni, non vi rendete conto che non servono a nulla? Non è stata ascoltata, e tutti possono ora vedere come è andata a finire. L’intelligente mastino della Cgil ha così messo nell’angolo la Fiom, riaffermando la piena sovranità della segreteria e del suo ruolo politico, non negando ma convocando lo sciopero generale: a distanza di sicurezza dall’autunno di lotte, di sole quattro ore e con manifestazioni territoriali. Per rendere più chiara la resa, la Fiom ha accettato – proprio alla vigilia dello striminzito 6 maggio – il diktat di Marchionne alla Bertone: solo la consumata spregiudicatezza di un abile sindacalista può presentare come “genialità operaia” quella che è un’evidente sconfitta, ripetendo gli stessi argomenti con cui la segretaria della Cgil invitava a votare sì anche a Mirafiori. La mossa del cavallo rischia di essere, in realtà, uno scacco matto.
Che cosa significa sciopero generale oggi? Questo è il problema. Susanna Camusso sembra avere le idee piuttosto chiare. Al momento del suo insediamento ha subito generosamente messo in guardia i suoi avversari, dentro e fuori la Cgil, dicendo in buona sostanza: voi poveri illusi fate una campagna per lo sciopero generale, ma il sindacato ne ha fatti più di uno negli ultimi anni, non vi rendete conto che non servono a nulla? Non è stata ascoltata, e tutti possono ora vedere come è andata a finire. L’intelligente mastino della Cgil ha così messo nell’angolo la Fiom, riaffermando la piena sovranità della segreteria e del suo ruolo politico, non negando ma convocando lo sciopero generale: a distanza di sicurezza dall’autunno di lotte, di sole quattro ore e con manifestazioni territoriali. Per rendere più chiara la resa, la Fiom ha accettato – proprio alla vigilia dello striminzito 6 maggio – il diktat di Marchionne alla Bertone: solo la consumata spregiudicatezza di un abile sindacalista può presentare come “genialità operaia” quella che è un’evidente sconfitta, ripetendo gli stessi argomenti con cui la segretaria della Cgil invitava a votare sì anche a Mirafiori. La mossa del cavallo rischia di essere, in realtà, uno scacco matto.
Ma il punto, per noi, non è fare le pulci ai conflitti intestini al sindacato, ma rimettere a tema il rapporto tra movimento e sindacato a partire dalle lotte.
Chi ha pensato di risolvere la seconda questione facendosi assorbire nella prima, rinunciando dunque al proprio punto di vista e al proprio discorso, ha evidentemente sbagliato. Da qualche anno Uninomade ha tentato di mettere la questione all’ordine del giorno, costruendo anche un dialogo con le componenti più disponibili della Fiom a partire però da un nitido presupposto: la tradizionale forma-sindacato è definitivamente in crisi, solo aprendo le proprie strutture all’utilizzo autonomo dei movimenti si può ripensare il suo ruolo. Non si tratta di una questione meramente speculativa, ma immediatamente politica. Si è innervata, ad esempio, del pragmatismo del movimento dell’Onda nel 2008 e delle sue, infine mancate, possibilità di generalizzazione sociale e politica. Portare gli studenti nelle fabbriche e gli operai nelle università, certo, ma soprattutto gli uni e gli altri dentro un processo di soggettivazione che si sviluppa non nella riedizione della loro mitica unità, bensì nella metropoli produttiva: questo era ed è il punto. È, se si vuole dirla con altre parole, un problema di composizione comune di differenti figure del lavoro vivo, non di alleanza tra le sue rappresentanze. Gli esempi – ancorché parziali – non mancano, se solo si mette il naso fuori dalla provincia italiana: si pensi all’esperienza di Justice for Janitors e all’uso delle strutture del Seiu, il più grosso settore sindacale negli Stati Uniti, da parte delle lotte e dei processi di autorganizzazione dei lavoratori latinos, oppure all’utilizzo che i precari dell’università hanno fatto dello United Auto Workers o di Unite-Here. Alcune union americane, spesso tradizionalmente corrotte e nazionaliste, tra tensioni e contraddizioni permanenti, ci sono evidentemente arrivate non per lungimiranza, ma per necessità, di fronte al rischio di una lenta morte.
O, ancora, si pensi al movimento rivoluzionario in Tunisia, che ha saputo coniugare organizzazione in rete e pragmatico utilizzo delle strutture di base dell’Ugtt, il sindacato unico del regime di Ben Ali. Nel Maghreb, il precariato cognitivo ha diretto le lotte verso l’insurrezione, mostrando, tra l’altro, come fossero almeno intempestive le cattive profezie, che circolano su quest’altra sponda mediterranea, sull’esaurimento di ogni sua forza di soggettivazione, di liberazione. Le interpretazioni pessimistiche e “luttuose” della crisi continuano ad essere spiazzate dagli eventi, che al contrario mostrano una forza conflittuale del lavoro vivo: ciò però richiede capacità di invenzione organizzativa, ben oltre l’elaborazione di alleanze meramente difensivistiche.
La Camusso, più saggiamente, si è guardata bene dal dar per morto il precariato cognitivo e, consapevole di non poterlo rappresentare, ha provato a cooptarlo, utilizzando la giornata del 9 aprile per spostare il terreno di scontro con la Fiom, rappresentandolo come un conflitto non tra destra e sinistra sindacale, ma tra innovazione e conservazione. Toccherebbe ora all’autonomia dei movimenti il compito politico di evitare che la potenziale forza del precariato cognitivo – e la critica alla forma sindacato che ne discende – siano messe al servizio della governance sindacale. A scanso di equivoci: parlare di autonomia dei movimenti e forza del precariato cognitivo non significa crogiolarsi in sciocche retoriche autocelebrative, di cui purtroppo gli esempi abbondano, né lamentarsi di un supposto tradimento delle rappresentanze con cui si è discutibilmente scelto di allearsi. I punti di limite e di blocco dei movimenti sono interni alle carenze di risposte organizzative post-rappresentative e alle difficoltà di sedimentarle in un orizzonte programmatico.
I percorsi di lotta, allora, possono costruire autonomia solo se sapranno sperimentare un equivalente funzionale allo sciopero, un’arma con cui bloccare la produzione e far male ai padroni. Non può esserci nessuna autentica generalizzazione dello sciopero se non c’è trasmissione concreta e reale di conflittualità, risonanza di capacità di lotta, pur dentro gli eterogenei spazi e tempi in cui opera il lavoro vivo oggi. É un processo da praticare entro la conflittualità viva e presente dei luoghi e dei tempi dello sfruttamento, la cui forma organizzativa procede necessariamente a salti e a sbalzi, ma la cui logica è esattamente il contrario della logica dell’Evento, tutta incentrata sulla proclamazione di una “data”. Un Evento astratto dal processo non produce nessuna effettiva generalizzazione, proliferazione del conflitto dentro la produzione, ma semmai una “trascendentale” universalizzazione dello sciopero: che allora diventa faccenda buona per l’opinione pubblica, per gli pseudoconflitti inscenati dai fantasmi della società civile, tutto, insomma, fuorché dispositivo di ricomposizione di una soggettività politica reale del lavoro vivo. I due mesi intercorsi tra la convocazione e la sua attuazione sono stati, in realtà, un percorso di sganciamento dello sciopero presunto generale dai conflitti del lavoro vivo: l’annullamento degli scioperi di categoria, per esempio, conferma in modo evidente come lo sciopero generale sia stato giocato dalla Camusso come strumento di normalizzazione e pacificazione. Non vi è dubbio che lo scorso 30 novembre, con le occupazioni di strade, autostrade e stazioni, il movimento di studenti e precari abbia fatto più male, mentre il 14 dicembre ha segnato uno spartiacque sulla possibilità di controllare una potenziale insorgenza precaria. Si pensi poi agli insegnamenti che ci vengono dall’autunno francese, con la sua capacità di fare della circolazione lo spazio di organizzazione moltitudinaria delle lotte sul piano metropolitano. Da qui nasce l’intuizione dello sciopero precario, un’idea di sciopero che capovolge i criteri fino ad oggi usati e “abusati” nel termine “sciopero”. Torniamo alla domanda iniziale: che cosa significa sciopero oggi? In primo luogo significa organizzare le istanze di conflitto che segnano il rapporto di lavoro oggi: in una parola la condizione precaria, condizione paradigmatica, nella diversità delle soggettività di vita e lavoro. Da qui occorre partire: ridefinire lo sciopero come momento di sabotaggio e di ricomposizione, non per un giorno, ma in un divenire continuo di azione e rivendicazione. Al riguardo, non abbiamo risposte definitive al problema, se non alcuni frammenti, ma sicuramente le lotte e le pratiche di movimento a livello transnazionale ci offrono delle straordinarie piste di inchiesta militante.
Sia chiaro, le compagne e i compagni che in varie città si sono impegnati per generalizzare lo sciopero, con pratiche eccedenti i recinti pensati da chi l’ha convocato, hanno evidentemente fatto benissimo. Il problema è un altro: combattere l’idea di uno sciopero “universale”, che altro non è oggi se non uno dei meccanismi della governance contemporanea, attraverso cui la temporalità del conflitto viene cioè dilazionata e neutralizzata. All’opposto, il punto è costruire programma comune dentro la temporalità delle lotte, dei nodi irrisolti e dei problemi aperti.
Immaginare nuove forme di sciopero, o per dirla in altri termini: in una composizione sociale costitutivamente mobile ed eterogenea, occorre pensare le forme di lotta, gli equivalenti dello sciopero, non come espressione di soggettività già date, ma come strumenti di produzione di soggettività. Come si traducono, perciò, dentro una composizione comune le espressioni e le istanze di singolarità delle nuove figure del lavoro vivo? Come si determinano le lotte e la vertenzialità collettiva nell’esplosione della forma-salario e nella produzione biopolitica? Come il diritto alla bancarotta per i precari diventa forma di riappropriazione collettiva della ricchezza sociale, del reddito e costruzione di nuovo welfare? Come trasformare le mobilitazioni per i beni comuni, cioè sul pubblico, in organizzazione del comune? E poi: come aprire le strutture del sindacato ai processi costituenti e al consolidamento di istituzioni autonome? Con questo sguardo, lungo e situato, dobbiamo guardare in avanti, per ripensare il rapporto tra lotte e crisi.































Add comment