Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 166
Fuori l'Italia dalla guerra!
di Francesco Cappello
Teheran ha avvertito che un utilizzo delle basi statunitensi sul nostro territorio sarebbe considerato un atto di guerra
 Il nostro è un territorio funestato dalla presenza militare statunitense (vedi nota [1]). Gli USA fanno di noi ciò che vogliono.
Il nostro è un territorio funestato dalla presenza militare statunitense (vedi nota [1]). Gli USA fanno di noi ciò che vogliono.
Gli iraniani difendendosi dall’attacco terroristico che stanno subendo hanno reagito distruggendo basi e porti militari in tutte quelle monarchie familiari arabe affiliate agli Stati Uniti utilizzate quale base di lancio verso il territorio iraniano.
Gli USA, in misure proporzionale alla distruzione di quelle infrastrutture militari, indietreggeranno ritirandosi presso i paesi del Mediterraneo come il nostro, la Grecia e gli altri. Abbiamo visto come gli iraniani siano riusciti a prendere di mira con successo gli inglesi a Cipro.
Noi dovremmo tirarci fuori dalla guerra e invece ci stiamo facendo coinvolgere sempre più pericolosamente.
L’Italia verso un decreto aiuti, l’ipotesi di sistemi anti droni e Samp/T al Golfo
L’Italia si prepara purtroppo a fornire supporto militare ai Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani. Il nostro solerte ministro della Guerra, Guido Crosetto, ha annunciato un pacchetto di aiuti – dispositivi anti-drone e possibilmente il sistema terra-aria Samp/T – da varare con un decreto legge in coordinamento con i partner europei, su richiesta di Emirati Arabi Uniti e Kuwait.
Resta inoltre aperto il nodo cruciale delle basi italiane per eventuali azioni offensive americane contro l’Iran. Non a caso il ministro degli esteri Tajani ha tenuto a ribadire rivolto all’Iran che il supporto delle basi sul territorio italiano è solo di natura logistica e non cinetica come vorrebbe la richiesta americana e come moltissimi elementi fanno già sospettare che sia.
Sappiamo qual è stata la reazione spagnola a questa stessa richiesta e la relativa reazione di Trump. Teheran ha avvertito che un utilizzo delle basi statunitensi sul nostro territorio sarebbe considerato un atto di guerra!
- Details
- Hits: 182
Il mosaico della morte per mille tagli
di Pepe Escobar – Strategic Culture Foundation
Si tratta di una guerra di logoramento strutturata e la sceneggiatura è stata scritta a Teheran
 La difesa decentralizzata a mosaico dell’Iran – la denominazione ufficiale – continua a essere modificata 24 ore su 24, 7 giorni su 7: questa è la strategia a lungo termine dell’IRGC, che consiste nel provocare la morte per mille tagli, con l’obiettivo di dissanguare l’Impero del Caos.
La difesa decentralizzata a mosaico dell’Iran – la denominazione ufficiale – continua a essere modificata 24 ore su 24, 7 giorni su 7: questa è la strategia a lungo termine dell’IRGC, che consiste nel provocare la morte per mille tagli, con l’obiettivo di dissanguare l’Impero del Caos.
Esaminiamo i canali interconnessi che permeano la palude incostituzionale, impossibile da conquistare e strategicamente catastrofica, costruita dall’Impero del Caos.
La resilienza mosaica dell’Iran e la sua strategia a lungo termine. La tentazione per quell’orrendo culto della morte in Asia occidentale di passare al nucleare, l’inesorabile avvicinarsi dell’inferno degli intercettori, la spinta incessante della Cina ad abbandonare il vecchio ordine (accumulando oro, scaricando dollari), i progressi dei BRICS nella creazione di un sistema finanziario parallelo, il crollo dei vassalli americani a diverse latitudini; tutto ciò sta accelerando un radicale riassetto del sistema.
E poi c’è Vladimir Putin che, con disinvoltura, quasi come un ripensamento, annuncia che alla fine potrebbe non esserci gas russo da vendere all’UE:
“Forse avrebbe più senso per noi smettere di fornire gas all’UE e spostarci verso quei nuovi mercati, affermandoci lì (…) Ribadisco: non c’è alcun motivo politico in questo. Ma se comunque tra un mese o due ci chiuderanno il mercato, forse è meglio andarsene ora e concentrarsi su paesi che sono partner affidabili. Detto questo, non si tratta di una decisione. Sto solo pensando ad alta voce. Chiederò al governo di esaminare la questione insieme alle nostre aziende”.
Il pietoso Cancelliere Bratwurst ha chiesto il permesso al neo-Caligola affinché la Germania potesse acquistare petrolio russo; lo ha ottenuto, ma potrebbe non essercene in vendita. Questa è una guerra energetica, e l’UE ancora una volta non è nemmeno all’altezza di un mendicante senzatetto. Niente gas dal Qatar, niente petrolio e gas dalla Russi; ora tornate alla vostra guerra infinita, l’ossessione della NATO.
- Details
- Hits: 269
Il sistema internazionale e la guerra
di Tiberio Graziani
 Norme, potere e transizione geopolitica
Norme, potere e transizione geopolitica
L’articolo propone una distinzione tra sistema internazionale e ordine geopolitico per interpretare la crisi attuale delle relazioni internazionali. La guerra in Ucraina viene letta non come una rottura improvvisa dell’ordine liberale, ma come l’esito di una progressiva erosione della credibilità normativa durante la fase unipolare. La politicizzazione selettiva del diritto internazionale ha indebolito la funzione regolativa del sistema, rendendo strutturale il disallineamento tra norme e distribuzione della potenza. La transizione in corso solleva quindi un interrogativo più profondo: è possibile ricostruire un principio di legittimità condiviso in assenza di egemonia?
Sistema internazionale e ordine geopolitico
Per affrontare questo tema è necessario chiarire una distinzione concettuale fondamentale: quella tra sistema internazionale e ordine geopolitico.
Con il sintagma sistema internazionale ci riferiamo all’insieme di regole, norme, istituzioni e principi che organizzano formalmente le relazioni tra gli Stati. Si tratta di una dimensione prevalentemente normativa e istituzionale, che comprende concetti come la sovranità statale, il diritto internazionale e le organizzazioni multilaterali, a partire dalle Nazioni Unite. Il sistema internazionale fornisce quindi il quadro di legittimità entro cui gli attori dovrebbero agire, almeno nelle fasi in cui il sistema mantiene una capacità regolativa effettiva che dipende a sua volta dalle configurazioni dell’ordine geopolitico entro cui opera.
L’ordine geopolitico, invece, riguarda la distribuzione concreta della potenza: chi possiede capacità militari ed economiche decisive, chi esercita influenza, chi costruisce alleanze e chi è in grado di imporre vincoli agli altri attori. Qui il principio regolatore non è la norma, ma l’equilibrio di potenza.
- Details
- Hits: 514
Guerra e bugie sorelle gemelle
Board of peace (war) per tutti
di Fulvio Grimaldi

In guerra la verità è così preziosa che deve sempre essere difesa da una vigilanza di bugie (Winston Churchill)
Far fuori l’Iran, costi quel che costi
Al momento in cui scrivo è partito l’attacco. A trazione israeliana, con gli USA a rinforzo, ma politicamente costretti a reggere il moccolo. E’ partito proprio quando pareva che Tehran stesse rispettando l’estrema linea rossa fissata da Trump: la rinuncia al materiale da arricchire e la sua consegna all’estero. Il nodo decisivo stava nel tiro della corda tra, a un capo, Netanyahu e la sua cosca internazionale e, all’altro, Trump e la realtà MAGA, confortata da alti comandi di Pentagono e Servizi, sorretta dal voto di chi voleva dal nuovo presidente lavoro, non guerre. E’ prevalso il ricatto di Netaniahu.
Questo tiro della corda è metaforicamente rappresentata dal genocida di Tel Aviv, con i suoi 800.000 squadristi delle colonie e una buona parte di popolazione intossicata di odio anti-arabo dal momento in cui hanno guadagnato la facoltà di udire, che dice: “O mi fai fuori l’Iran (mica solo gli Ayatollah), o tiro fuori foto e carte di Epstein. E saresti fottuto”. Con l’altro che risponde: ”Ti riconosco la Cisgiordania giudaizzata, ci piazzo subito un consolato, ti ridò Gaza ripulita e kushnerizzata, ma risparmiami l’Iran. Quella è un’altra guerra che non vinceremo e allora addio Trump e ti perdi quello che dicevi fosse il migliore amico di Israele”.
Non è bastato. Ha prevalso la demenza criminale necrofaga di Netaniahu, della sua cricca dirigente, sostenuta da una parte non indifferente della popolazione. Del resto qualsiasi concessione Tehran avesse fatta, fino alla chiusura delle centrali di ricerca nucleare e allo smantellamento dell’armamento missilistico, non sarebbe bastata allo Stato sionista. L’obiettivo è sempre stato chiaro e irrinunciabile: via dal Medioriente, dopo Iraq, Siria, Libano, Palestina, la Repubblica Islamica, 90 milioni di abitanti, la seconda potenza petrolifera del mondo, 1.648 milioni di chilometri quadrati, una popolazione che, alla faccia delle rivoluzioni colorate, vanta una fortissima coesione in difesa della nazione.
- Details
- Hits: 551
Guerra digitale – Lezioni dall’Ucraina
Innovazione, l’arte della guerra e i nuovi equilibri geopolitici
di Corrado Cirio
Parte 1.Simmetria e balzi tecnologici
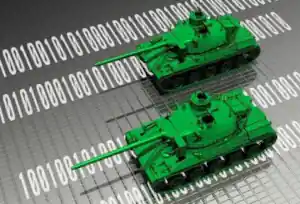 L’Ucraina 2022/2025: laboratorio globale
L’Ucraina 2022/2025: laboratorio globale
La guerra Russia/NATO via Ucraina costituirà nel prossimo futuro uno dei punti di svolta cruciali nella storia militare, che verrà analizzato da studiosi di ogni disciplina collegata alla guerra.
Lo scontro armato tra contendenti simmetrici diventa il luogo di massima accelerazione dello sviluppo tecnologico, perché impone adeguamenti in tempo reale, sperimentazioni in condizioni limite, confronto con soluzioni alternative, sotto la spinta di un’urgenza senza precedenti. È anche il luogo di massimo sviluppo della ricerca scientifica, grazie alla disponibilità di risorse straordinarie e alla forzata cancellazione di vincoli e procedure.
Sul campo di battaglia si confrontano le capacità globali dei contendenti, intesi come sistemi sociopolitici, produttivi e diplomatici. Nell’ordine: il morale e la volontà dei combattenti, l’adesione alle motivazioni, il senso di appartenenza e il consenso sociale derivano direttamente dalla situazione sociopolitica; la disponibilità di mezzi materiali, sia quantitativa sia qualitativa, dipende dalla struttura produttiva (ivi comprendendo la ricerca scientifica e tecnologica); il quadro strategico globale, con il mantenimento o la perdita di asset commerciali, economici, relazionali e reputazionali, dipende dalla situazione diplomatica.
Durante i primi tre anni di guerra in Ucraina la battaglia sul campo ha completamente cambiato le regole dello scontro bellico, introducendo via via nuove armi e sviluppando conseguentemente le modifiche necessarie alle modalità di combattimento. Iniziata con strumenti e dottrine trasferite quasi integralmente dal secolo scorso, oggi la guerra in Ucraina rappresenta una realtà profondamente diversa.
Talmente diversa, a nostro parere, da imporre non soltanto un ripensamento delle tattiche e delle strategie militari, ma anche la presa d’atto di cambiamenti geopolitici globali.
- Details
- Hits: 734
E’ tempo di liberarci dei liberatori
di Gianandrea Gaiani
 L’attacco all’Iran mentre erano in corso trattative e che mette nel mirino le figure chiave del governo iraniano, non contiene particolari novità rispetto a quanto già sapevamo dell’approccio di Stati Uniti e Israele nei confronti di Teheran.
L’attacco all’Iran mentre erano in corso trattative e che mette nel mirino le figure chiave del governo iraniano, non contiene particolari novità rispetto a quanto già sapevamo dell’approccio di Stati Uniti e Israele nei confronti di Teheran.
Non deve stupire che Stati Uniti e Israele decidano arbitrariamente di usare la forza contro chiunque considerino loro nemico in tutto il mondo e lo fanno mentendo circa il programma nucleare iraniano che nessuno considerava prossimo allo sviluppo di armi atomiche.
In fondo l’hanno sempre fatto con attacchi incursioni mirate, attacchi “preventivi” e persino rapimenti di capi di stato come nel caso venezuelano; azioni che se venissero compiute da altri non esiteremmo a definire terroristiche.
Lo fanno destabilizzando intere aree del mondo, di solito quelle ad alto valore energetico, senza avvisare preventivamente gli alleati né consultarsi con loro. Il vicepremier italiano Matteo Salvini ha rivelato ieri che il governo italiano è stato informato dell’avvio delle operazioni militari dopo che queste erano cominciate. Quando Roma lo aveva già saputo dalle breaking-news televisive e dalle agenzie di stampa.
La vicenda del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a quanto pare con la famiglia a Dubai, su cui molti hanno ironizzato, dimostra in realtà che il Pentagono non ha informato i colleghi della NATO dell’imminente attacco a ulteriore conferma che Stati Uniti e Israele applicano da sempre un principio di superiorità sul resto del mondo basato sulla loro “eccezionalità”. Di fatto “io sono io e voi non siete un c….” per dirla con la Marchese del Grillo.
Nulla di sorprendente se si considera l’arroganza che riserva agli europei l’Amministrazione Trump e soprattutto che i nostri “alleati” d’oltreoceano, ben prima di Donald Trump, si comportano da molti anni da nostri acerrimi nemici.
- Details
- Hits: 747
La guerra all’Iran
di Scott Ritter - forumgeopolitica.com
L'amministrazione Trump parla il linguaggio della diplomazia mentre si prepara a una guerra contro l'Iran che, se attuata, segnerà la fine dell'esperimento democratico americano
 L’Iran e gli Stati Uniti stanno prendendo una pausa di due settimane dai negoziati sul programma nucleare iraniano, mentre i negoziatori tornano nelle rispettive capitali per riflettere su ciò che è stato messo sul tavolo fino a oggi. La parte iraniana è apparsa piuttosto ottimista, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che ha dichiarato ai media iraniani: “Siamo riusciti a raggiungere un accordo generale su una serie di principi guida, sulla base dei quali procederemo d’ora in poi, e ci muoveremo verso la stesura di un potenziale accordo”.
L’Iran e gli Stati Uniti stanno prendendo una pausa di due settimane dai negoziati sul programma nucleare iraniano, mentre i negoziatori tornano nelle rispettive capitali per riflettere su ciò che è stato messo sul tavolo fino a oggi. La parte iraniana è apparsa piuttosto ottimista, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che ha dichiarato ai media iraniani: “Siamo riusciti a raggiungere un accordo generale su una serie di principi guida, sulla base dei quali procederemo d’ora in poi, e ci muoveremo verso la stesura di un potenziale accordo”.
Più eloquenti sono stati i commenti del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. “Per certi versi è andata bene”, ha dichiarato Vance a un media statunitense al termine dei colloqui martedì. “Ma per altri versi è stato molto chiaro che il presidente ha fissato alcune linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere e a superare. Quindi continueremo a lavorarci”.
La domanda chiave che emerge da questo scambio è cosa intenda esattamente il vicepresidente Vance quando parla di “lavorarci”.
A un certo punto la comunità analitica globale dovrà fare i conti con la dura realtà che, dal punto di vista degli Stati Uniti, la diplomazia non è un’opzione. La politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran non è quella di trovare una via diplomatica verso una soluzione di compromesso che consenta all’Iran di arricchire l’uranio come è suo diritto ai sensi dell’articolo 4 del trattato di non proliferazione nucleare, ma piuttosto quella di un cambio di regime a Teheran.
Ciò significa che gli Stati Uniti sono sulla strada di una guerra con l’Iran che scoppierà prima piuttosto che poi.
Col senno di poi, l’inevitabilità di questa guerra è evidente da mesi, da quando l’amministrazione Trump ha orchestrato eventi all’interno dell’Iran che logicamente potrebbero essere interpretati come un modo per facilitare il rovesciamento del governo della Repubblica Islamica dell’Iran.
- Details
- Hits: 965
Perché l’America molla gli alleati? Le rivelazioni scioccanti del think tank
Non è finita qui!
di OttolinaTV

È fallito: il Pivot to Asia, la grande strategia americana per contenere la Cina, non esiste più; non perché Washington abbia cambiato idea, ma perché non ha più i mezzi per realizzarla. Questo, in sostanza, è il cuore dell’analisi del ricercatore Zack Cooper pubblicata su Foreign Affairs – che, come sai, non è un pamphlet militante, ma il luogo dove Generali, consiglieri di sicurezza nazionale e think tank espongono al mondo la dottrina imperiale: se lì si scrive che la strategia asiatica americana è irrealizzabile, significa che il problema è davvero strutturale. Ma veniamo all’articolo: il Pivot nasce formalmente nel novembre 2011, quando Barack Obama parla al Parlamento australiano e annuncia che gli Stati Uniti sposteranno il baricentro strategico verso l’Asia-Pacifico. La dottrina era semplice: la crescita della Cina rappresenta la principale sfida sistemica al potere americano e, quindi, bisogna investire nella regione che concentra la maggior parte del PIL mondiale, delle rotte commerciali e delle catene industriali. Il piano prevedeva tre pilastri operativi; il primo era, ovviamente, militare: spostare il 60% della flotta americana nell’Indo-Pacifico, rafforzare le alleanze con Giappone, Corea del Sud, Australia e Filippine e aumentare la presenza di basi e pattugliamenti. Il secondo era economico: creare un blocco commerciale guidato da Washington, il Trans-Pacific Partnership, per scrivere le regole del commercio asiatico escludendo Pechino. Il terzo era politico-istituzionale: promuovere governance liberale, anticorruzione e standard democratici per rendere gli Stati regionali più compatibili con l’ordine americano. Cooper, nell’articolo, sostiene che questi tre pilastri avrebbero dovuto funzionare insieme: economia forte, governi stabili e capacità militari locali avrebbero impedito alla Cina di costruire una sfera d’influenza regionale; il problema è che due di questi pilastri non sono mai stati costruiti – provate a indovinare quali.
Il Trans-Pacific Partnership è il primo esempio concreto del fallimento economico: firmato, nel 2016, con dodici Paesi, tra cui Giappone, Vietnam, Malesia e Australia, avrebbe creato una zona di libero scambio che rappresentava circa il 40% del PIL mondiale; il Congresso americano, però, non lo ha mai ratificato.
- Details
- Hits: 591
Marco Rubio a Monaco: il ritorno del suprematismo civilizzazionale
di Alessandro Visalli
 Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il 14 febbraio 2026, il Segretario di Stato Americano, Marco Rubio, ha pronunciato un atteso discorso[1] nel quale ha invitato i leader europei ad unirsi agli USA nella difesa della civiltà occidentale. E proprio di quella civiltà che dal XV secolo in poi, per cinquecento anni, ha di fatto oppresso, schiavizzato, barbaramente trucidato, oscurato e calpestato millenarie civiltà colpevoli di essere solo troppo deboli.
Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il 14 febbraio 2026, il Segretario di Stato Americano, Marco Rubio, ha pronunciato un atteso discorso[1] nel quale ha invitato i leader europei ad unirsi agli USA nella difesa della civiltà occidentale. E proprio di quella civiltà che dal XV secolo in poi, per cinquecento anni, ha di fatto oppresso, schiavizzato, barbaramente trucidato, oscurato e calpestato millenarie civiltà colpevoli di essere solo troppo deboli.
Oggi, al primo quarto del sesto secolo, quando troppo debole il resto del mondo non è più, Rubio, come un novello conquistador, invita ad unirsi sotto lo stendardo della ‘civiltà’ per rinnovarne i fasti.
Un anno fa anche il vicepresidente Vance pronunciò nella stessa occasione un vibrante discorso[2] nel quale, tuttavia, spostava con vigore il tema dalla sicurezza esterna a quella dei valori. In quella occasione disse apertamente che l’Amministrazione era impegnata e credeva di poter “raggiungere un ragionevole accordo tra Russia e Ucraina” e che lo preoccupava, casomai, “la ritirata dell’Europa da alcuni dei suoi valori fondamentali”. In particolare, dalla democrazia (l’Unione si era appena vantata del fatto che il governo rumeno avesse annullato un’elezione non gradita), tramite il controllo dei social, le restrizioni alla libertà di espressione, di opinione (nella fattispecie contro l’aborto). Uno dei passaggi più forti, echeggiante un apocrifo Voltaire fu “a Washington c’è un nuovo sceriffo in città e sotto la guida di Donald Trump potremmo non essere d’accordo con le vostre opinioni, ma combatteremo per difendere il vostro diritto di esprimerle nella piazza pubblica, che siate d’accordo o meno.” Insomma, Vance si travestiva da più puro e coerente liberale, di fronte al totalitarismo europeo.
Ora, invece, l’amministrazione americana ha mandato un funzionario di livello meno alto, il Segretario di Stato, ma, soprattutto, lo ha mandato a dire una cosa del tutto diversa: mentre Vance parlava di democrazia e di pace, Rubio parla di scontro e di espansione.
- Details
- Hits: 492
A Monaco gli Stati Uniti snobbano l’Europa in delirio bellicista
di Gianandrea Gaiani
 Più slogan che contenuti, più propaganda che politica, più bugie che concreto realismo. La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco non si è differenziata molto dei summit degli ultimi anni mettendo in luce ancora una volta la profonda inadeguatezza di molti leader europei rispetto alle sfide che devono affrontare.
Più slogan che contenuti, più propaganda che politica, più bugie che concreto realismo. La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco non si è differenziata molto dei summit degli ultimi anni mettendo in luce ancora una volta la profonda inadeguatezza di molti leader europei rispetto alle sfide che devono affrontare.
Quanto peso attribuissero gli Stati Uniti agli “alleati” europei era del resto già evidente prima dell’inizio della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, quando solo il segretario di Stato aveva annunciato la sua presenza mentre il vice-presidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Pete Hegseth hanno rinunciato a partecipare e quest’ultimo non si è visto neppure al summit dei ministri della Difesa della NATO pochi giorni prima della conferenza.
Benché con toni pacati rispetto al ruvido intervento contro i leader europei di cui si rese protagonista J.D. Vance nell’edizione de 2025, Marco Rubio ha affermato che USA ed Europa hanno un destino comune, precisando però tra le righe che tale destino viene deciso a Washington.
Come ha evidenziato il generale Maurizio Boni, che da Monaco ha seguito la conferenza per Analisi Difesa, dietro le parole rassicuranti, Rubio ha ribadito le posizioni di fondo dell’amministrazione Trump secondo la quale le Nazioni Unite non hanno giocato nessun ruolo nella risoluzione dei conflitti; l’ordine internazionale basato su regole ha portato a “migrazioni di massa che destabilizzano i paesi occidentali”; le istituzioni globali devono essere “riformate e ricostruite”.
Nelle parole iniziali del suo intervento “siamo preoccupati per l’Europa”, e nel suo successivo sviluppo, ritroviamo i contenuti (e il linguaggio) della strategia di sicurezza nazionale divulgata nel dicembre dello scorso anno. In altre parole, l’America vuole un’Europa forte, ma nella quale una delle priorità degli Stati Uniti è quella di “sviluppare l’opposizione all’attuale traiettoria europea all’interno delle nazioni europee”, intendendo il sostegno a movimenti o partiti europei contrari alle attuali politiche dell’UE.
- Details
- Hits: 935
L’America dichiara la III guerra mondiale
di Enrico Tomaselli
 Un po’ come fu, per altri versi, la Conferenza di Monaco del 1938, così la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco 2026 potrebbe essere il preludio della terza guerra mondiale. Il discorso tenuto da Marco Rubio – non a caso lui, vero deus ex machina della politica estera statunitense – è infatti, né più né meno, che una dichiarazione di guerra da parte dell’impero americano al resto del mondo. Anche se è stato pronunciato con toni assai più melliflui, rispetto a quelli usati da J.D. Vance lo scorso anno, il contenuto del suo discorso è di estrema violenza; e se Vance era venuto a rimbrottare gli europei, ingiustamente (ma non del tutto) accusati di essere un peso morto per gli Stati Uniti, Rubio è venuto a lanciare una duplice sfida: agli europei, cui sostanzialmente ha detto che o scelgono di stare con Washington nella sua crociata o saranno contro, e a tutto il mondo non occidentale, al quale dice che ridisegneranno l’intero ordine globale – ovviamente a propria misura e a proprio piacere – e che sarà così, piaccia o non piaccia.
Un po’ come fu, per altri versi, la Conferenza di Monaco del 1938, così la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco 2026 potrebbe essere il preludio della terza guerra mondiale. Il discorso tenuto da Marco Rubio – non a caso lui, vero deus ex machina della politica estera statunitense – è infatti, né più né meno, che una dichiarazione di guerra da parte dell’impero americano al resto del mondo. Anche se è stato pronunciato con toni assai più melliflui, rispetto a quelli usati da J.D. Vance lo scorso anno, il contenuto del suo discorso è di estrema violenza; e se Vance era venuto a rimbrottare gli europei, ingiustamente (ma non del tutto) accusati di essere un peso morto per gli Stati Uniti, Rubio è venuto a lanciare una duplice sfida: agli europei, cui sostanzialmente ha detto che o scelgono di stare con Washington nella sua crociata o saranno contro, e a tutto il mondo non occidentale, al quale dice che ridisegneranno l’intero ordine globale – ovviamente a propria misura e a proprio piacere – e che sarà così, piaccia o non piaccia.
In buona sostanza, Rubio ripropone l’idea del destino manifesto lanciata da O’Sullivan nel 1845, che in fondo è il substrato ideale su cui poi i neoconservatori costruiranno tutte le loro strategie per il dominio statunitense, e che il Segretario di Stato – forse l’esponente neocon più potente che mai – rimastica e risputa come un chewing gum, adattandolo alla fase contingente. Il solo effettivo elemento di novità, infatti, è in un certo senso il ribaltamento della posizione di Vance: dallo sprezzo verso gli europei alla rivendicazione di una presunta – se non del tutto inesistente – civiltà occidentale che accomunerebbe le due sponde dell’Atlantico. Il richiamo a una epopea colonizzatrice dell’occidente, chiaramente vista in un’ottica da conquista del west, si traduce in un tentativo di nobilitare le pretese egemoniche statunitensi, e di arruolare gli ascari europei facendo appello ad un passato falsamente comune.
E già questo, di per sé, è un modo per definire i termini della relazione immaginata a Washington tra l’occidente ed il resto del mondo.
- Details
- Hits: 721
Trump e il duro scontro interno al capitalismo
Luca Busca intervista Alessandro Volpi
 Alessandro Volpi, ex sindaco di Massa, docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, è reduce dall’ultima fatica letteraria, pubblicata nel 2025 con Laterza, dal titolo emblematico: “La guerra della Finanza – Trump e la fine del capitalismo globale”.
Alessandro Volpi, ex sindaco di Massa, docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, è reduce dall’ultima fatica letteraria, pubblicata nel 2025 con Laterza, dal titolo emblematico: “La guerra della Finanza – Trump e la fine del capitalismo globale”.
Il libro s’inserisce perfettamente in un quadro geopolitico che appare sempre più confuso, facendo luce su dinamiche che sembrano sconvolgere i canoni classici del neoliberismo. Abbiamo così chiesto “lumi” al professor Volpi.
* * * *
L.B. Con il secondo mandato di Donald Trump come è cambiata la comunicazione geopolitica e soprattutto cosa è cambiato “nel duro scontro interno al capitalismo contemporaneo ... in seguito all’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti”?
A.V. L’elezione di Trump ha segnato una forte tensione all’interno del capitalismo finanziario Usa, dominato da diversi anni dall’assoluta centralità dei grandi fondi di raccolta del risparmio gestito; le cosiddette Big Three, rappresentate da BlackRock, Vanguard e State Street, capaci di raccogliere quasi 50 mila miliardi di dollari di asset in giro per il mondo e di indirizzarli verso i principali titoli dello S&P 500, divenendo così le principali azioniste di vasti settori, dai colossi come Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta e Nvidia ad una sequenza di major dell’energia, delle armi, della grande distribuzione e del divertimento. L’arrivo di Trump ha comportato un almeno parziale indebolimento di questo monopolio perché il nuovo presidente aveva e ha una finanza decisamente più organica alle sue posizioni, da Musk, a Thiel, a Ellison, a Bessent e Lutnick, figure legate al mondo delle criptovalute, delle commesse statali, della finanza hedge e che lo stesso Trump ha addirittura inserito in posti chiave del suo governo.
- Details
- Hits: 417
Il crollo dell’ipocrisia internazionale
di Alessandro Scassellati
 Il problema con la concettualizzazione del Primo Ministro canadese Mark Carney sulla fine dell’’ordine internazionale basato sulle regole” è comune nelle capitali dei Paesi occidentali. La storia inizia quando vogliono le élite al potere, in questo caso, il secondo mandato di Donald Trump. Sono arrabbiate, disgustate e in preda all’ansia perché alcuni aspetti di ciò che è stato inflitto al Terzo Mondo, in azioni alle quali i loro Paesi hanno preso parte, ora vengono ribaltati e usati contro di loro. Estorsione, gangsterismo, coercizione economica e minacce alla sovranità territoriale vengono ora perpetrate contro gli Stati deboli e vulnerabili dell’alleanza occidentale. Gli stessi Stati che sono rimasti in silenzio o hanno partecipato quando a essere vittime erano Paesi distanti e “autoritari” che non condividevano i loro valori.
Il problema con la concettualizzazione del Primo Ministro canadese Mark Carney sulla fine dell’’ordine internazionale basato sulle regole” è comune nelle capitali dei Paesi occidentali. La storia inizia quando vogliono le élite al potere, in questo caso, il secondo mandato di Donald Trump. Sono arrabbiate, disgustate e in preda all’ansia perché alcuni aspetti di ciò che è stato inflitto al Terzo Mondo, in azioni alle quali i loro Paesi hanno preso parte, ora vengono ribaltati e usati contro di loro. Estorsione, gangsterismo, coercizione economica e minacce alla sovranità territoriale vengono ora perpetrate contro gli Stati deboli e vulnerabili dell’alleanza occidentale. Gli stessi Stati che sono rimasti in silenzio o hanno partecipato quando a essere vittime erano Paesi distanti e “autoritari” che non condividevano i loro valori.
* * * *
Il 20 gennaio 2025, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso al meeting annuale del World Economic Forum (WEF) a Davos. Immediatamente, un coro di elogi si è levato dai ”capitalisti progressisti” e dai media liberal-progressisti di tutto il mondo, sia del Nord che del Sud del mondo. Carney ha preso indirettamente di mira il Presidente Trump affermando che il mondo è “nel mezzo di una rottura, non di una transizione”, indicando che “gli egemoni non possono monetizzare continuamente le loro relazioni” e cercando di indicare una nuova direzione in cui “gli alleati si diversificheranno per proteggersi dall’incertezza… [perché] le medie potenze devono agire insieme, perché se non siamo al tavolo, siamo nel menu”. Carney ha esortato le “medie potenze” a smettere di conformarsi a regimi che cercano l’egemonia, a smettere di sperare in un ritorno al passato e a costruire invece nuove coalizioni per sopravvivere a ciò che verrà. A parte l’utopia del Primo Ministro Carney di un’uscita del Canada dal dominio e dalla sfera d’influenza statunitense, sono state presentate un paio di verità molto importanti.
- Details
- Hits: 700
Il mondo incantato delle menzogne: sempre quello
di Alberto Bradanini
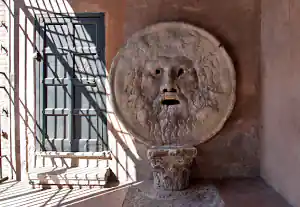 Le menzogne di regime sono come le zanzare d’estate in bassa Padania, ti aggrediscono da ogni lato: non se ne può più! Secondo la campana della verità nordamericana, che inizia all’alba e ci accompagna fino a notte fonda e il cui suono echeggia – ça va sans dire – in ogni contrada europea, le cose del mondo starebbero così:
Le menzogne di regime sono come le zanzare d’estate in bassa Padania, ti aggrediscono da ogni lato: non se ne può più! Secondo la campana della verità nordamericana, che inizia all’alba e ci accompagna fino a notte fonda e il cui suono echeggia – ça va sans dire – in ogni contrada europea, le cose del mondo starebbero così:
a) l’attuale presidente degli Stati Uniti è persona fine, avveduta, talora un po’ risoluto nei modi, ma nemico della guerra – insignito non a caso del Nobel per la Pace 2025 da tale Maria Corina Machado, invece che dal Comitato norvegese per il Nobel, ma questo dettaglio potrà essere corretto nell’anno di grazia 2026. Certo, si è visto costretto a bombardare sette od otto paesi solo nel suo primo anno di mandato, ma che volete, bisogna pur mettere ordine in un mondo altrimenti destinato alla deriva. Nei modi, poi, è persona gradevole, corretto con ogni interlocutore, di cui rispetta la libertà di scegliere la posizione del missionario o quella a novanta gradi. Il presidente è inoltre scrupoloso del diritto internazionale: mai minaccerebbe, che so, la Danimarca, il Venezuela, Cuba o Panama, men che meno l’Iran, la Cina o la Russia, solo perché non assecondano i suoi capricci e non s’inchinano al suo passaggio. Quanto ai paesi alleati, non si sognerebbe nemmeno lontanamente di imporre dazi pesanti o condizioni insostenibili, tipo il 5% del PIL in armi da comprare soprattutto negli USA. Mai e poi mai farebbe una cosa del genere. E beninteso rispetta pienamente la Costituzione del suo paese, anche se non proprio al 100%, come ad esempio ottenere il via libera del Congresso per fare la guerra e imporre dazi al resto del mondo. Ma, signori miei, nessuno è perfetto e poi l’urgenza impone di agire in fretta;
b) il presidente venezuelano Nicolás Maduro è affiliato al narcoterrorismo, crimine sinora ignoto alla civiltà giuridica del mondo ma non all’effervescenza giurisprudenziale dell’esimio inquilino della Casa cosiddetta Bianca. Del resto, chi potrebbe sorprendersi se per far soldi N. Maduro – fino al 3 gennaio scorso legittimo presidente di un paese che possiede le più ingenti riserve di petrolio del pianeta – invece di rotolarsi su milioni di barili di petrolio, preferisce vendere cocaina colombiana sul mercato statunitense?
- Details
- Hits: 562
Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO della multinazionale Mondo
di Fulvio Grimaldi
 Suicidi e pandemie
Suicidi e pandemie
C’è in giro una tendenza al suicidio. O, quanto meno, a martellopneumatizzarsi gli strumenti di conservazione della specie. Pensate agli europei che si tagliano il cordone ombelicale con il quale, unendosi alle salubri e risparmiose fonti di energia russe, si assicuravano decente sopravvivenza, per attaccarsi a una canna del gas frantumambiente americana che gli costa il quadruplo e li riduce ad accattoni.
Pensate ai 15 signori del mondo riuniti nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU che seppelliscono il famigerato “ordine fondato sulle regole” e votano (2 si astengono, ma non cambia niente, anzi agevola) per il Board of Peace che consente la nascita di un CEO (vulgo: Amministratore Delegato) del mondo, col suo Consiglio d’Amministrazione di domestici, mafiosi e sicari. 15 sciagurati sprovveduti che mandano in discarica l’organismo che avrebbe dovuto assicurare la pacifica e prospera convivenza delle nazioni umane. Ma che, in effetti, aveva smesso da tempo, finendo con l’essere gestito da tale grassotello lusitano, tirato via da un banco di bacalhau, che ha l’unico compito e merito di emettere guaiti contro la Russia.
E, se non siete già finiti in depressione, pensate come tutto questo sia servito a puntellare un diabetico claudicante creduto prima potenza mondiale, onerato da un debito che, se lo vogliamo vedere in dollari, va da qui alla prossima galassia (39 trilioni e 7 in più ogni minuto). Una superpotenza obesa in crisi d’astinenza di armi, con un apparato produttivo da Terzo Mondo e tra i piedi una pietra d’inciampo costituita dalla repulsione di quasi 7 miliardi di persone. Non è l’unica, ce n’è una addirittura in casa sua, in Minnesota, dove una resistenza civile fantastica la getta tra i piedi agli sgherri nazisti scagliatili addosso da Casa Bianca affollata da mentecatti. Uno Stato Maggiore mancato vincitore di tutte le guerre dal 1945 a oggi, ora finito in mano a un bambino bipolare di quasi 80 anni. Si chiama establishment USA e a quell’infante consente di proclamare da Davos che, d’ora in poi, sarà lui il CEO, e non più l’ONU, a determinare le cose e i flussi di denaro da siringare dal basso verso l’altissimo.
Page 1 of 70















































